
Foto di Fabio e Damiano D’Inncenzo, courtesy Artdigiland
di Ludovico Cantisani
La mostruosità del quotidiano fatta estetica. Una sterilità che affossa i protagonisti ma non l’immagine. Una fotografia che sa essere dissonante senza essere grezza. Una catabasi, quasi, in un quotidiano apparentemente indolore, sottotraccia feroce, sintomo di un’età della vaghezza, di un tempo che ha perso ogni archetipo e insegue nuovi idoli. Sin dalla sua presentazione al Festival del Cinema di Berlino, in un febbraio 2020 ignaro della pandemia imminente, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo si è imposto come “qualcosa di nuovo”. Salutato come “una boccata d’aria fresca nel cinema italiano”, originale lo è davvero, di un’originalità stratificata e densa che lo ha reso, molto più di altri film in concorso quest’anno al David, un’ottima radiografia del tempo presente e dello stato dell’arte nel panorama produttivo italiano. Da più parti si parla di capolavoro – lo stesso Goffredo Fofi ha scomodato questa parola, converrà credergli – ma forse più che imputare a Favolacce dei titoli bisognerebbe premurarsi a preservarne la seminalità.
Favolacce è un racconto di formazione incompiuto e paradossale, un conato di adolescenza destinato a non procedere. Una voce fuori campo dice di aver trovato il diario di una bambina, di averlo dapprima liquidato superficialmente come “non interessante” per poi leggerlo con un coinvolgimento sempre maggiore, fino al punto di inventarne una prosecuzione a partire dal momento in cui – non è dato sapere a quale passaggio del film esso corrisponda – le pagine del diario bruscamente si interrompono. Entriamo così in un microcosmo vivido e ancestrale, con una storia che prende l’avvio negli ultimi giorni prima dell’inizio delle vacanze estive, seguendo i differenti percorsi di un piccolo gruppo di bambini ormai sulla soglia dell’adolescenza, condannati a vivere un’estate stantia attorno alle loro case, tra piscine in plastica, epidemie di pidocchi o morbillo e feste di compleanno venute male. La tragedia è dietro l’angolo, così come la spensieratezza però. Un po’ orchi un po’ Peter Pan, un popolo di adulti irrisolti veste i panni dei genitori di questi bambini, ma sono ancora più immaturi di loro.
Favolacce è la coscienza di una lacerazione. Di uno sfasamento. E su più livelli. Alcuni di questi sfasamenti sono narrativamente classici, ma atipici per il cinema italiano e per il suo linguaggio tradizionale: il “narratore inaffidabile”, ad esempio. Lo sfasamento tra ciò che dice il narratore in voice over e ciò che l’immagine mostra o lascia presagire della realtà dei fatti è uno strumento narrativo che i fratelli D’Innocenzo usano a più riprese, e con un particolare senso del caustico. Il narratore, uomo adulto che legge il diario di una bambina, “incompiuto” come ogni diario, dice spesso cose in contrasto con le immagini che scorrono sullo schermo: un po’ perché è bambina, e quindi non coglie certe ipocrisie, o meglio delle volte preferisce restare a fantasticare; un po’ perché è un adulto, “annoiato dalla vita”, e quindi quasi si diverte ad abbattere gli animi e a smorzare ogni entusiasmo, a immaginare un finale a “questa storia insensata e amara e anche pessimistica”.
Una lacerazione ulteriore e più fine riguarda il rapporto tra forma e contenuto, il dialogo tra fotografia, suono e montaggio e soprattutto la costruzione dell’inquadratura. Il cinema che sussurra di essere autoriale si ritrova in una posizione snervante: da un lato deve virtualizzare il reale, i personaggi nella loro corporeità di attori, gli ambienti nella loro oggettualità di scenografia, il suono nella sua duplice valenza diegetica ed extradiegetica; dall’altro lato, deve dare forma all’informe, colorare le sensazioni, drammatizzare in una storia dei concetti che però sfuggono e rifuggono a una spiegazione, a una troppo precisa trattazione. Favolacce ha una costruzione dell’inquadratura al tempo stesso spontanea e complessa che, ignorando il più delle volte gli stilemi classici del campo e del controcampo, sembra strizzare l’occhio al modello di certo cinema europeo, Haneke e Lanthimosin primis.
Qualche eco di precedenti autori non toglie che Favolacce sia tutt’altro che riducibile a un mero citazionismo. Si coglie nelle inquadrature dei fratelli D’Innocenzo e di Carnera, soprattutto nei piani larghi, come una difficoltà, un’ulteriore crepa: un tentativo, irrealizzabile ma compiuto, di prendere le distanze da quanto racchiuso tra le linee di campo, alternato con inquadrature marcatamente più empatiche, meno inquisitive. Se il precedente La terra dell’abbastanza si giocava quasi tutto sulla macchina a mano, Favolacce ritrova anche una certa geometria e stabilità di fondo dell’immagine, ma è una stabilità compromessa fin dai primi minuti dal contenuto perturbante delle inquadrature, dalla presenza in esse di “veli” sia concreti che metaforici, dalla fotografia ora allucinata ora scarnificata di Paolo Carnera. Sembra cogliersi in Favolacce quella difficoltà, fisiologicamente registica, di fissare il divenire, di fissare quel movimento che del cinema è la base anche solo da un punto di vista etimologico, di imprimere su pellicola o, in questo caso, sul sensore digitale immagini di disagio, di inquietudine di dolore, alla fine anche di morte. È per questo che la sintassi cinematografica classica si sfilaccia, si lacera e poi si ritrova, per poi perdersi di nuovo e irrimediabilmente in quel movimento di macchina brusco e quasi violento che chiude il film sul sorriso perplesso del padre di Geremia: di fronte al cuore ermeticamente tragico che pulsa sotto il mondo di Favolacce, una chiara lacerazione è una lacerazione del linguaggio.
La lacerazione più inquietante di Favolacce pertiene però non al piano della sintassi filmica ma al piano del contenuto. È una lacerazione multipla, incontrollata e al tempo stesso geometrica, che assorbe e ferisce le relazioni tra tutti i personaggi del film, e il loro dispiegarsi sullo spazio. È una lacerazione sociale, nel senso eminentemente antropologico del termine società. Da un lato, c’è una lacerazione, una scissione tra casa e casa, tra famiglia e famiglia: ogni villetta monofamiliare come unica apparente isola di salvezza in un mare estraneo, in un mare di estranei. Dall’altro lato, c’è un abisso di incomunicabilità tra genitori e figli, tra mondo dell’infanzia e mondo adulto, e a poco giova la presenza di figure liminari tra le due età come la giovane madre Vilma e il suo fidanzato Mattia. Più nel profondo, sia da parte dei personaggi dei bambini che alla fine sceglieranno di non vivere, sia da parte dei personaggi dei loro genitori, c’è una scissione grave e ai margini della psicosi di sopravvivenza tra la vita che vivono e la vita che si rappresentano: ciò si avverte bene dalla lettura delle pagine della bambina che struttura tutto il racconto, ma anche e ancor di più in quell’”ideologia della svorta” che ispira molti dei discorsi “tra grandi”. In maniere diverse, tanto il Bruni di Elio Germano, il padre di Dennis e Alessia Placido, quanto il Pietro Rosa splendidamente interpretato da Max Malatesta quanto anche Amelio, il padre di Geremia di cui sopra, al quale presta il volto Gabriel Montesi prospettano continuamente nei loro discorsi questa idea della possibilità di un successo improvviso, casuale e al tempo stesso meritato, che potrebbe arridere loro o meglio ancora i loro figli: Pietro Rosa si fomenta a proposito della sua nuova attività ripetendo slogan motivazionali di Steve Jobs, Amelio e suo cugino concordano sul fatto che Geremia dovrebbe andare alla Nasa o al suo equivalente italiano, Bruno Placido e sua moglie Dalila entrano in un gioco di pericolose simmetrie dicendosi l’un l’altro “tu sei il miglior padre che ho mai conosciuto”, “tu sei la migliore madre che ho mai conosciuto”. Tutto questo sfuggire in un modo o nell’altro alla realtà è un atteggiamento di ingloriosa passività, di inettitudine felice la cui pericolosità non è colta dagli adulti ma è avvertita dai figli, che rifiutano le regole del gioco e che nel finale coerentemente si danno la morte: ma a differenza dei loro genitori il loro suicidio non è una fuga dalla realtà, è un rifiuto netto e fin troppo coraggioso della possibilità catastrofica che “le cose restino sempre così”; la loro morte è modo per porre fine a un miasma e a una contaminazione nel senso più classico e greco del termine.
Soprattutto se si colloca Favolacce in un’ideale storia del paesaggio cinematografico italiano, di visione in visione un tema emerge con crescente chiarezza. Geograficamente parlando, il milieu entro cui si muovono i personaggi di Favolacce, i vari Bruno Placido e Pietro Rosa, è al confine liminare tra i viali senza chiari confini di una provincia imborghesita e il quartiere senza storia di una metropoli diffusa. La memoria cinematografica corre allora – forse per un automatismo, ma tant’è – verso l’universo pasoliniano, verso quel microcosmo borgataro universalizzantesi che disvelava innocenza, vitalismo, primigeneità. Ecco, se pure è corretto l’accostamento, in termini storici e diacronici, tra la borgata pasoliniana e questo non-luogo “dinnocenziano”, di visione in visione si fa strada una sensazione sociologicamente epifanica: la sensazione che il vero tema di fondo di Favolacce, il tema che il film non tratta mai direttamente – forse perché intrattabile cinematograficamente, in quanto mero contrasto di ideali – ma che è uno dei suoi princìpi strutturanti più forti, è la lacerazione tra comunità e società, il sopraggiunto scarto semantico tra questi due termini, tra questi due ideali.
Tematiche non dissimili le affrontava anche Salvatore Mereu nel suo Assandira, forse l’altro grande film italiano della scorsa stagione, purtroppo poco considerato dall’Accademia dei David. Ma se Assandira in fondo trattava una volta ancora della fine del mondo contadino riportando sul grande schermo il suo ultimo cantore, Gavino Ledda, Favolacce si muove su un piano diverso, più sfuggente, meno circoscrivibile. Non è solo una situazione di “crisi del rito” e di “fine del simbolo”, e di banalizzazione e del rito e del simbolo ad opera dello storytelling turistico dei luoghi, a dare a Favolacce quella consapevolezza di una lacerazione e di uno smussamento rispetto al passato. Fuori dalla grande città, com’è il caso di Favolacce e come, in misura diversa e minore, poteva essere il caso anche de La terra dell’abbastanza, tradizionalmente comunità e società coincidevano: ciò che mostra Favolacce, e ciò che mostra la nostra stessa quotidianità virtuale a uno sguardo antropologicamente più vigile, è invece quasi una contrapposizione netta tra queste due situazione, tra una comunità intesa come legame e coabitazione anche fisica tra gli abitanti di un determinato contesto geografico e ambientale e una società intesa come pratica e ideologia dei meccanismi del potere, del lavoro e delle relazioni in seno ad essa.
A ben vedere, il rapporto tra comunità e società non è solo dell’ordine della scissione, in alcuni passaggi Favolacce sfiora anche i toni della parodia: si prenda ad esempio il rispetto delle pratiche di buon vicinato, le cene assieme tra la famiglia Placido e la famiglia Rosa, che presto si trasforma in una competizione neanche lontanamente velata tra i genitori, in questa gara paradossale e squallida che sta nel confrontare le pagelle dei rispettivi figli. Non c’è rito, non c’è comunità, non c’è vera, autentica festa che sia liberazione e purificazione dell’invidia sociale e non l’ennesimo terreno di confronti ed esclusioni, non c’è neanche una memoria storica dei luoghi in cui si abita, se non per un fugace ma salientissimo accenno di Amelio a suo padre contadino – e non a caso Geremia e Amelio vivono separati dalle altre famiglie, guardati quasi con sospetto. La terra desolata in cui è ambientato Favolacce è senza identità al punto da essere indefinibile da un punto di vista geografico, sociologico e antropologico: è neutralità e indifferenziazione, nel crescere di un’invidia ed un disagio sociali che girardianamente chiedono una loro espiazione.
Che una terra senza passato sia una terra senza futuro è una lezione fin troppo facile da acquisire: e certo Favolacce non si premura di ricostruire la genesi e le cause di questo crollo valoriale che pure illustra con grande pregnanza, e del disagio esistenziale che impregna una ex-periferia che ha perso ogni riferimento a un centro per continuare ad essere tale. Ma nel lavoro di sottrazione e di astrazione che Favolacce indubbiamente fa – la provincia romana è poco più che un pretesto, dialetto a parte – il secondo film di Fabio e Damiano D’Innocenzo torna ad essere quello che il cinema italiano un tempo era: universale, o almeno universalizzabile. Questa condizione di vaghezza sociale, politica, esistenziale, morale ed economica, questa “terra dell’abbastanza” ritratta e approfondita anche nel loro secondo film, forse travalica le frontiere, sicuramente viene capita e premiata anche e forse pure di più da pubblici diversi, da pubblici stranieri. Il nostro è un “tempo che attende la Grazia”: ma questa Grazia non arriva e forse, come Favolacce mostra masticando a un tempo tragedia e grottesco, questa Grazia può essere l’esatto contrario di quanto sperato, di quanto adombrato. Solo Geremia, solo Amelio, solo il diverso si salva, può trovare scampo, ma è un Noé inconsapevole, un Ismaele che non racconta storie.
Cos’è allora Favolacce? Un esorcismo, come suggerirebbero i versi apotropaici del “Bisogna morire” della Passacaglia attribuita a Stefano Landi? Una perdita dell’innocenza fatta film, opera seconda di due autori gemelli “venuti dal nulla” che intanto hanno appena annunciato il fine riprese del loro terzo film? “I bambini ci guardano” A.D. 2020? Un Lanthimos “de noartri” che si sposa con un Pasolini riveduto e corretto, depasolinizzato? Una storia vera ispirata a una storia falsa che non era molto ispirata, con il gratuito e sofferto nichilismo generazionale di chi si affaccia al mondo e ne rifiuta il futuro? Forse Favolacce è il ritorno della tragedia in un mondo e in un tempo in cui il tragico sembrava estinto, e il riproporsi – lacerato e contaminato – degli archetipi da manuale di narratologia classica in un frangente ed un linguaggio in cui l’unica narrazione possibile, almeno da parte dei giovani autori, sembrava essere una fastidiosa narrazione del sé; solo due gemelli di spiccata sensibilità avrebbero potuto fare un film tanto organicamente corale e intragenerazionale, se vogliamo. Forse, Favolacce è il concetto classico e fin troppo abusato di alienazione, recuperato con originalità di sguardo e trasposto in uno scenario di “archetipico contemporaneo”; e forse, Favolacce è un’analisi sociale essenzialmente visiva e narrativa che, con gli stilemi della fiaba, di un realismo in disfacimento e dell’alienazione, ha la forza e la precisione di un saggio di sociologia. E allora forse sì, forse no, forse non importa così tanto, Favolacce era il film che il cinema italiano aspettava da un po’, aspettava da troppo, nel suo equilibrio tra tradizione e originalità, nel suo insinuarsi tra il nichilismo e la Speranza.
Il saggio Conversazioni su Favolacce, a cura di Ludovico Cantisani, con disegni e foto inedite di Fabio e Damiano D’Innocenzo, è disponibile su www.artdigiland.com/italian/conversazioni-su-favolacce e su Amazon
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

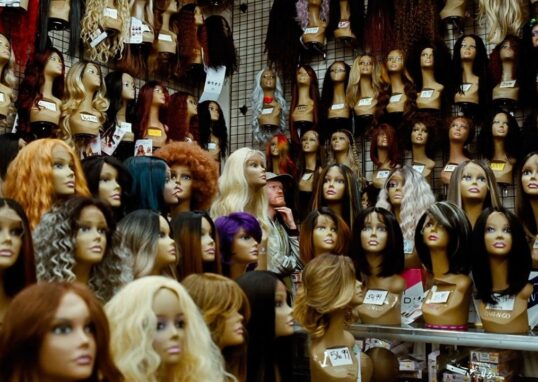





Molto interessante la descrizione! Mi incuriosisce! Passerò su amazon…
Il reame delle pippe proprio…l’articolo e il film, degni uno dell’altro.
Tavolacce dei fratelli Vincenzoni è una delle più vergognose, scandalose, imbarazzanti e ridicole cose viste al cinema negli ultimi 20 anni.
Lo scandalo sta tutto nel vedere quanto la critica italiota non capisca veramente niente di autorialità.
È il “famolo strano” di Carloverdoniana memoria fatto film.
Filmacci