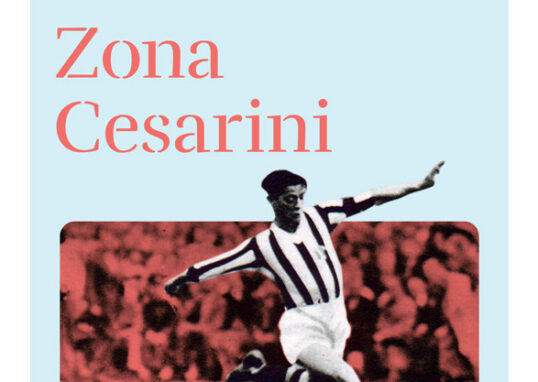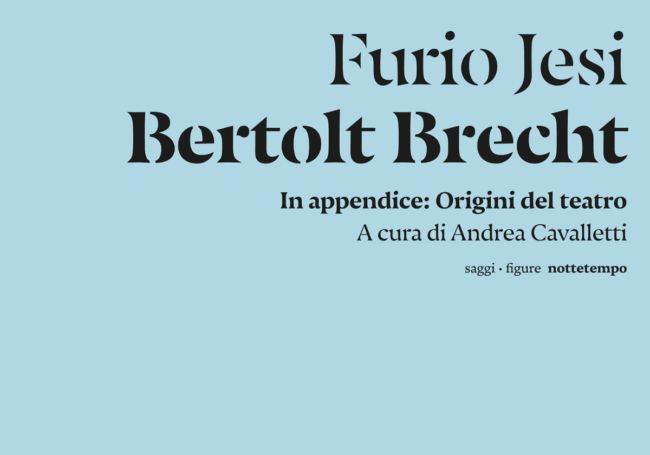
Mille e una volta ho immaginato Mr Brecht fare su e giù lungo Ocean Avenue, a Santa Monica, mentre masticava il sigaro contro la vista abbagliante dell’acqua marina, riparato dalle palme, calmo e lento, come il trascolorare di un rimorso. Me lo sono immaginato discutere con il padrone di una lavanderia cinese, mentre entrambi ironizzavano su quanto sproporzionato fosse il naso di Mr Brecht. L’ho visto entrare in un cinema, magari al Criterion Theatre, dove si accomodava in balconata, qualche volta a dormire, finalmente al riparo dal vento e dalla troppa luce della costa.
Tuttavia un languore di fondo persiste in questa fantasia: qualcosa di questo è mai stato vero? Mr Brecht ha mai camminato fumando lungo Ocean Avenue, ha mai socializzato con un cinese nei locali odorosi di una lavanderia, ha mai incontrato il cassiere invalido di guerra all’ingresso del Criterion?
La prima risposta è: non ne ho la più pallida idea. La seconda, invece, recita: poco importa, perché vivificare una storia – che spesso coincide con il riattivare il corpo e la voce dei morti – è un riflesso involontario, un atto rituale, che nelle sue movenze, attraverso il suo codice, segue un’inerzia propria. Furio Jesi, in Origini del teatro (di recente riproposto in appendice al suo Bertolt Brecht, riedito da Nottetempo a cura di Andrea Cavalletti), attribuiva «al linguaggio non parlato» una funzione nodale, osservando come «compiere determinati gesti che alludono a una particolare vicenda, confermare le allusioni con abiti, tatuaggi e pitture corporee appropriate significa genuinamente evocare la vicenda in questione: significa partecipare ad essa, farsi coinvolgere in essa. Significa anche ripeterla».
Forse, quando si parla di scrittura, l’investimento materiale è più leggero, ma la pratica parrebbe la stessa, ovvero indossare la vita di un altro attraverso la sua superficie evocativa, gli attributi. Il naso di Mr Brecht, i suoi occhiali, l’impianto del suo cranio: reliquie magiche per evocare di nuovo la sua ombra.
Così, come in un’avulsa costruzione teatrale, quella mia fantasia sedimentò in un racconto scritto anni fa (si intitolava Pietà ed era ambientato tra Santa Monica e Berlino Est), dove io provai a ‘interpretare’ l’interlocutore cinese di Bertolt Brecht. Ne stilizzai la figura, la imparai, ne riattivai il meccanismo arcaico, e ne feci uno specchio in cui il protagonista di quello scritto – il drammaturgo tedesco in persona – cominciò a riflettersi. E riflettendosi, agì, si mosse, parlò e visse per la durata di qualche pagina. Anche lui animato da una viscerale appartenenza a un mondo permeato di storie. La pagina come un palco, la parola come uno scenario, e poi la sua voce postuma, totalmente rivolta al pubblico, ovvero ai lettori. Gli attributi necessari a quel primo contatto erano diventati improvvisamente una ‘maschera’, cioè per dirla ancora con Jesi «la concreta testimonianza di un’epifania, di un’apparizione; la componente più esplicita dell’esperienza non solo visiva, ma visionaria che sta alla base delle ripetizioni rituali, teatrali, di un evento mitico, […] il simbolo della sopravvivenza del sacro nella cerimonia rituale o nella rappresentazione».
Il Brecht di Pietà, tra le molte cose, era polvere di stelle arrivata dalle pagine di un altro scrittore. Lo avevo intravisto in I morti a tavola di Antonio Tabucchi (racconto della raccolta Il tempo invecchia in fretta), dove un ex agente della Stasi, ormai assimilato nel flusso della nuova Germania, ricordava per cenni e analogie di quando tra i suoi sorvegliati c’era proprio Bertolt Brecht, a cui attraverso l’osservazione quotidiana si era affezionato più di altri, pur non potendogli mai svelare la sua presenza. Un racconto ‘specchio’, magistrale, in cui il rovescio della storia cuciva il dubbio del lettore in tutto il suo sviluppo: e se invece il drammaturgo avesse saputo benissimo di essere seguito, spiato, documentato, e avesse accettato per umana pietà la presenza di quell’ombra, per non affliggerla ulteriormente nella sua condizione di supino gregario della storia? È così che scoccò la scintilla del ‘mio’ fantasma, che riappariva questa volta a spasso per la contea di Los Angeles, nell’attesa di poter tornare a casa e diventare, suo malgrado, nuovamente un sorvegliato speciale. E quando ci tornava, tesseva l’elegia di quell’uomo che si era ritrovato a dover interpretare il ruolo di un’ombra, quasi di un doppio suo, a cui toccava il residuo di tutto, compreso quello della condizione umana. Creazioni divergenti intorno alla medesima vicenda. Rivisitazioni di un mito che coincideva con le sue infinite possibilità e delle parole per dirlo.
Nel 2026 saranno trascorsi ottant’anni dalla scomparsa di Bertolt Brecht in quel di Berlino Est, da quando una pietra con inciso il suo nome è stata posata al cimitero municipale di Dorotheenstadt, a pochi passi da quella che era stata la sua abitazione. Eppure sembrerebbe trascorsa un’epoca, se volessi sondare la presenza radicata e viva di Brecht nella mia cognizione, e nella mia vita, immaginandola come l’esito di un sedimento lento, secolare, e non invece di un urto, di una perentoria intuizione. La stessa che determinò una specie di consapevolezza, che ora si riproporne nella mia testa in forma di postilla: per lo scrittore può valere quello che, riducendo, secondo Brecht valeva per l’attore. Rinunciare all’interpretazione in favore della rappresentazione, smettere di immedesimarsi e rompere finalmente l’illusione emotiva. Suonerebbe più o meno così: «Lo scrittore può rinunciare all’interpretazione in favore della rappresentazione. Lo scrittore può smettere di immedesimarsi e rompere l’illusione emotiva». Mi chiedo in quale forma si spalancherebbero le nostre invenzioni, i nostri mondi, quale forma assumerebbe la rivoluzione di certi nostri fantasmi, di certe maschere. Chi può dirlo?
Danilo Soscia (1979) ha pubblicato la raccolta di racconti Condomino (Manni, 2008). Studioso di letteratura e di Asia Orientale ha curato il volume In Cina (Ets, 2010) e realizzato lo studio Forma Sinarum. Personaggi cinesi nella letteratura italiana
(Mimesis, 2016). A gennaio 2018 pubblicherà per minimum fax Atlante delle meraviglie. Sessanta piccoli racconti mondo.