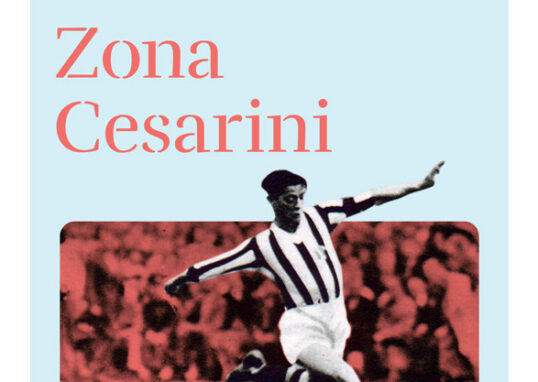«C’è la felicità che hai / E la felicità che meriti».
Quasi sempre, quando mi arriva un libro nuovo di poesia, apro una pagina a caso e leggo il testo che ho davanti mi è successo anche per La tradizione di Jericho Brown, appena uscito per Donzelli, con la cura di Antonella Francini. Ero a casa con Anna e Sabina, una delle nostre amiche più care, che è pure la libraia della Marcopolo di Venezia. È stata lei a regalarmi una copia del libro, molto atteso, del vincitore del Pulitzer 2020. Eravamo seduti, dopo cena, apro a pagina 44, leggo qualche verso e dico: ma questa è bellissima, ve la leggo? La poesia si intitola Duplex e i primi due versi sono questi: «Una poesia è un gesto verso casa. / Fa richieste oscure che dico mie.»; due versi meravigliosi che aprono mondi come se il poeta ti invitasse a spalancare una serie di finestre una dopo l’altra. Fatto sta che io cominci a leggere questa poesia ad alta voce e verso la metà sento la voce che si rompe, sento la commozione arrivare prima che io mi renda conto del perché, del motivo, e, soprattutto, di cosa mi stia dicendo il testo. Ma i versi fanno prima di dire, di spiegare, e quando sono arrivato alla fine di quello che è poi un sonetto, con l’ultimo verso che è uguale al primo ero proprio commosso e, sinceramente, contento di quel momento condiviso. Ora, un pezzo critico, una recensione, forse, non dovrebbero cominciare così, ma chi lo sa davvero come si comincia, e chi lo sa davvero cosa io intenda scrivere. Quello che so è che una poesia come si deve ogni tanto fa questa cosa e quando accade è bellissimo e, credo, sia questo, prima di tutti gli altri, il motivo per cui andiamo leggendo versi.
Il mio corpo è un tempio in rovina. / L’opposto di stupro è comprensione.
Proseguiamo proprio con Duplex, che nel libro di Brown è il titolo di una serie di quattro poesie – La tradizione è composto da 52 testi –; si tratta di sonetti anomali, scritti a coppie di distici, all’interno sono facilmente riconoscibili novenari ed endecasillabi. Leggiamo poi versi che si ripetono o si riflettono come in uno specchio, fedeli proprio a un procedimento di duplicazione e del suo contrario. Brown sceglie la forma ibrida, una forma che gli somigli, sentendosi lui stesso difficile da capire e da collocare nel mondo, che determina e giudica attraverso stereotipi e cliché (vedasi postfazione di Antonella Francini). Ma sceglie il sonetto irregolare per tenere alto il margine di improvvisazione che viene dal blues e, mi pare, pure dal jazz; e per pescare, per esempio, dal ghazal nordafricano. Lasciando per un attimo la struttura, già di per sé molto interessante, torniamo al contenuto e all’effetto che fa. Il duplex è inteso come un tipo di appartamento americano, composto da due abitazioni che condividono una parete (o ne sono separate soltanto, di nuovo il contrario di una cosa), ma viene in mente anche il vecchio duplex telefonico, negli anni Settanta, due abitazioni dello stesso condominio potevano condividere lo stesso numero per ripartire le spese, poi magari litigavano per la linea occupata dall’altro e così via.
L’altro tipo di duplex telefonico (improprio, ma forziamo) – che mi riporta a Brown – è quello che consente, sollevando la cornetta in una stanza della casa, di ascoltare la conversazione che sta avvenendo in salotto. Ascoltare la telefonata di un altro, condividere un appartamento, sono modi, anche questi, di connettersi tra le persone. Questa serie di quattro sonetti, ma tutte le poesie del libro, fanno – tra gli altri – questo effetto: noi lettori, stiamo ascoltando la telefonata di Brown con qualcuno e quel qualcuno siamo di nuovo noi; stiamo dietro la parete l’orecchio appoggiato sul muro e vibriamo sentendo quello che avviene nella stanza di Brown, che di colpo diventa una stanza dove siamo stati, o – in altri testi – quella che per fortuna non ci è capitato di entrare.
Ti scrivo dall’altra parte / Del mio corpo dove non mi hanno mai / Sparato e nessuno mi ha mai accoltellato.
Il suono è centrale nei versi di Brown, la forma e il contenuto contano allo stesso modo, addirittura, paiono condizionarsi a vicenda, sembra una cosa banale ma non lo è affatto. È un libro moderno, di un poeta che non ha ancora cinquant’anni, afroamericano, nato in Louisiana, gay, conoscitore profondo della poesia, maestro nel manipolare le parole e portarle (e farsi portare) nel posto in cui vuole andare. È un poeta lirico, ma questo aggettivo cambia senso indossato da Brown. Lirico diventa immediatamente una cosa di adesso, una caratteristica che pare venire dal futuro.
Nel sogno dove io sono un’isola, / Divento verde di speranza. Vorrei finirla lì
E se Jericho Brown viene dal futuro perché il suo libro si intitola La tradizione? Intanto perché il classico e il moderno si mischiano per forza di cose, che lo si voglia o meno, e poi perché la tradizione per Brown è, naturalmente, memoria, origini, storia, usi e consuetudini che si tramandano da una generazione all’altra, ma è pure la rappresentazione di quello che la tradizione – per gli afroamericani – porta con sé: soprusi, violenze domestiche e sociali, lotte, mancati riconoscimenti, destini segnati, morte, omicidi, svantaggi. Tradizione vuole dire anche attualizzare il mito greco ponendolo sotto un’altra luce, si legga Ganimede, il bellissimo testo che apre il libro e ci dichiara subito con chi e cosa avremo a che fare. È un libro che ripropone uno dei grandi temi della letteratura nordamericana, quello del razzismo, dell’emarginazione di chi non è bianco, qualcosa che chi continua a definirsi un paese libero non ha ancora risolto. Ti dicono, pare recitarci Brown, che ci sono grandi opportunità ma poi la maggior parte di noi non uscirà dal quartiere ghetto, nemmeno potrà sognare, magari un poliziotto lo ucciderà e il suo migliore amico non potrà intervenire per non incorrere nella stessa sorte.
[…] Lo giuro, se sentite / Che sono morto da qualche parte accanto / A uno sbirro, lo sbirro m’ha ucciso, M’ha / Portato via da noi e lasciato il mio corpo / Che, non importa cosa ci hanno insegnato, / È più grande dell’indennizzo d’una città / A una madre perché smetta di piangere, / È più bello della pallottola nuova / Ripescata nelle pieghe del mio cervello.
La tradizione è anche un libro che ha a che fare con il corpo e con l’amore. In fondo le 52 poesie di questo libro sono tutte d’amore e sono tutte quante bellissime, molto ben rese in italiano dalla traduzione di Francini. Si può riporre questo volume sullo scaffale sapendo che lo si tornerà a riprendere di tanto in tanto, se ne sentirà il bisogno.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/