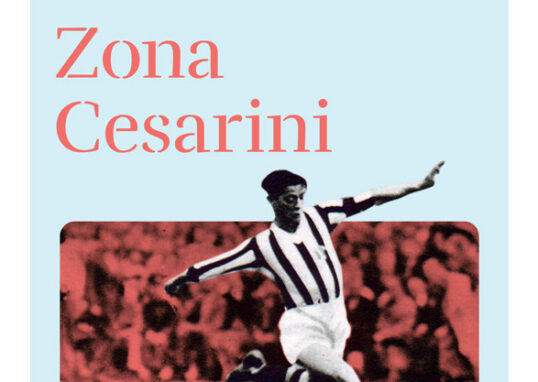Pubblichiamo, ringraziando l’editore, un estratto dal libro Pier Vittorio Tondelli Viaggiatore solitario, uscito per Bompiani a cura di Fulvio Panzeri. Con l’occasione ricordiamo che nelle giornate dell’11 e 12 dicembre si terrà l’evento Pier Vittorio Tondelli non era invidioso, ideato e curato da Piergiorgio Paterlini, a 30 anni della scomparsa dello scrittore. Tra i partecipanti alle giornate Gabriele Romagnoli, Marco Belpoliti, Simonetta Sciandivasci, Luciano Ligabue, Giuseppe Culicchia, Antonio Spadaro.
di Fausto Pezzato
È Pier Vittorio Tondelli, ha un viso che assomiglia al cognome, da putto malizioso, sorriso finto-imbarazzato, l’aria da apprendista intellettuale preso in contropiede dall’improvvisa notorietà. È giovane, molto giovane: vien subito voglia di perdonargli tutto. È nato nel 1955 a Correggio, Reggio Emilia. Ha studiato a Bologna. E ha scritto quest’opera prima che s’intitola Altri libertini. Sei lunghi racconti di droga, omosessualità, scostumatezze provinciali intorno a squallide stazioni ferroviarie, su strade perdute nella notte, livide piazze di paese: un piccolo mondo crepuscolare, brulicante di battone, “bucati”, spacciatori di droga al quale l’Emilia fornisce solo un pretestuoso ancoraggio. La scrittura di Tondelli è carica di eccessi ma non per questo priva di ricercatezza, eleganze, sciatterie accattivanti, una lingua colta, frutto di naturale versatilità e di identificabili letture.
Nutrito, come dice l’autore, “di molto affetto e molto scazzo”, Altri libertini è un’onda post-sessantottesca in cui l’età dei protagonisti è cultura: quella dei viaggi “insensati”, dell’estraniamento della “marja”, del sacco a pelo, del sesso tenero e animalesco, delle fughe dalla politica, dalla famiglia. Tondelli ha scritto nella nebbiosa Correggio un romanzo sulla cultura dell’autostop sgradevole e provocatorio. Quindi ben dentro a una “corrente di pensiero” che si rifà ai libri di Kerouac più che alla storia del Movimento.
Chi sono, Tondelli, gli “altri libertini”?
Gente in cerca d’identità, di felicità, gente che si gioca il tutto per tutto… Amori, esperienze quotidiane, sbragature,
speranze di giovani fin troppo allo sbando, sempre disposti ad andare fino in fondo.
Come li hai scoperti? Chi sono?
Per me, come per tanti altri, è stato molto importante il Movimento, il Settantasette… Ha liberato energie latenti, ha invogliato ciascuno ad assumersi la propria vita. I personaggi di questo libro non sono rintracciabili nella realtà, però la finzione trova nella realtà ampi riscontri. La storia del gioco, per esempio, è una storia violenta raccontata in modo violento: la sua improbabilità non destituisce la sua verosimiglianza, non so se mi sono spiegato…
Il “tuo” Settantasette com’è stato?
L’ho vissuto fra Milano e Correggio con qualche puntata al dams di Bologna, un po’ sulla strada appunto. Vissuto, direi, in modo più culturale che politico, nella sua ricchezza creativa.
Cos’è rimasto di quella stagione?
Be’, non saprei… Ci sono punte che stanno emergendo adesso, lo stesso Boccalone di Palandri viene fuori da lì, e anche altri libri.
Appartieni a una generazione che fa un po’ paura e un po’ sorridere, che rimane, tutto sommato, poco comprensibile alla
cultura diciamo così tradizionale. Chi siete?
Abbiamo vissuto in pieno il clima delle vacche grasse – non voglio usare la solita frase odiosa, boom economico – della speranza. Abbiamo avuto più istruzione, più cultura, più libertà, più viaggi soprattutto. E proprio per questo ci siamo sbandati di più, siamo venuti su come tante velleità, una generazione che forse è ancora infantile. Ma tutto comincia dal Sessantotto…
Anche la droga?
No, non credo che la droga sia circoscrivibile a quell’area ma a un’area culturale più vasta, forse quella della beat generation. Allora, se ci penso, eravamo piuttosto rigidi in certe cose…
Non sto parlando dello spinello…
La droga pesante? Be’, quello è un atteggiamento personale difficilmente generalizzabile. È un modo nuovo di buttar via la propria vita che non necessariamente nasce in un momento preciso.
Qual è l’“emilianità” dei tuoi racconti?
Le osterie, le osterie bolognesi specialmente. Questi posti fanno da sfondo. Da panorama, da luogo di raccolta delle mie storie. Sono fondamentali. In nessun’altra regione italiana l’osteria è altrettanto diffusa e così importante… Andar per osterie è un fenomeno tipicamente emiliano che ha alimentato quella passione della conoscenza umana, quella sorta di mistica dello “stare insieme” che nel libro viene descritta spesso. Guccini non esisterebbe, credo, senza l’osteria, è stato lui il poeta della nuova convivialità.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente