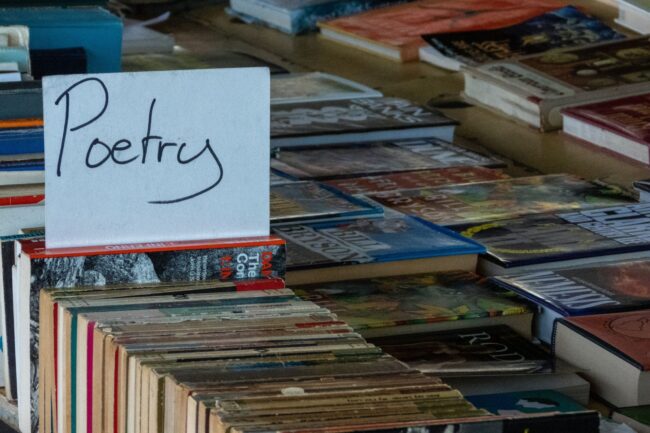
Leggendo una poesia di Roberto Bolaño, per il canale streaming di «Decamerette», ho involontariamente sostituito in piedi ci sono solo i cordoni / della polizia con in piedi ci sono solo i cordoni / della poesia, mi è parso da subito uno dei più bei refusi di sempre. L’idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l’esatto contrario di ciò che fanno i cordoni della polizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà di una, due o più poesie, di vari poeti, cercando un filo comune, facendo sì che versi lontani si tengano per mano.
*
Prendiamo una foto, forse una polaroid, teniamola tra le dita, ora avviciniamola ai nostri occhi. Ecco che tutto pare chiaro, ecco il primo piano di un volto, i colori nitidi, ecco una casa, un lungomare, qualcosa sullo sfondo, ecco un gioco di luci e ombre. Sembra una bella foto. Ora allontaniamola. Ecco che qualcosa che ci era sfuggito, sottratto al nostro sguardo dalla troppa vicinanza, adesso compare. Ecco un oggetto, cos’è? Uno stipite, il bordo di un letto, un armadio? O forse non riusciamo a vedere bene, non mettiamo a fuoco, la foto a questa distanza pare sgranarsi, e allora quel cilindro che vediamo a lato della figura potrebbe essere la base di una lampada, un cavo elettrico, un sacchetto di plastica di quelli che ti danno i negozi di alimentari. E se invece fosse l’angolo superiore di una bara? Ma no, è solo una vecchia insegna già sbiadita ed è destinata a sbiadire ancora di più nella polaroid. Prendiamone un’altra adesso è una foto silenziosa, notturna, scattata in assenza di luce, c’è un vuoto, qualcuno se ne è andato, e in questa forma rettangolare appena stampata si contempla e racconta una assenza come nelle poesie di Stefano Bottero.
Un’altra foto, un’altra forma, una panchina fuori da un portone, uno scenario casuale, ferma come la panchina, a completarne la forma, è una figura umana, che fa paesaggio, che ha una voce che nessuno sente, come avviene in una poesia di Diletta D’Angelo. Posiamo sul tavolo questa polaroid e prendiamole un’altra, ecco che ci salta tra le mani. Come se fosse un ritorno, e lo è, si ritorna sempre, in questa polaroid c’è una porta aperta e si presenta agli occhi di noi che guardiamo una sorta di inventario privato che non lo è più, che qui e ora è condiviso, ci sono armadi e cassetti da aprire, ma se osservi bene la foto ti aspetti che compaia qualcuno a cui dire che tutto si è rotto, come in un testo di Andrea Donaera.
*
«ti aspettano soltanto cose immobili
oltre il limite di corridoi dove
la colpa fiorisce
e la tua assenza è breve come fuochi artificiali
aritmie a cui appartieni fino al punto in cui
te ne vai via
a cullarmi in nuove aspettative»
Questa poesia è tratta da Notturno formale, opera di Stefano Bottero (industria&letteratura 2023), libro molto interessante, che al suo interno ha anche alcune fotografie di Nerina Toci. Si parla di un’assenza, qualcuno è andato, e allora – proprio come fa il fotografo quando scatta – il poeta cerca di fissare la parola malinconia senza scriverla, questo è uno dei segreti della poesia. La malinconia per l’assenza e la malinconia diversa e incerta per i giorni a venire. Questo testo arriva a bassa voce, eppure colpisce da subito, per chiarezza, per estrema decisione della voce. Ti aspettano solo cose immobili l’efficacissima apertura ci inchioda, le cose immobili appaiono prive di speranza, si pensa a uno stagnamento, a una condizione di fermo immagine ripetuto all’infinito. Le cose immobili ti impediscono di vederne altre che invece si muovono, che accadono, al di là dei corridoi, che diventato qui lunghi chilometri, snodati attraverso pareti o troppo bianche o troppo scure. Eppure, Bottero, che sa l’immobilità è solo percettiva, poco dopo scrive e la tua assenza è breve come fuochi artificiali ovvero che esiste solo l’attimo in cui tutto esplode, quando la persona oggetto dell’assenza se ne va.
Solo in quell’istante è davvero assente perché poi inevitabilmente ritorna per via di tutto quello che costruiamo per colmare il vuoto. Il verso finale propone nuove aspettative in cui cullarsi, buttate lì come si butta il resto di una sigaretta finita in un posacenere. Bottero pare volerci dire, tra le altre cose, che le nuove aspettative non sono tanto verso sé stessi ma sempre rivolte a chi è andato, non più persona, ma solo figura incarnata nell’assenza. Notturno formale è un libro che ha che fare con il tempo e il non saperlo (né poterne) disporre, con oggetti e luoghi che perdono il loro significato, diventando per forza di cose correlativi oggettivi di uno stato d’animo. In un’altra poesia, Bottero chiude: la distanza è lingua – / al tuo posto dormono i tuoi nomi, si tratta di due versi molto belli che tengono assieme diverse cose, il fatto che tutto è linguaggio, e ciò che non lo è non esiste. La distanza (e perciò l’assenza, la nostalgia, il senso di perdita) (e il nostro misurarla) è uno dei linguaggi a noi più noti e più sconosciuti allo stesso tempo. I nomi al plurale appoggiati su un cuscino ci ricordano che in ogni storia d’amore, la persona amata non ha mai un nome soltanto.
*
«A undici anni si stendeva nelle tenebre dell’asfalto
con i fiori spezzati tra le fratture esposte
solo il cielo – riflesso negli occhi –
guardava i rivoli di plasma e di sale,
la necrosi tissutale, le grida suicide di nostra madre
suturavano una bambola riempita di sabbia
espellevano le ultime ossa
Vorrei solo dirti scusa scusa non ho saputo guardare oltre i tuoi resti
ti ho rimpiazzato il crescere vincere perdere provare
tolto il ridere vivere respirare guarire».
Le polaroid che ho sul tavolo, in questo momento, posizionate in ordine sparso, perché non è tempo di catalogare, sono immagini che ho scattato mentalmente dopo aver letto Defrost di Diletta D’angelo (Interno poesia, 2022); le osservo e mi faccio una lunga domanda – che tiene a sé una serie di sotto-domande – ovvero, come si racconta il tempo presente? Quanti (e quali) sono i modi per rappresentare una deformazione? Per Diletta D’angelo – alla sua notevole opera prima – un tentativo, un modo possibile è quello di andare all’indietro, attraverso il ricordo, rielaborando traumi e storture, il famoso dettaglio, oggetto, giorno fuori posto. La matematica ci aiuta con la certezza del calcolo, l’archivio ci aiuta con il documento, la storia si costruisce con il racconto, lo studio e la memoria, una cartella clinica si compone di tutta la vicenda medica di una paziente. La poesia può viaggiare all’indietro, saltando di memoria in memoria, mettendo insieme fatti, all’apparenza sconnessi tra loro, può fare il gesto di scongelare, appunto, tirando fuori dal freezer cose che sono rimaste sotto ghiaccio a lungo. E non si tratta di cibo, ma di figure, di corpi e occhi, di racconti di lesioni, ferite. Come nella figura rappresentata in questa poesia, che a undici anni si stendeva sull’asfalto, e ci sono i fiori spezzati e ci sono le fatture esposte. Chi legge non sa chi sia il personaggio ma la vede e sente come un fragore, vede i fiori recisi, sente il rumore che fa un osso quando si frattura.
La poesia prosegue e arriva a una svolta bellissima e geniale con questo lungo verso: Vorrei solo dirti scusa scusa non ho saputo guardare oltre i tuoi resti. Una richiesta di perdono tardiva, l’ammissione di non aver saputo vedere oltre il corpo, oltre il disagio. Non sono andata, ci dice D’Angelo, oltre a ciò che si vede, ed ecco il ricordo, la capacità di trovare ciò che rimane dietro i resti di qualcuno che forse abbiamo perduto. La poesia in fondo è una speranza. Gli ultimi due versi di un’altra poesia recitano: La marcescenza delle ombre (degli altri) non è ancora un problema / non lo è mai abbastanza. Qui è ben rappresentato ciò che sempre accade, ovvero quello che è degli altri, dall’inizio alla fine, non è ancora un problema, lo spostiamo, non lo è mai abbastanza da riguardarci. Dopo è troppo tardi.
*
«La casa in cui ti vivi è tutta un esitare
[nel timore di un arrivare altrove
hai messo in piedi un vorticare a sbando
ma perché?; per chi?; da quanto?; da quando?)]:
tra il bagno e il tinello: i passaggi: due bivi:
la finestra aperta: e il coltello:
ed eccoti: a te la scelta, ti dici-
gli occhi fissi atterriti sulla porta:
esci: ritorni, per ora, tra i vivi:
tra i panettieri in canottiera, tra
i bar che aprono e la rumena storta
che chiede, chiede, e tu non le rispondi
[non sai nemmeno cosa chiede: tu non rispondi
(perché torni già dentro: perché esondi)]»
Qui in questa polaroid c’è una casa che è tutta un esitare, ed è quella in cui vivi. Chi ci vive? E perché la casa è tutta una somma di esiti, di incertezze, di scelte che non si compiono, che non si possono più fare? Vediamo di capirlo leggendo questa bella poesia di Andrea Donaera, tratta da Le estreme conseguenze (Le Lettere, 2023). L’abitazione diventa la somma di tante incertezze, di un arredo che sovrascrive l’architettura ordinaria del luogo, diventa teatro di un vagare senza senso. Il soggetto che si muove tra quelle che chiamiamo mura, ma forse sarebbe meglio chiamare pareti, ma forse sarebbe corretto chiamarle strutture mobili che lo inseguono o si aprono di colpo, è preda di un ritorno che non si compie, che non può compiersi.
Per questo Donaera usa – alla maniera quasi Sanguinetiana – parentesi quadre, tonde, due punti che aprono continuamente, perché poco c’è da chiudere, c’è solo da sbandare a ritmo di musica forte che in qualche modo sentiamo, e l’angoscia che viene da domande poste non si sa bene da chi, alla quale chi vive nella casa esitante non sa rispondere. Ma è un morto il soggetto? Perché a un tratto esce e ritorna tra i vivi, ma se leggiamo ci viene da pensare che non esiste una vera distinzione tra il mondo dei morti e quello dei vivi, la casa allora può essere un confine, uno stargate, e i panettieri in canottiera sono un altro ricordo di sé stesso. Chi si muove e narra nei bei testi di Andrea Donaera è qualcuno che a un certo punto decide di attraversare la sua memoria, prova a mettere ordine ma incrocia un nuovo scompiglio, e saltano fuori le perdite, i dolori, le cose incomprese, tra le estreme conseguenze c’è – non da ultima – quella di sopravvivere. In un’altra poesia, il poeta di Gallipoli scrive: ma è ancora oggi: un oggi che non finisce / non sai da quanti giorni ti succede: / la luce va e viene: in strada, per casa, quando si va a fare i conti con la memoria si entra in un oggi che non finisce perché è pieno di ieri e tiene nascosto in fondo all’ultimo degli armadi il domani.
Bottero, D’Angelo e Donaera hanno scritto tre libri di poesia molto interessanti e molto diversi e che in qualche maniera si tengono tra voglia di scavare all’indietro e voglia di andare avanti, non sapendo come fare, chiudiamo dedicando loro tre due frasi dello scrittore argentino Salvador Elizondo, tratte dal suo romanzo Farabeuf (Liberaria 2018, traduzione di Giulia Zavagna), la prima è questa: «La vita era soggetta a una confusione nella quale era impossibile distinguere il presente dal passato» e la seconda è questa: «Siamo il ricordo di qualcuno che ci sta dimenticando?». E qui ce ne andiamo.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/






