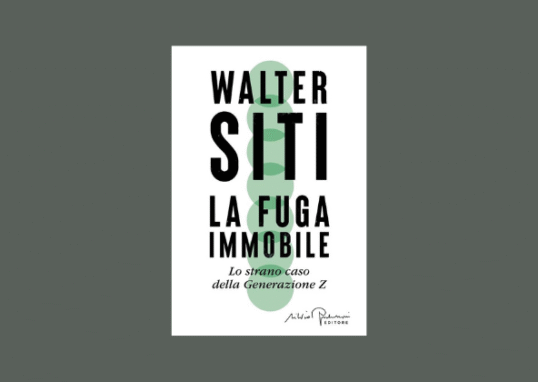Quando ho letto per la prima volta Ocean Vuong con Brevemente risplendiamo sulla terra (La Nave di Teseo, trad. di Claudia Durastanti, ne avevo scritto sempre qui su minima, eravamo nel pieno della pandemia e mi sembrava che se ci era capitato di risplendere era stato davvero per molto poco e che quel poco fosse già ampiamente alle nostre spalle. Poi ho letto il romanzo di questo ragazzo – ne avevo sentito parlare come poeta ma non ne avevo ancora incrociato i versi – e ho capito, tra le altre cose, che quel minimo splendore spesso ci è offerto dalle pagine della grande letteratura, e Vuong la stava facendo senza dubbio.
Lo splendore di riconoscersi in perfetti giri di frase, e in un mondo molto distante dal proprio ma di colpo vicino. Vuong scriveva in una lingua nuova, una lingua che sceglieva l’inglese e lo ribaltava dandogli nuova linfa. In quel romanzo Vuong traduceva l’America di oggi a sua mamma e a sua nonna e la trasportava a tutti noi. L’America con molto poco ancora da sognare, illuminata solo dalle luci dei supermercati di periferia. L’America che nessuno conosce bene e che nasconde la poesia (o lo splendore) che le è rimasta. Con questi ricordi e molta curiosità attendevo il nuovo romanzo di Vuong e non sono rimasto deluso, anzi, in L’imperatore della gioia, da poco edito da Guanda, con la traduzione di Norman Gobetti, ho sentito il click di cui parlava Foster Wallace, lo scatto in avanti dello sguardo e della narrativa, ne sono stato felice.
Chi in quel momento fosse passato in macchina sul ponte avrebbe visto in lontananza due persone che ballavano sotto la pioggia a dirotto, in un cono di luce in una notte del Connecticut.
Un accenno alla trama o a quello che per semplificazione andiamo definendo trama. Ci troviamo a East Gladness, città post-industriale, o quello che ne resta, in Connecticut. Piove a dirotto. Un ragazzo di 19 anni, Hai, sta ritto sul bordo di un ponte, è deciso a saltare in acqua e farla finita. Quando sembra pronto (ma lo si è mai?) al balzo sente una voce provenire dall’altra sponda del fiume. Hai si blocca come pietrificato. Chi parla è Grazina, anziana, immigrata dalla Lituania, è vedova e sola e ne ha viste tante. È scampata alla Seconda Guerra Mondiale, non le ci vuole molto a convincere il ragazzo a scendere dal ponte e raggiungerla a casa sua.
Lo accoglie, gli parla, lo ascolta, lo invita a rimanere da lei, prima per evitare che nell’immediato ci riprovi e poi, in seconda battuta, perché a entrambi sembrerà l’unica decisione possibile. Hai sembra perduto, disorientato, è il volto della disillusione dei ragazzi americani nati in contesti disagiati, poveri, figli di immigrati. Non ha un posto in cui voler tornare, ha mentito troppe volte a sua madre, accetta di restare a vivere con Gazina e le sue sigarette, i suoi ricordi, la sua strana forma di saggezza. Bastano poche settimane affinché tra i due si instauri un legame molto forte. Da lì, da quella sera, dai primi gesti di entrambi, dalle prime parole, dal primo pasto condiviso, cambiano le loro vite.
C’è affetto, attenzione e cura. Una profonda comprensione dell’altro, la condivisione dei traumi – quello della guerra per Grazina, quello di capire sé stessi e crescere per Hai – e il destino di essere stranieri, figli di altre terre lontane accomunati dall’aver più o meno scelto di camminare sulla terra americana, non più accogliente, non più promettente. Hai capisce che un futuro è possibile, un tipo di futuro che non corrisponde al sogno americano, non più realizzabile (ammesso che lo sia mai stato) ma al proprio desiderio più intimo. Hai capisce che provare a essere una brava persona, esserlo nel ripetersi di giornate ordinarie, normali, è già tanto, e come gli ha insegnato Grazina, è la cosa più difficile.
È una cittadina dove il venerdì sera i ragazzi delle superiori, non avendo dove altro andare, si piazzano col pick-up del patrigno ai margini bui del parcheggio del Walmart a bere Smirnoff da bottiglie di Poland Spring, ascoltando a tutto volume i Weezer e Lil Wayne, finché una sera abbassando lo sguardo si trovano un neonato fra le braccia e si rendono conto di avere più di trent’anni, e che il Walmart non è cambiato se non per il logo, che adesso è più luminoso e gli tinge di azzurrognolo il viso smunto dal tempo.
Vuong, di nuovo parte dalla sua storia di immigrato, dal desiderio di trovare un posto nel mondo e nel tempo, di nuovo inventa un linguaggio che da astratto si fa lingua comune. Il suo sguardo attento è capace di raccontarci gli Usa per quello che sono adesso, un luogo abbastanza devastato e desolato che ha finito le promesse. Le descrizioni che l’autore fa del paesaggio, della cittadina, degli ambienti pubblici e privati puntano tutte a mostrarci una cosa che era e che ora non è più. Rimangono le persone come Hai e Grazina che hanno paura e coraggio, che hanno chiaro il concetto di accoglienza e sanno che non bisogna mai abbandonare la speranza ma cercarla in maniera differente, ricrearla in un minimo gesto, in un’azione semplice. Ecco, il tipo di speranza che troviamo in Vuong ricorda molto da vicino quella di certi racconti di George Saunders.
Si interruppero per ascoltare, la testa inclinata per la concentrazione, convincendosi davvero che il peggio, lì e altrove, fosse passato. Era il tipo di giornata in cui tutto sembra possibile. Come se, finalmente, il peso della carità avesse fatto pendere dal lato giusto la bilancia arrugginita del mondo. Il tipo di giornata in cui puoi annerire le tue cicatrici col pennarello e dirti che sei normale – e forse è davvero così.
Quella notte in cui stava per saltare, Hai è apparso a Grazina come un’immagine che ne rimandava a un’altra, quella di suo figlio. L’innesco in narrativa spesso è quasi tutto e con Vuong lo è. La sua scrittura salda, ricca di metafore azzeccate, di poesia riesce a penetrare i sentimenti dei personaggi e a farli danzare sulle pagine fino a noi. Io lo preferisco come romanziere che poeta, ma è questione di gusti. Se non fosse anche poeta dubito che Ocean Vuong sarebbe in grado di scrivere così come scrive. Allievo e amico di Ben Lerner, ormai ha preso una direzione chiarissima e propria. Dovremo guardare ai suoi romanzi per capire cosa accade nella narrativa americana, cosa accade alla gente quando non sa più che fare.
L’imperatore della gioia, potremmo affermare, che è il romanzo della nuova working class americana, figlia dell’immigrazione ma non solo di quella. Si tratta di un libro bellissimo, pieno di dolore, ferite, bagliori, frammenti di luce scagliati qua e là dalle parole che, con Vuong, hanno il vizio di suonare.
E tutti continuarono a lavorare, e i parenti della bambina le sparsero attorno i regali impacchettati di rosa, mentre Maureen guardava la famiglia che mangiava la torta da uno spiraglio fra i macchinari in acciaio inossidabile che componevano quello che veniva definito “il retrobottega”. E l’inverno finì.
Qualche tempo fa ho scritto un articolo sul Grande romanzo americano, sul fatto che non possa esistere – ovviamente – in un libro solo, ma che è composto da tanti pezzi, da romanzi (o opere complete) di alcuni autori e autrici che, libro dopo libro, hanno (e stanno) definendo il canone. Penso che ogni tanto, se siamo fortunati, arriva qualcuno che aggiunge qualcosa a quel canone scrivendo le sue schegge di Grande romanzo americano. Ocean Vuong di certo va aggiunto alla mappa, gliene siamo grati.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/