
“C’ho un morto sopra il letto a castello
E sogna guerre per salvare principesse…
Disney-Inferno è il paese dei balocchi
Dove tutto quello che tu vedi poi lo tocchi”
Rancore & Dj-Mike, Disney Inferno
di Ludovico Cantisani
Sradicatezza. Il luogo in cui siamo fino a pochi decenni fa era ricoperto da paludi – e fu proprio il Duce a bonificarle, notoriamente, retoricamente. Non è imprevedibile allora che questa sia diventata una terra di fantasmi. È una terra senza passato, senza identità, verrebbe da dire – che fugge e al tempo stesso si aggrappa al ricordo di un passato all’insegna del fascio littorio, che senza essere mai neppure accennato attraversa come simbolo irrisolto per tutta la durata del film. Le case, soprattutto, hanno qualcosa di irreale – sembrano più che altro parchi gioco in cemento per bambini che non sono voluti crescere.
Fra l’idealizzazione e la disperazione si muove questo America Latina, opera terza dei gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo dopo La terra dell’abbastanza e il premiatissimo Favolacce. Il titolo lo hanno spiegato a modo loro, come “un bellissimo Frankenstein” che “unisce l’America, che da quando siamo fanciulli rappresenta il Sogno, quello che immaginiamo, e Latina, quella terra bonificata che è il nostro contatto reale”.Il titoloAmerica Latina, allora, “è lo sposalizio tra reale e sogno”. Così tutto torna – eppure non torna niente.
La trama si aggira tra il lapalissiano e il visionario: un dentista con una famiglia e una vita all’apparenza perfette, interpretato da Elio Germano, un giorno scende nello scantinato di casa sua e scopre qualcosa che non dovrebbe esserci. Qualcosa di feroce che azzera la sua vita, la sua posizione sociale, i suoi rapporti con il resto della famiglia, composta da una moglie e due figlie oltre che da un padre lontano e assente. Fatto sta che la persona che Massimo Sisti trova legata nello scantinato resta là, e lui le fa periodicamente visita. Con tutto che è giovanissima, all’uomo non viene in mente di fare la cosa più banale di tutte: avvertire immediatamente le autorità.
La permanenza di questo segreto, nelle profondità più vicine della sua casa, lo porta però a un collasso rapido e brutale che lo induce a manifestazioni e comportamenti sempre più scomposti: solo l’affetto della sua famiglia potrà – forse – salvarlo. Adesso si capisce quel criptico “è una storia d’amore, e come tutte le storie d’amore quindi un thriller” con cui i D’Innocenzo avevano anticipato il film, qualche mese fa.
C’è una struttura che si ripete, in America Latina, e che avvicina il terzo film dei D’Innocenzo a una lunga serie di altre film e di altre narrazioni di ogni tipo, romanzi o drammi teatrali che siano. Da un punto di vista immediato, America Latina sostanzialmente riparte là dove Favolacce si concludeva: in una visione mostruosa, che corrispondeva all’immediata ma tardiva presa di coscienza degli adulti di quanto la loro vita in famiglia e tutto il loro mondo altro non fossero che una gigantesca ipocrisia. Se Favolacce si concentrava su ciò che languiva, su quanto di sospeso e tossico nell’aria si aggirava, America Latina fa deflagrare ciò che soggiace, e mostra un sottotesto archetipico ancora più profondo del precedente film.
Ciò che soggiace è ciò che viene occultato, ciò che viene insabbiato da un’ideologia della positività che è arrivata a trascendere ogni schieramento politico, ciò che soggiace è ciò che angustia e si ignora – volutamente e inconsapevolmente nello stesso momento, e questo non è un ossimoro. Ciò che soggiace è la polvere che viene nascosta sotto il tappeto, la festa di famiglia che diventa falso rito, la sessualità di coppia che diventa narcisismo monomaniaco. Ciò che soggiace è la notizia di un massacro famigliare che improvvisamente prorompe dalla voce metallica del telegiornale, tanto in Favolacce quanto in America Latina, ciò che soggiace è quanto di troppo crudo e vero per apparire – generalmente – nei film.
Quello che America Latina mette in scena non è però propriamente un ritorno del rimosso à la Freud – è un riaffiorare del nascosto, in tutta la sua scioccante essenza. Nel cinema del XX secolo, l’unico genere che davvero sa mantenere intatta quell’idea di Necessità che rendeva dirompenti le tragedie greche e il miglior teatro shakespeariano è l’horror; America Latina non è una rielaborazione di un horror o di un thriller, ma una vera e propria presa di possesso di quella che presa isolatamente potrebbe essere la situazione iniziale di un rape & revenge, o di uno snuff movie, o di un remake di Split– e poi condannarla all’immobilità, alla stagnazione, a un violento parossismo quasi beckettiano per cui quanto accade nello scantinato a lungo non ha una vera evoluzione, è il modo in cui l’incontro con la ragazzina legata si riverbera sulla vita di Massimo a mostrare un crescendo.
Del resto, quest’immobilità è ottenuta solo grazie alla problematica, paralizzante passività di questo personaggio, esistenzialmente ancora più inetto degli ignari adulti, genitori ma non padri, che facevano da sfondo a Favolacce. Aprendo una porta e scendendo una rampa di scale Massimo Sisti si trova davanti agli occhi una verità urlata, una verità che avrebbe mille volte preferito ignorare – e allora non fa nulla, ma non può più vivere come prima, questa rivelatoria apocalisse personale lo carica di un peso che sa di non poter portare.
È così che America Latina si ricollega alla struttura archetipica di un gran numero di narrazioni precedenti. Di base, è vulgata comune di tutta la teoria del viaggio dell’eroe che ogni racconto prenda effettivamente le mosse solo quando il protagonista compie il passaggio da un mondo ordinario a un mondo straordinario: solo che in America Latina questi due mondi esistono in un unico piano dell’esistenza, e l’unsuspected non tarda a contagiare e a divorare ogni quotidianità, ogni pacifica routine. Ma a ben vedere America Latina – anche nel finale – ha la stessa struttura di un film come Eyes Wide Shut di Kubrick, tanto per citare un titolo: l’improvvisa apparizione visiva, certo apocalittica e quasi teofanica da un punto di vista demoniaco, di qualcosa di nascosto tra le maglie della famiglia e della società, di qualcosa che il protagonista ignorava e avrebbe preferito continuare a non conoscere, e che invece stravolge, o rischia di stravolgere, la sua intera esistenza da cima a fondo.
Il disincanto e la delusione di fronte a tutto il grandissimo non-detto che affligge ogni rapporto umano, soprattutto se di coppia, e in generale la vita nella società, è fin troppo comune per non poter dirsi universale – ma non sono molti i film come America Latina, come Eyes Wide Shut, come Melancholiadi Trier e Sacrificio di Tarkovskijanche, o come lo stesso Morte a Venezia di Mann-Visconti per altri versi, che sanno tratteggiare con uguale precisione questo movimento di fine dell’illusione e di soffocante sorpresa che inaspettatamente accomuna il Massimo Sisti di Elio Germano con il Bill Hartford di Tom Cruise o l’Alexander di Erland Josephson.
È possibile che i maggiori punti di forza di un film siano anche gli elementi in cui si rivelano di più le sue debolezze? La scena più bella del film è anche la più brutta – quella del contrasto tra Massimo e il padre, nell’unica scena in cui il vecchio compare. La scelta di non inquadrare mai chiaramente in volto il padre, forzando l’attore alle posture più innaturali immaginabili, è una scelta di regia al tempo stesso smaccata e suggestiva, irritatamente didascalica e profondamente emozionante oltre che indicatoria dello stato pessimo dei rapporti che intercorrono tra i due uomini. La sensazione è che i D’Innocenzo, quanto più diventano consapevoli della tecnica cinematografica, tanto più rischiano di intrappolare l’immagine in una maniera un po’ hanekeniana: e se Favolacce era la sintesi perfetta tra lo stile grezzo di regia che aveva caratterizzato il film d’esordio e la ricerca di un’inquadratura che fosse saliente, le sgrammaticature di America Latina rischiano di sembrare una mera affettazione e quasi un vezzo di stile, tanto più se immediatamente seguite da altre inquadrature che sono capolavori a sé stanti di fotografia, con cui il direttore della fotografia Paolo Carnera apre intuitivamente nuove prospettiche semiotiche all’uso del colore nel cinema italiano.
Quella che al tempo stesso è la forza e il limite di America Latina, soprattutto se paragonato al precedente Favolacce premiato a Berlino, è proprio la sceneggiatura: volutamente scarna e grezza, un one-man show al posto del dualismo de La terra dell’abbastanza e della coralità del film di mezzo, che pur permettendo a Germano la sua interpretazione più sorprendente sconfina spesso in una sintesi affrettata, in una ritrattazione vorticosa di luoghi comuni che a volte è perfetta e a volte è approssimativa. Sotto ogni aspetto, nel bene e nel male, America Latina è un film “barbarico”. Inesplicabile e al tempo stesso chiarissima è la scena finale, al di qua del verbalizzabile, una sintesi di idee che solo il cinema avrebbe potuto realizzare – ma al tempo stesso, non esente da un sospetto di retorica, e di retorica della peggior specie, quella consolatoria. Forse è disseminato di simboli, o almeno di correlativi oggettivi, anche più del precessore, ma rispetto a Favolacce il nuovo America Latina è un film tematicamente molto più semplice e meno denso: viene da chiedersi che fine abbia fatto quella polistraticità semantica, quel calderone delle più disparate suggestioni che era stato Favolacce. Ed è difficile dire se America Latina rappresenti per i D’Innocenzo un esperimento di radicalizzazione, oppure la delineazione sempre più precisa di uno stile: certo sarebbe imperdonabile se, dopo aver portato una ventata di originalità nel cinema italiano, i D’Innocenzo ambissero a diventare un genere a sé stante, un aggettivo.
Con questo non si vuole affatto minimizzare la portata di originalità di America Latina, che se non altro è il film italiano più estremo degli ultimi anni, in un momento in cui produttivamente parlando gli horror sembrano non esistere in Italia, salvo rare e fortunate eccezioni. In fondo, l’aspetto migliore del film si riallaccia a quel fil rouge che di fatto collega America Latina sia con La terra dell’abbastanza che con Favolacce: il tema della paternità, una questione che nel cinema dinnocenziano si alterna e un po’ insegue la questione, altrettanto forte, di una fratellanza nel senso ampio del termine. La vacuità dei padri accomuna tematicamente tutti e tre i film: ma America Latina compie un passo ulteriore e, come presentando il film a Venezia gli stessi D’Innocenzo avrebbero dichiarato in conferenza stampa, il vero argomento di fondo del film è la crisi del maschio, del maschile, della mascolinità.
Questo è un tema onnipresente ormai nella letteratura, ma che il cinema e soprattutto il cinema italiano continuava a bypassare, ancora legato più di quanto si vorrebbe credere a una concezione scemotta del protagonista, dell’”eroe”: i D’Innocenzo lo prendono di petto, e oltre a contrapporre (e a ricongiungere) il personaggio di Massimo a quelli delle tre donne di casa, la moglie e le due figlia quasi angeliche nel loro vestiario, tracciano un’implicita ode alla vulnerabilità maschile che rischia di non essere colta nella rapida successione di immagini che chiudono il film. Per la forza morale nel ritrarre la violenza in maniera esplicita, per la precisione con cui delineano il disagio di certe periferie e certi entroterra, e soprattutto per questa problematizzazione del maschile anche e soprattutto nei suoi attimi più violenti e aggressivi, America Latina di Fabio e Damiano D’Innocenzo può ricordare anche un romanzo come La città dei vivi di Nicola Lagioia, un’altra narrazione incentrata su ciò che soggiace, al di sotto dell’Urbe, di ogni subcultura androcentrica, di un certo concetto malato di virilità e del rapporto perennemente irrisolto che l’Italia ha con la mobilità sociale. È così che il terzo film dei D’Innocenzo, facendosi forza sulle sue stesse innegabili imperfezioni, riesce ad essere ciò che Favolacce già era: radicale, rivelatorio, e, in fin dei conti, anche rivoluzionario.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






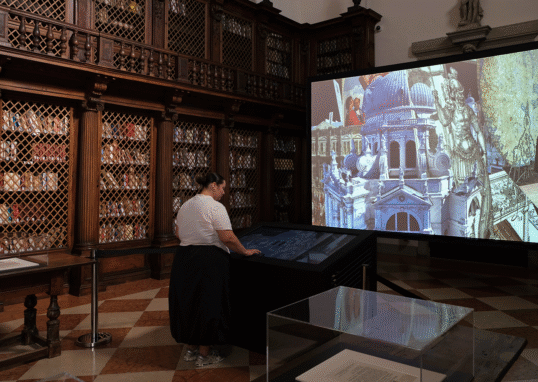
Per cortesia, adesso basta.