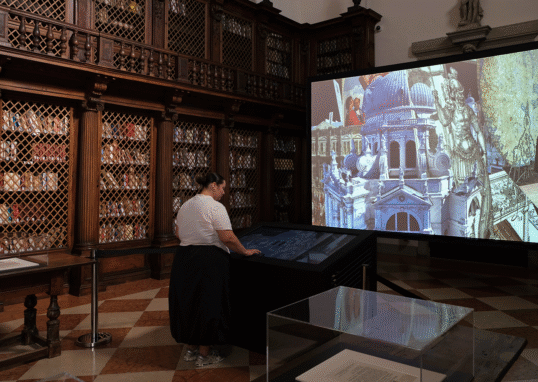di Rosario Sparti
Il Bergamo Film Meeting ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante per un festival che nel tempo ha definito la sua identità pur sapendosi rinnovare, senza mai rinunciare alla propria vocazione di manifestazione dedicata alla scoperta delle nuove tendenze del cinema europeo e la salvaguardia del cinema d’autore. Dopo due edizioni virtuali quest’anno il BFM ha potuto celebrare la ricorrenza con il ritorno in presenza, offrendo al pubblico per nove giorni – dal 26 marzo al 3 aprile 2022 – un ricco programma che, come da tradizione, ha bilanciato con sapienza passato e presente. In occasione di questo anniversario lo storico festival cinematografico ha dedicato una retrospettiva completa al regista Costa-Gavras, un omaggio che ha ripercorso le tappe di una filmografia arricchita da premi internazionali: basti citare l’Oscar per il miglior film straniero vinto con Z – L’orgia del potere nel 1970, la Palma d’Oro per Missing – Scomparso nel 1982 e l’Orso d’oro per Music Box – Prova d’accusa nel 1990.
«Nome, cognome e professione», questa la formula di rito che Jean-Louis Trintignant nel ruolo di un integro magistrato declamava in modo sistematico durante l’interrogatorio al centro del film Z – L’orgia del potere (1969), il coraggioso racconto della Grecia all’indomani del colpo di stato dei colonnelli che ha portato il regista alla ribalta mondiale. Ponendo quelle semplici domande all’autore della pellicola però si rischierebbe di avere una sorpresa: se il suo mestiere è comprovato dalla ventina di film che ha realizzato durante la carriera, lo pseudonimo di cui ha scelto di servirsi nasconde le sue radici. Dietro il suo nome d’arte infatti si cela l’identità di un giovane greco, Kōnstantinos Gavras, nato nel 1933 in un villaggio del Peloponneso, Loutra Heraias, costretto ad abbandonare il suo paese a causa del passato politico della sua famiglia. A ventidue anni Costa- Gavras per proseguire gli studi decide di trasferirsi a Parigi, frequentando prima la Sorbona e poi l’IDEHC, dove incomincia un percorso nel mondo del cinema che lo porterà persino a ricoprire il ruolo di presidente della Cinémathèque Française .
Ma il nome di Costa-Gavras richiama subito alla mente i film d’impegno civile che fecero scalpore durante gli anni ’70, testimonianza della temperie politica dell’epoca, scaldando gli animi degli spettatori che popolavano quei luoghi di eroici fuori dialettici e interminabili dibattiti – sì, il dibattito sì – chiamati cineforum. In realtà tutta la produzione di questo autore è una lucida testimonianza sulle contraddizioni sociali e storiche di paesi vicini e lontani come Stati Uniti (Betrayed – Tradita), Francia (L’affare della sezione speciale), Cile (Missing – Scomparso) Uruguay (L’Amerikano), Cecoslovacchia (La Confessione), Israele e Palestina (Hanna K.). Mentre nella sua patria registi quali Theo Angelopoulos, Yiorgos Stamboulopoulos, Dimos Theos e Pantelis Voulgaris mettevano in scena in chiave allegorica la realtà politica della Grecia, Costa-Gavras dalla Francia allargava il suo sguardo al panorama internazionale documentando in tempo reale la brutale e tragicomica violenza esercitata dalla commedia del Potere. Abbiamo approfittato della sua presenza al festival bergamasco per conversare con questo giovane ottantanovenne di grande eleganza e velocità di pensiero, ancora pronto a indignarsi e resistere di fronte alle ingiustizie del nostro tempo.
Ci racconti il giovane Costa-Gavras.
In Grecia a causa delle accuse politiche rivolte a mio padre – da antimonarchico aveva partecipato alla Resistenza insieme ai comunisti – non potevo iscrivermi all’Università, così decisi di mettere da parte un po’ di soldi e andare in Francia dove avrei potuto studiare gratuitamente. Di quei giorni a Parigi ricordo soprattutto il senso di libertà, la meraviglia di scoprire un modo nuovo di vivere. Anche un modo nuovo di guardare al cinema, infatti frequentando la Cinémathèque rimasi sorpreso da pellicole molto lontane dai film di genere che vedevo al mio paese. La passione per il cinema è nata lì.
Ha iniziato a lavorare nel cinema come assistente alla regia per cineasti come René Clair, Henri Verneuil, René Clément o Jacques Demy.
Ho avuto una grande fortuna. Per me è stato come andare all’università, una sorta di università del cinema in cui apprendere in modo differente come funziona il lavoro del regista. Ognuno di loro aveva uno stile diverso e ti insegnava dal punto di vista tecnico qualcosa di nuovo. All’epoca la tecnica cinematografica aveva una grande importanza, ora è tutto più semplice, e poi c’era tutto quel che riguardava la direzione degli attori, che era e resta fondamentale se si vuole diventare buoni registi. Grazie a loro ho imparato ciò che è l’essenza di questo mestiere: come raccontare una storia attraverso le immagini.
Su quei set ha conosciuto Simone Signoret e Yves Montand, una coppia d’attori centrale nella sua carriera. È vero che l’hanno aiutata a diventare regista?
Ero in attesa di lavorare di nuovo con Clément quando ho letto un libro, Vagone letto per assassini, e ho pensato di adattarlo per il grande schermo. Più che altro voleva essere un esercizio di scrittura, ma un produttore ha letto quella sceneggiatura e mi ha chiesto di farne un film. Ho capito che forse poteva essere il modo migliore per iniziare, quello più rapido. A quel punto ho contattato la mia amica Simone Signoret per chiederle di far leggere il copione a sua figlia Catherine, che avrei voluto nel cast come protagonista, tuttavia con mia grande sorpresa è stata proprio lei a proporsi come attrice. Era un piccolo ruolo ma le era piaciuta la sceneggiatura. Poco dopo mi ha contattato Yves Montand e mi ha detto: «Simone mi ripete che hai scritto una buona sceneggiatura, c’è una parte per me?» Conoscevo molti attori all’epoca grazie al mio lavoro come assistente, però sono rimasto sbalordito quando tanti di loro mi hanno cercato per proporsi anche solo per comparsate. È stata un’occasione unica e imprevista.
Il film fu un successo.
Con quel cast è stato tutto più facile. Aprirei una parentesi: in Francia all’epoca facevano film solo i registi francesi, non era così usuale che lavorassero registi stranieri. Che si trattasse di vecchi maestri o “giovani turchi” il cinema francese era appannaggio della borghesia francese. Non pensavo infatti che avrei esordito nella regia così velocemente, d’altronde se avessi potuto iniziare in libertà probabilmente avrei esplorato altri territori, altre situazioni, guardando a quello che accadeva nel cinema italiano dell’epoca.
Senz’altro lei è molto legato al cinema italiano, dal neorealismo alle opere “politiche” di Elio Petri, Francesco Rosi e Gillo Pontecorvo. Con quest’ultimi ha condiviso anche lo sceneggiatore Franco Solinas, con cui ha stretto un fortunato sodalizio a partire da L’amerikano (1972).
Abitualmente io lavoravo con Jorge Semprùn e volevo continuare con lui, ma in quel periodo stava scrivendo un romanzo e mi ha chiesto una pausa di sei mesi. Non mi andava di attendere tutto quel tempo, volevo iniziare a lavorare subito al film e così ho chiamato Solinas che mi piaceva molto per quello che aveva fatto in precedenza. Abbiamo scritto insieme quattro film: due sono stati realizzati da me, uno da un altro (Mr. Klein diretto da Joseph Losey, N.d.A.) e uno è rimasto sulla carta.
Sta parlando del film che negli anni ‘80 aveva catturato l’attenzione di Robert Redford, Il Cormorano?
Abbiamo impiegato due anni e mezzo per sviluppare quel progetto, Robert Redford era interessato ma alla fine ha deciso di abbandonarlo. Il finale gli sembrava troppo cupo. Era una storia che in qualche modo parlava del nostro presente, del ruolo che oggi hanno le grandi compagnie internazionali. All’epoca le multinazionali non avevano questa forza economica però arrivavano comunque in tutto il mondo, controllavano un paese e ne cambiavano la produzione. Si intitolava Il Cormorano, come l’uccello predatore addestrato dagli uomini per catturare i pesci; secondo una vecchia tradizione i pescatori erano soliti applicare un anello alla base del collo di questi uccelli per evitare che ingoiassero i pesci più grandi e riuscissero a mangiare solo quelli piccoli. Le grandi compagnie usano la gente alla stessa maniera.
Sono le stesse accuse al neoliberismo che ha lanciato più di recente in Le Capital (2012) e Adults in the Room (2019).
Grazie all’attrattiva delle azioni, del denaro facile, le banche attirano le persone e poi le sfruttano. Li fanno contenti dandogli i pesci piccoli, ma quando il cormorano non porta più grandi pesci o si toglie l’anello dalla gola allora cambia completamente la propria vita.
Il suo lavoro è ancorato al valore della comunità. Si potrebbe dunque parlare di cinema civile in cui l’individuo e la polis condividono un destino comune.
L’uomo è un animale politico, lo sappiamo: vive nella società, dove vivono altri uomini come lui. Il cinema deve per forza parlare dell’uomo e dei suoi problemi, altrimenti non avremmo voglia di vedere un film.
In una vecchia intervista affermava che «la storia è cambiata radicalmente con il crollo del blocco sovietico, le dittature non sono più le stesse». Oggi che aspetto hanno le dittature?
Le dittature politiche purtroppo sono presenti ancora in certi paesi arabi o asiatici. Esistono però “dittature” anche nel nostro mondo libero: sono le grandi multinazionali cui accennavo prima, i giganti dell’Information Technology che non pagano le tasse che dovrebbero; hanno accumulato delle fortune smisurate e possono intromettersi nella vita degli Stati come desiderano. Grosse imprese come queste, dirette da piccoli gruppi, si sono inserite nella nostra società e impongono la loro opinione. Gli Stati si indeboliscono sempre di più e le grandi società prendono sempre più potere. Questo nuovo tipo di dittatura è all’interno delle nostre società, che si vantano di essere libere e democratiche.
Se parliamo di manipolazione un ruolo rilevante è quello esercitato dai media. Già in Mad City – Assalto alla notizia (1997) lei si preoccupava del loro potere falsificatorio, certamente accresciuto nell’epoca delle cosiddette fake news.
In Francia ci sono alcuni programmi di informazione che guardo spesso. Per esempio l’altro giorno c’era un uomo che parlava e la didascalia recitava “consigliere del presidente Putin”, ma man mano dalla trasmissione è emerso che era un economista che faceva parte del governo russo. In realtà erano due persone differenti. Ecco, questo è un esempio di manipolazione. Più che altro si insegue una sempre crescente spettacolarizzazione delle notizie, si vuole avere sempre maggiore drammaticità. Si ha la necessità di costruire un cattivo per il pubblico, è evidente che quello che sta facendo Putin è spaventoso ma bisognerebbe cercare di andare più in profondità nell’analisi del problema.
Francesco Rosi diceva che «una cosa è la realtà, un’altra è la verità». Come si costruisce la verità cinematografica?
La verità è il mio punto di vista. La verità non è oggettiva, non è un obiettivo da inseguire, è legata al pensiero personale del regista senza che si atteggi da filosofo, da saggio; non bisogna porsi al di sopra degli spettatori. Bisogna poi vedere se il pubblico crede o meno a quello che si racconta, ma questo è un discorso differente. Quando ho girato film basati su personaggi reali sono stato attento a rispettare le loro peculiarità, senza cedere a stereotipi per rendere il tutto più facile nella drammatizzazione. Non si può scegliere di fare ciò che si vuole solo in nome dello spettacolo.
Il delicato equilibrio tra tensione spettacolare e rigore documentario è la cifra del suo stile. In tal senso gioca un ruolo primario il montaggio, non solo in termini di ritmo ma anche di rapporto tra immagini: come lo stacco tra i rastrellamenti della polizia e l’interrogatorio in Z – L’orgia del potere, oppure la contrapposizione tra l’inquadratura del palazzo del governo e il cimitero zeppo di nuove tombe in L’amerikano.
Un film nasce sempre sotto forma di sceneggiatura, infatti quando giro cerco di rispettare quello che ho messo su carta ma è nel momento successivo, al montaggio, che il film prende veramente forma e si giunge a decisioni definitive. È una seconda scrittura, per questo lavoro ogni giorno al montaggio per dare una forma nuova a quanto ho girato. La mia generazione ha capito bene le enormi potenzialità che il montaggio può offrire.
In molti dei suoi film è presente l’umorismo, magari in veste nera o grottesca, eppure si tende a dimenticarlo.
Noi facciamo cinema non per discorsi accademici ma per fare spettacolo. E la risata è un elemento importantissimo dello spettacolo così come nella vita, proprio per questo sfrutto l’umorismo per avvicinare quanto racconto allo spettatore. Spesso in situazioni drammatiche ci troviamo a scoprirne un lato buffo, che emerge spontaneamente, non è costruito, ed è quello che cerco di fare anche io nei film. A volta la situazione consente di far emergere questi due aspetti apparentemente opposti. È un rischio che si può correre anche decidendo di utilizzare attori comici in controruolo, osando andare contro la percezione del pubblico, come nel caso di Le Capital in cui ho scelto Gad Elmaleh per un ruolo drammatico.
È quello che già aveva fatto in maniera eccellente con Jack Lemmon in Missing – Scomparso.
Molti attori comici hanno notevoli qualità drammatiche se accettano di cambiare, di mettersi in discussione. Jack Lemmon aveva già messo in mostra queste sue qualità con Billy Wilder in L’appartamento, che è certamente una commedia ma se vista da un’altra prospettiva invece può apparire come una tragedia. Ho dovuto lottare con i produttori per averlo, ma lui ha dato credibilità al film e il pubblico è stato disposto a seguirlo.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente