
Questo articolo è uscito su Artribune.
Come era accaduto nel sorprendente Warrior (2011) di Gavin O’Connor, anche con Cogan-Killing Them Softly di Andrew Dominik (basato sul romanzo Cogan’s Trade di George V. Higgins) il cinema di genere si dimostra il più adatto a ritrarre il tempo oscuro della crisi, molto più per esempio dei tentativi puramente didascalici e descrittivi che negli ultimi anni hanno cercato di prendere di petto la questione “dall’alto” (l’ultimo in ordine di tempo: Margin Call di J.C. Chandor). Questo è forse uno di quei casi in cui le strategie di ‘aggiramento’, per così dire, di un tema cruciale funzionano meglio e si dimostrano più efficaci: finora, sono ancora molto rari – sia nel cinema hollywoodiano, che in quello indipendente, che in quello occidentale in genere – gli esempi di rappresentazione della crisi nelle sue conseguenze dirette e profonde sul tessuto del quotidiano e sulla vita collettiva in grado di fuoriuscire dalle convenzioni stilistiche degli ultimi vent’anni.
D’altra parte, il noir fin dalle sue origini letterarie – esattamente coincidenti con l’inizio della Grande Depressione (Red Harvest di Dashiell Hammett fu pubblicato proprio nel 1929) – è strettamente connesso all’esigenza di ritrarre crudamente la realtà sociale attraversata dal disagio, e calata nella dimensione della città e delle relazioni umane che si sviluppano: la crime story, cioè, è quasi un pretesto per l’indagine sociologica e antropologica, condotta con i mezzi narrativi.
Cogan, fin dalle scene iniziali, introduce lo spettatore in un paesaggio urbano devastato, immerso in una luce lattiginosa e sporca, e punteggiato da case abbandonate che sembrano uscite dritte dalle foto di Walker Evans; di riflesso, lo scenario umano che emerge dai dialoghi (e qui la matrice tarantiniana sembra come abrasa e disciolta negli echi di Faulkner e di Steinbeck) fatto di disoccupazione, desolazione, frustrazione e assenza di prospettive. L’epoca in cui la vicenda si svolge è l’inizio ufficiale della crisi economica, quel settembre-ottobre 2008 che vedeva in contemporanea la campagna elettorale per le presidenziali americane e il salvataggio periglioso – ancora non illuminato, peraltro, da un racconto minuzioso e veritiero.
Il collegamento tra i due livelli – la grande economia e la vita di strada – è affidato al continuo contrappunto dei discorsi dei candidati alla presidenza (Obama e McCain), e soprattutto del chiacchiericcio mediatico dei commentatori, che accompagna lo svolgersi della vicenda. Questo contrappunto ha un doppio ruolo: da una parte (didascalica) illustra bene come le due dimensioni presentano il medesimo funzionamento interno, e le stesse disfunzionalità; dall’altro (molto più interessante) dimostra la totale inadeguatezza del discorso pubblico istituzionale ad arginare lo squallore dell’esistenza quotidiana in questi luoghi emblematici. La politica è rumore bianco, non intrattiene più alcun rapporto con le azioni e le decisioni di questi individui, così come dei criminali che giocano nella bisca clandestina di Markie Trattman (Ray Liotta) e che vengono rapinati dai due balordi. La politica non tranquillizza né agita: è presente, ma fondamentalmente estranea, e inutile.
In questo contesto, Jackie Cogan (Brad Pitt), killer freddo e umano al tempo stesso – una sorta di Rick Deckard calato invece che nella Los Angeles del 2019 in un universo narrativo post-Soprano, che non conserva quasi nulla della residua grandezza di Tony (anche James Gandolfini è presente nel film, nel ruolo di Micky, il secondo assassino) – si presenta come il “risolutore” per eccellenza, il perfetto pacificatore. Cogan è guidato da una filosofia estremamente pragmatica, e da un solido sistema di riferimenti. Ciò che lo contraria maggiormente è il relazionarsi con un mondo criminale che pretende di applicare una mentalità aziendale persino alle sue faccende, saltando a pié pari le soluzioni ‘dure’ ma necessarie, il metodo essenziale ma funzionale della “vecchia scuola”. Mentalità aziendale vuol dire, di fatto, deresponsabilizzazione (individuale e collettiva): è questa la disfunzionalità principale.
Cogan ci sta dicendo che gran parte dei problemi non solo dei piccoli criminali con cui ha a che fare, ma dell’intero mondo occidentale (ad ogni livello, e in tutti i settori) dipendono e discendono da essa; un sistema di valori fondato sulla delega costante, sul rinvio perenne, sulla non-decisione e sulla rimozione dei rapporti diretti – anche, e soprattutto, di dominio – non può che crollare: “questo mondo è fottuto: sta arrivando la peste”.
Il ruolo e il destino di Cogan è quello di riportare un po’ di concretezza, un po’ di durezza, un po’ di responsabilità in questo mondo scombinato.
Christian Caliandro (1979) è storico, critico d’arte contemporanea e curatore. Insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Tra i suoi libri: La trasformazione delle immagini. L’inizio del postmoderno tra arte, cinema e teoria, 1977-‘83 (Mondadori Electa 2008), Italia Reloaded. Ripartire con la cultura (Il Mulino 2011, con Pier Luigi Sacco), Italia Revolution. Rinascere con la cultura (Bompiani 2013), Italia Evolution. Crescere con la cultura (Meltemi 2018), Tracce di identità dell’arte italiana. Opere dal patrimonio del Gruppo Unipol (Silvana Editoriale 2018), manuale Storie dell’arte contemporanea (Mondadori Education 2021) e L’arte rotta (Castelvecchi 2022). Dirige la collana “Fuoriuscita” per l’editore Castelvecchi. Dal 2004 al 2011 ha diretto le rubriche inteoria e essai su “Exibart”; dal 2011 cura la rubrica inpratica su “Artribune”. Collabora inoltre con “minimaetmoralia” e “che-Fare”, e dal 2017 dirige insieme a Angela D’Urso La Chimera–Scuola d’arte contemporanea per bambini presso TEX, ExFadda, San Vito dei Normanni (BR). Ha curato numerose mostre personali e collettive in spazi pubblici e privati, tra cui: The Idea of Realism/L’idea del Realismo, American Academy in Rome, Roma (2013); Concrete Ghost/Fantasma Concreto, American Academy in Rome, Roma (2014); Amalassunta Collaudi, Museo Licini, Ascoli Piceno (2014); Sironi-Burri: un dialogo italiano (1940-1958), CUBO-Centro Unipol Bologna (2015); Cristiano De Gaetano: Speed of Life, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (2017); Now Here Is Nowhere. Six Artists from the American Academy in Rome, Istituto Italiano di Cultura, New York (2017); le quattro edizioni de La notte di quiete, ArtVerona, Verona, quartiere Veronetta (2016-2019); le sei edizioni del progetto Opera Viva Barriera di Milano, Flashback, Torino (2016-2021); il progetto Artista di Quartiere, Torino (2020); Z/000 GENERATION. Artisti pugliesi 2000>2020, AncheCinema, Bari (2020); Fragile, galleria Monitor, Roma (2021); Cantieri Montelupo, programma di residenze artistiche, Museo della Ceramica, Montelupo Fiorentino (2021).






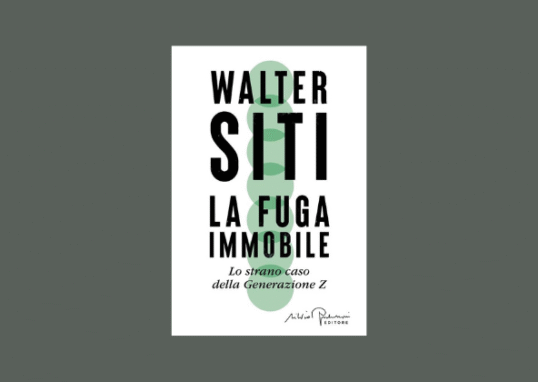
Sì, sono d’accordo che proprio il noir si presti meglio di qualsiasi altro genere, a raccontare la nostra realtà… Il post-crisi, la depressione della precarietà… però, una volta tanto, vorrei vedere superato l’ormai superato (e tanto visto…) cliché tarantiniano, le foto di Walker Evans… e vedrei volentieri Rick Deckard catapultato in una Milano, livida e lattiginosa, certo, ma reale e presente… magari a fare il giudice o il PM…