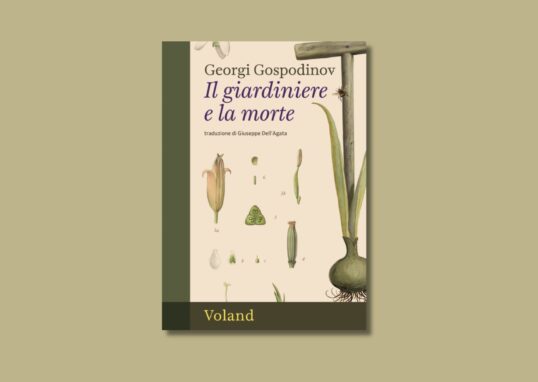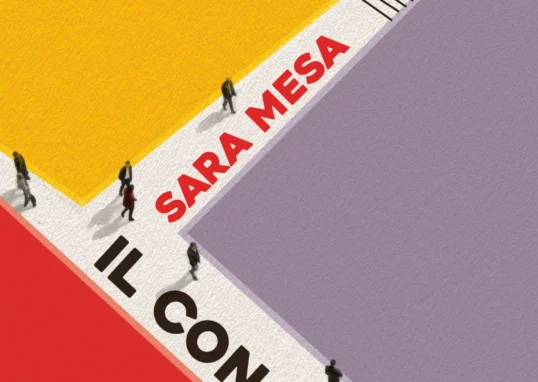Pubblichiamo un articolo di Francesco Pacifico, uscito su «IL», su «Chimurenga», il «New Yorker» africano.
Il centro di Città del Capo sembra concepito apposta per ignorare la periferia. È abbracciato e protetto da due montagne: l’alta e piatta Table Mountain, e una collina con cucuzzulo che sull’altro fianco guarda il mare e il quartiere bianco e ricco di Sea Point. Nascosta da questi paraocchi naturali, e da un breve muro di grattacieli, è la distesa suburbana che contiene quel che fino al ’94 furono le tre classi-razze segregate: cinque milioni di neri, coloureds, e asians.
In Long Street, la via principale del centro, lo stile sinistramente familiare dei bassi palazzi coloniali, con i loro portici di colonne di legno snelle e avvitate, estetizza perennemente il passato ipnotizzando il turista, facendogli dimenticare la distesa di lamiera degli slums intravista lungo la superstrada venendo dall’aeroporto. Long Street di giorno è trafficata e indaffarata; la sera, dai balconi dei palazzi esce la musica dei locali a un volume che non ho mai sentito altrove, così alto da mettere a disagio.
E in Long Street ha la sua redazione una rivista letteraria panafricana in lingua inglese, Chimurenga, nata dieci anni fa per provare a unire, con il racconto, il reportage e la poesia, la vita intellettuale bianchissima e filobritannica del Sudafrica e quella del continente nero.
Sedici numeri dopo, nel 2011, la redazione di Chimurenga decide di uscire dall’ambito ristretto della rivista letteraria per costruire un numero speciale: un quotidiano di 128 pagine, il “Chimurenga Chronic”, composto, in stile anglosassone, da una mazzetta con le diverse sezioni affastellate, più un magazine di lifestyle di 40 pagine e un inserto dedicato ai libri. Ma l’aspetto geniale di quest’unico numero di un quotidiano immaginario, è che è datato 18-24 maggio 2008. E di quella settimana parla, come un romanzo storico postmoderno, cubista, composto di frammenti.
Il maggio del 2008 non è un mese qualunque per il Sudafrica: dopo dieci anni di sporadiche violenze xenofobe, segno del persistere dell’odio razziale anche dopo la fine dell’Apartheid nel 1994, in diverse città del paese i sudafricani, esasperati dall’abbondanza di crimine e disoccupazione, attaccano gli immigrati africani, facendo decine di feriti e due vittime. In questo romanzo fantasma di una settimana, attraverso la moda, il costume, l’economia, lo sport, le recensioni dei libri, la redazione di Chimurenga cerca di fare ciò che i quotidiani di regola non fanno: raccontare con distacco e profondità, senza sensazionalismi, lo stato di un paese e di un continente in un momento significativo della sua storia.
Chimurenga vuol dire lotta. È una parola ereditata dalle insurrezioni antibritanniche dello Zimbabwe alla fine dell’ottocento. Qui però si parla di una lotta intellettuale: quella avviata a inizio secolo dall’immigrato camerunense Ntone Edjabe. Arrivato a Cape Town negli anni novanta, Edjabe fonda prima il Pan African Market, un centro culturale per migranti africani, quindi, nel 2002, la rivista e la piccola casa editrice, per dare voce agli scrittori di tutta l’Africa e provare a creare un mercato che non miri solo alla cooptazione da parte del mercato culturale angloamericano.
La redazione occupa una grande stanza al terzo piano del Pan African Market. Il centro culturale è però anche letteralmente un mercato per artisti e artigiani. Quando un artista africano arriva a Cape Town può venire qui a stringere contatti.
Io a Cape Town ci arrivo in un mattino d’estate, a metà febbraio, e trovo tutti i redattori tranne Ntone. Ma non importa, perché se lo scopo è capire e raccontare cos’è una rivista panafricanista in una città ancora divisa razzialmente, già mi basta come sfida e rompicapo esaminare le quattro persone che mi trovo davanti.
Graeme Arendse ha trentasei anni ed è coloured, misto. È nato da famiglia del ceto medio e cresciuto a Cape Town. Ha un accento che non ho mai sentito, un improbabile misto di nordeuropeo e indiano. I coloured, mi dice, stanno di solito tra lower middle class e middle class. “Non sono andato all’università. Ma ho avuto la possibilità. Mio fratello ha fatto graphic design, anche se adesso è un insegnante di fitness. Io qui sono designer, art director, poeta”.
Liepollo Rantekoa ha ventotto anni, si occupa della produzione, è nera, benestante, viene dal Lesotho. “Sono una migrante economica. Il Lesotho è un paese piccolo dentro il territorio sudafricano. Sono andata in collegio in Sudafrica. In una scuola cristiana… Con ciò che ne consegue: sono finita a giocare a hockey e squash”.
Insomma, le dico, sei bianca quanto Stacy.
Stacy Hardy, l’unica bianca della redazione, commenta: “Mi sa che è più bianca lei di me: è andata a una scuola privata! Io a una scuola pubblica”.
Liepollo è una nera privilegiata e ha una storia interessante: “La Free State Province, dove stava il collegio, è davvero Afrikaans quindi lì ciò che è inglese e femminile è privato. Enclosed. Andando al colloquio per farmi accettare nel collegio, mia madre mi ferma contro il muro e mi fa: Usa il nome Jocelyn, d’ora in poi, così la gente saprà pronunciarlo. Avevo otto anni. Dopo il liceo ho smesso e ho ricominciato a usare Liepollo. Ero in fase Fight against the machine, bla bla bla. Perciò sono venuta a Cape Town. Perché la sapevo più liberale, aperta. Sono venuta alla University of Cape Town, per studiare ragioneria. In quell’epoca se eri nera e donna in Sudafrica ti dicevano di fare ragioneria o medicina o ingegneria, per guadagnare l’indipendenza e sistemarti. Poi ho smesso, perché non volevo sentirmi dire cosa fare. Ho fatto sociologia. E poi sono finita volontaria qui a Chimurenga, e ora sono a tempo pieno e pagata”.
Teresa Ayugi si occupa dell’amministrazione. È kenyota, si è trasferita qui dieci anni fa. Il padre insegnava all’università e le disse di raggiungerlo. In Kenya, Teresa lavorava per una società telefonica. Qui ha studiato, ha lavorato nelle risorse umane per una ditta di vestiti, poi è passata a Chimurenga.
Infine c’è Stacy Hardy. Stacy è bianca ed è l’unica fra i quattro collaboratori fissi di Ntone Edjabe a non avere lo stipendio. “Sono volontaria: ho uno sugar daddy che mi mantiene”. Risate. Le risate fra noi sono molte, mentre cerco di farmi un quadro sociale della redazione: le risate accompagnano ogni scomodo tentativo di collocare uno di loro sugli assi di razza e ricchezza. Cos’è uno sugar daddy?, chiedo.
“Ho un compagno con uno stipendio, e mi permette di lavorare gratis. È editor di Rolling Stone South Africa. Lavoro anche per conto mio, scrivo racconti e sceneggiature, e faccio digital art. Sono cresciuta a Pietersburg nell’ex provincia del Transvaal. I miei genitori sono i classici pinko liberals: bianchi, liberali, ceto medio, ci piacciono i neri e ci piacerebbe che avessero potere, ma non vogliamo rinunciare a nulla di ciò che abbiamo. Sono andata alla scuola pubblica, ma una buona. Bianca, quindi per definizione ok. Sono andata all’università con borse di studio. Ho insegnato lì. Poi sono venuta a Cape Town”.
I complessi legati alla razza rimangono: come mai Stacy è l’unica che non chiede uno stipendio a Chimurenga?, penso fra me.
Stacy mi dice: “Se devo essere onesta, uno dei motivi per cui qui lavoro gratis è che a livello personale per me è faticoso essere bianca sudafricana. Tutto ciò che hai è fondato sul sangue degli altri. Vengo da una famiglia, ok non ricca, ma mai un problema di cibo, sono stata all’università, ho avuto di che vestirmi. E solo perché altri hanno sofferto. I nostri privilegi sono il risultato di una eredità di oppressione. Per me poter essere onesta a riguardo è importante”.
È un tema ineludibile, che il buon umore generale dei redattori ha permesso di trasformare in commedia in una pagina del Chimurenga Chronic: con l’intestazione Servizio Fiscale Nazionale, un elenco ministeriale su sfondo malva stabilisce le linee guida per calcolare in Rand la “Guilt Tax”: la tassa sul senso di colpa per essere ricchi. Il paniere contiene il numero di camere della propria casa, i titoli di studio, l’appartenenza a un circolo del golf, l’automobile e l’inevitabile piscina.
Il Chimurenga Chronic, irripetibile sforzo produttivo che mescola reportage, immaginazione e ottimo design, si gioca tutto nei dettagli, nei livelli metanarrativi, nell’accumulo spropositato di materiale. Al punto che, anche se ci fosse, sarebbe difficile trovarne l’ideologia.
Stacy: “Non c’è ideologia, ma c’è un credo: per muoverci oltre la visione tribale e statale e unire culturalmente l’Africa dobbiamo cercare qualcosa di più grande: un mondo panafricano in cui colleghiamo gente di luoghi e propositi diversi. Uniti da un desiderio di libertà e liberazione”.
Graeme: “Abbiamo delle ideologie da cui partire, che ci hanno ispirati. La Black consciousness. E il panafricanismo novecentesco. Però non sono punti in cui siamo radicati. Volevamo solo partire da lì.
Cosa rifiutate della black consciousness per andare avanti?
Stacy: “Vogliamo levare il black. Levare il colore. E la black consciousness era sessista, maschilista. Il numero di donne che vedi qui in redazione già ti dà un’idea…”
Liepollo: “Biko [fondatore del Black Consciousness Movement, negli anni Settanta, NdR] non pensava che la black consciousness sarebbe rimasta ferma. Serviva in quel momento ma si sarebbe evoluta”.
Graeme: “Biko l’ha detto chiaramente: è nera perché risponde a un’oppressione bianca. Ma come le cose evolvono, il nero sparisce. L’idea di base è il credere in sé e nel proprio valore, quello è il nocciolo della conscienza”.
Dieci anni fa, mi raccontano, non c’era un posto per publicare scritti africani per africani da un editore africano. Nell’inserto sui libri del Chimurenga Chronic, c’è un pezzo sul problema degli scrittori africani che vogliono affermarsi solo per un pubblico bianco occidentale, e finiscono invariabilmente a insegnare al “nord”, in occidente, ritrovandosi poi disseccata l’ispirazione.
Graeme: “Prima di Chimurenga c’era stato un altro tentativo: la sezione arte e cultura del quotidiano Cape Times. Ma loro si resero conto di quanto fosse bianca la scena liberal, di quanto non fosse interessata a temi africani”.
Stacy: “Alcune pubblicazioni erano estremamente bianche e si conducevano come fossimo una colonia della Gran Bretagna. Pubblicavano scritti bianchi, si occupavano di logiche del Nord. La televisione era solo internazionale. Non si occupavano per niente dell’Africa. Neanche nel giornalismo. In Sudafrica nessuno imparava niente. A scuola neanche”.
Graeme racconta come ha partecipato alla nascita di Chimurenga. “Non avevo idea di cosa sarebbe venuto fuori. Ci vedevamo qui al Pan African Market. Era un luogo centrale, in quegli anni”.
Il Pan African Market era il solo posto dove potevano incontrarsi i migranti africani. È diventato un posto iconico. Cape Town resisteva alla migrazione africana, quindi non c’erano molti posti per incontrare africani. Il Sudafrica ha la più grande popolazione di rifugiati del mondo, ma il centro di Cape Town è rimasto bianco”.
In effetti, di nero in centro si notano soprattutto mendicanti e tassisti. E come dicevo, è facile ignorare il resto della città: tanto che al mio arrivo ho visto solo questo paradiso fra le due basse montagne; soltanto la sera, su una tangenziale, andando al quartiere residenziale Observatory, dove Chimurenga gestisce un locale di musica dal vivo, il Tagore’s, mi si è spalancata sulla sinistra la sprawl, la distesa suburbana, un lago di luce, e ho capito che Cape Town è una metropoli che cerca di spacciarsi per town.
Chimurenga ambisce a un’ampiezza analoga, e perciò non è solo una rivista. Oltre ai libri che pubblica, ha creato una biblioteca online che raccoglie e diffonde una rete di pubblicazioni africane”. Nel retro del Tagore’s, infine, una stanza a cui si accede da un cortile ospita la Pan African Space Staion, una webradio (panafricanspacestation.org.za).
Per Liepollo, arrivata dal Lesotho e dal suo collegio inglese ricco e protetto in una città troppo divisa, Chimurenga è stata una boccata di aria fresca. Stacy rende bene l’idea: “Cape Town è tutta frammentata in scene microscopiche. Noi siamo la sola città del mondo in cui perfino i rastafariani sono divisi per razza”.
Francesco Pacifico è nato a Roma nel 1977, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Il caso Vittorio (minimum fax), Storia della mia purezza (Mondadori) e Class (Mondadori). Ha tradotto, tra gli altri, Kurt Vonnegut, Will Eisner, Dave Eggers, Rick Moody, Henry Miller. Scrive su Repubblica, Rolling Stone, Studio.