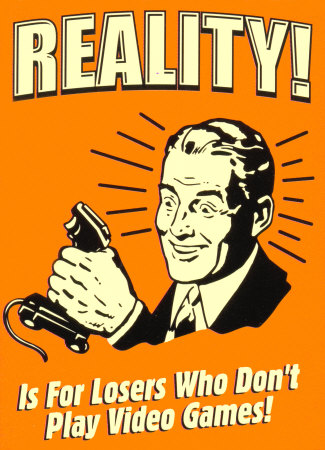
Qualche mese fa ero a un incontro di aggiornamento per gli insegnanti di materie umanistiche nel liceo. In una sala convegni gigantesca, eravamo in seicento a sentire Guido Baldi del famoso manuale Giusso-Baldi, che discettava su come insegnare meglio letteratura al liceo: usate la narratologia, esortava, educate secondo una didattica strutturalista “questi ragazzi di oggi che non leggono niente, non sanno nulla e stanno tutto il giorno a rincretinirsi coi videogiochi”. A quella sala d’insegnanti che applaudivano in modo sperticato Baldi, ben contenti di sentirsi superiori moralmente ai ragazzi di oggi che spendono centinaia d’ore davanti a una consolle, vorrei dedicare questa piccola recensione del migliore saggio di poetica (ossia, se vogliamo, dell’arte di inventare mondi) che ho letto quest’anno – un libro che non soltanto è capace di aggiornare meglio di Baldi quanto scritto da Greimas o Genette o ovviamente da Roger Caillois nella sua teoria dei giochi, ma anche di tracciare una mappa del presente spingendosi fino ai confini estremi di quella che potremmo definire immaginazione collettiva.
Il libro si chiama Voglia di vincere di Tom Bissell (Isbn, 19,90 euro) e è una breve storia culturale dei videogiochi, dagli anni ’80 di Pong fino al quasi-presente di Grand Theft Auto IV. Ed è chiaro che – anche nel caso non abbiate mai usato una Psp in vita vostra o odiate il suono stesso di uno sparatutto – questo libro vi potrebbe piacere comunque moltissimo. Sì, sono sicuro che vi piacerebbe moltissimo per diversi motivi che proverò a elencare brevemente. 1) perché ipotizza che tipo di immaginario avranno gli adulti del futuro, ossia coloro che in un modo o nell’altro hanno passato la loro adolescenza con un joystick o un pad fra le mani (per capire, alle volte la sensazione è come quella di leggere un saggio sul cinema nel 1920); 2) non si risparmia nemmeno una delle domande fondamentali sull’arte, la verosimiglianza, il realismo, l’autenticità che ci facciamo da Aristotele in poi e se le pone con un’onestà rarissima e un’intelligenza potente, prendendo di petto lo stesso concetto di “rappresentazione”, nel momento in cui i mondi dei videogiochi rendono l’interattività possibile tra creatore e abitanti è un terreno ogni giorno da ridefinire; 3) parla della contemporaneità nell’era della riproducibilità tecnica delle sue forme mentali più astratte: creare videogiochi vuol dire essenzialmente dare forma a universi in cui milioni di persone si divertiranno, si arrabbieranno, si spaventeranno magari balzellando da una nuvola all’altra per più di cento ore della loro vita; 4) recensisce molti videogiochi (da Braid o Far Cry 2) riuscendo a riconoscere (con le interviste agli ideatori o con un’acribia da filologo) il loro statuto artistico – ancora plastico, certo: quanta ingenuità, ripetività, autocontradditorietà, sperimentazione fallimentare… in un tipo di opere che non hanno ancora ben definito i loro codici; 5) analizza con uno sguardo politico (derridiano si direbbe) e una spietatezza rivolta verso di sé e verso i suoi compagni di consolle la psicologia dei videogiocatori, il loro amore per la violenza gratuita, per la solitudine, la predisposizione alla dipendenza (le pagine sul suo consumo di cocaina sono toccanti) e soprattutto le questioni di che cosa vuol dire essere liberi o avere potere in un mondo inventato; 6) afferma che in un tempo dei social network che ci chiede sempre di più di essere noi stessi, i videogiochi ci “insegnano cose su di noi che non sapevamo”; 7) si occupa delle sfide più importanti delle scienze cognitive oggi: in sostanza, come tradurre in un codice le abilità semantiche dell’essere umano (ovvero, se fossimo dei game designer: come facciamo a disegnare un volto umano perché ci sembri veramente credibile? quali sono delle scelte morali veramente interessanti?); 8 ) sostiene che gli sparatutto come Gears of War stanno alle guerre contemporanee come Omero o Tennyson stavano a quelle di allora; 9) intervista il creatore di Fable Peter Molineaux per lasciargli in bocca frasi di questo tipo: “Ecco cos’è ancora più stupefacente: se dovessi disegnare su quel muro il personaggio di un videogioco di vent’anni fa, sarebbe fatto di sedici punti, fine. Siamo partiti da quello e ora pensiamo che potremmo replicare il volto umano. E più o meno tutto quello che abbiamo fatto, l’abbiamo inventato. Non siamo andati a pescarlo da tecnologie preesitenti. Non esistevano. Dipingere la Cappella Sistina? Prima abbiamo dovuto inventare l’architettura. Abbiamo dovuto estrarre la roccia. Abbiamo dovuto inventare la pittura. Non esiste altra tecnologia al mondo su questo pianeta che abbia tenuto il ritmo dei videogiochi. Cambieremo il mondo e creeremo un tipo di intrattenimento diverso da tutto ciò che c’era prima”; 10) è un libro scritto divinamente – come qualunque cosa del resto che abbia scritto Tom Bissell, da Dio vive a San Pietroburgo, una raccolta di racconti uscita da Einaudi qualche anno fa, a Chasing the sea, un reportage-memoir sui luoghi della vita del padre, che qualche editore italiano dovrebbe avere il coraggio di pubblicare.
Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).

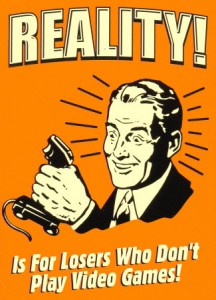






Ho letto Voglia di vincere qualche mese fa e anch’io come Christian Raimo l’ho trovato davvero un libro fantastico e importante.
Importante perché, come fa giustamente notare la recensione, è un libro che apre la strada alla nascita di una critica del videogioco che sappia fondare in autonomia le proprie basi.
Il riferimento al cinema degli anni ’20 è estremamente significativo, perché il libro di Tom Bissel si inserisce in quel filone di critica impressionista, legato a doppio filo con lo sguardo e l’esperienza dell’autore, che ha segnato la genesi della critica cinematografica.
Inoltre mi pare che sia maturo il momento per una riscoperta del valore del gioco e dell’esperienza ludica che possa contribuire a chiarire la posizione di certe pratiche (specialmente quelle legate alla formazione dell’immaginario) all’interno della nostra cultura…
imperdibile, in effetti, per chi ha interesse alla faccenda. da leggere!