
Baby, do you miss the days before hope knocked on your door?
Perché ci sia speranza, dev’esservi oscurità. C’è una bellissima canzone di Grian Chatten, forse uno dei brani che più ho avuto in cuffia l’anno scorso, che si intitola Fairlies, e a un certo punto domanda: “Ti mancano i giorni prima che la speranza bussasse alla tua porta?”. In quel momento ricordo di non aver capito: come mai a una persona dovrebbero mancare i giorni prima della speranza? Forse avevo ascoltato in modo distratto, forse avevo tradotto troppo velocemente. Però, a pensarci bene, quand’è che uno si ritrova a sperare? Quando prova a fare qualcosa, a essere qualcun altro. Quando è sull’orlo della disperazione. Allora può cedere alla tentazione o confidare nell’ignoto. Mi son detta che allora i giorni prima della speranza sono i giorni in cui la speranza non serviva, e nel momento in cui bussa alla porta significa che inizia a fare buio e se ne ha un tremendo bisogno. Allora la si può accogliere o meno. E se non ci si riesce, si può riprovare. Che alla fine la speranza mi sembra una luce che non si stanca mai di bussare.
E in questo devastante e devastato 2024 la speranza che il ritmo degli eventi potesse mutare non si è mai affievolita, sebbene risultasse arduo continuare a gettare il pensiero nel futuro fatto di giorni buoni. Conflitti armati, genocidi, bombardamenti, sparatorie, femminicidi, violenze quotidiane: al buio di tutto questo, come si può pensare davvero alla musica? Come si può aver ancora voglia di farla, di ascoltarla, di viverne i battiti?
Ma tale è la meravigliosa casualità delle nostre vite fugaci che recentemente, per purissimo caso, mi sono imbattuta nel lavoro di Cahran Ranganath, professore di psicologia e neuroscienze, sul tema della memoria. I suoi studi hanno indagato come si formano effettivamente i ricordi, in particolar modo su quella che è la la capacità di archiviazione del nostro cervello per cui la mente riedita momenti ed esperienze, incapsulandoli in una breve sinossi di quelli che erano intervalli di tempo molto più estesi. Ranganath ha ipotizzato che la memoria sia simile a un dipinto, costruito in modo creativo, in costante adattamento, in perenne evoluzione attraverso ogni ritorno, osservazione, stato d’animo e abbraccio. Ho sempre pensato che la musica operi lungo linee simili a quelle di un quadro, con la dualità di sentire il presente, trasportandoci lontano, attraverso il tempo e il ricordo, evocando dipinti sonori invisibili, innescando consistenze tattili, profumi, emozioni. E magari facendoci dimenticare da dove siamo partiti. Ma il problema non è la nostra memoria, quanto le aspettative sbagliate su di essa, in primo luogo sulla sua utilità. I meccanismi mnemonici non sono stati messi assieme per aiutarci a ricordare il colore della giacca che aveva la nostra insegnante il primo giorno delle medie. Non possiamo ricordare tutto, ed è evidente che ciò che spesso leggiamo come difetti della memoria, sono in realtà anche le sue caratteristiche. Nelle giuste circostanze, anche dimenticare può esserci stato utile. I nostri ricordi contribuiscono sì alla nostra identità, ma a lavorare su questo ci pensa anche la loro controparte silenziosa, l’enorme substrato subliminale di tutto ciò che abbiamo dimenticato. Qualcosa che anche una melodia, un canto, un accordo può rievocare nell’intuizione di quell’attimo prezioso.
Ed è esattamente in quell’istante che risuonano le canzoni di questo duemilaventiquattro, canzoni di un mondo perduto, con tutto il loro carico di mistero e con tutta la limpida, cristallina familiarità di qualcosa che già è stata parte della nostra vita. Anche se probabilmente non ce ne ricordiamo. Ma va bene anche così. Perché forse a un certo punto della nostra vita semplicemente smettiamo di ascoltare la musica e iniziamo ad abitarla, in un tentativo di identità immediata. Sarà colpa anche del fatto che non abbiamo più il tempo di cercarci un’identità negli archivi, in una memoria, in un passato, e tanto meno in una prospettiva, in un progetto, in un avvenire. Ci serve allora una memoria istantanea, una fissazione immediata, una specie di identità pubblicitaria che possa verificarsi in un attimo. Ed è esattamente ciò che ha fatto la musica uscita quest’anno. Settimane piene di uscite brillanti, esordi imperdibili, certezze ritrovate, ritorni attesi e felici. Commuoversi, perdersi e poi tornare dove non siamo mai stati: quante volte ci siamo riscoperti fragilissimi di fronte a un suono che pensavamo di non poter più trovare? Quante volte un ricordo che credevamo reale si è dissolto in mezzo a un accordo inaspettato che grondava un sentimento di famiglia e casa per poi sparire dietro filtri di mastering?
Prendiamo, solo per un attimo, il nuovo disco dei Cure, una storia che arriva dopo sedici anni di silenzio: Songs of a Lost World non è semplicemente una raccolta di bellissime canzoni, è piuttosto un luogo, in cui mi sembra di essere stata davvero, in una vita che non è quella delle mie mani, delle mie gambe, dei miei occhi ma percepisce la memoria di un corpo che conosco. Le tastiere alte, il basso che ravviva un fuoco morente, e un campanello scarlatto che racconta di preghiere disattese. Come se quei capolavori di Disintegration e Bloodflowers fossero usciti lo stesso giorno, in bella mostra nella vetrina del negozio di dischi della nostra provincia disprezzata, in cui abbiamo aspettato arrivassero regali dal futuro. E in quel tempo scosceso siamo tristi e siamo felici, perché non tutto quello che le nostre orecchie sentono, non tutto quello che i nostri occhi vedono, vagando nel mondo, è così immediato. Perché vive in fondo alle cose, la bellezza più cara, quella dell’ascolto di dischi che si fanno colonna sonora per un mondo che ha perso la testa. E allora li colleziono qui, come promesse apocalittiche, come tracce che fluttuano ben al di sopra dello spazio sonoro, ché la musica esiste oltre i vincoli dei media, vagando nell’etere, ed esiste sì, in termini emotivi. Ed è forse in questi termini che mi ritrovo a ricordare come hanno suonato i dodici mesi passati, i giorni buoni e quelli brutali. Alle volte erano la fotografia di un camino che brucia in un’America confusa e vuota, come la meravigliosa conferma arrivata da Adrianne Lenker, una delle autrici più solide e capaci di questa generazione. Il suo Bright Future – dalla copertina che è dissolvenza e azione – suona come una conversazione intimissima (è un disco autobiografico), registrata in presa diretta, un compendio di densità e struggente bellezza in odor di Judy Collins. “Volevo così tanto che la magia fosse reale”, sussurra Lenker nella splendida Real House a sostenere il ricordo di un attimo felice trasformato in passato.
E dal passato sembrano arrivare le melodie di Aladean Kheroufi, polistrumentista, cantautore, produttore e DJ canadese-algerino, alle prese con dilemmi d’amore tra ballate soul, psichedeliche e spezzate e ritmi chican-folk; Studies In A Dying Love, il suo album di debutto, è un ritratto sorprendente e catartico del crollo di una relazione, senza mai perdere la gioia di un’immersione emotiva nei flussi e riflussi del cuore. E se si parla di esordi splendidi non si può non ricordare Darning Woman di Anastasia Coope che con GarageBand, un pc, il soggiorno vuoto e un senso di rinnovata curiosità nei confronti della musica, ha formato il proprio percorso musicale all’interno della malleabilità del suono. Coope, sebbene giovanissima, è già riuscita a forgiare una voce distintiva e inconfondibile, tra folk surrealista e meditabonde serenate sorrette da cori che sembrano risuonare dall’antichità. Una gemma preziosa di trasformazione sonora e stratificazione vocale, qualcosa di vicino eppure ossimorico rispetto allo slowcore sintetico e umido degli Arab Strap: il loro ottavo album, I’m Totally Fine With It Don’t Give A Fuck Anymore abbraccia un gusto da crooner, la darkwave più urbana e mefitica, il post-rock e la cassa in quattro quarti. Senza pezzi indimenticabili forse ma pur sempre maestri nell’arte della declamazione epica. Interessanti e voluttuosi sono ancora una volta i canadesi BADBADNOTGOOD che incrociando hip hop, jazz e fusion nipponico continuano a spingere i confini musicali della loro ricerca musicale in Mid Spiral, figlio di una produzione sontuosa che non fa rimpiangere Talk Memory anche nel decidere di mettere, a differenza del passato, la chitarra in primo piano.
Se in questo 2024 c’è stato un ritorno capace di commuovere e aprire voragini è stato quello di Bill Ryder-Jones, confermatosi autore maturo e musicista curioso. Iechyd Da, che si può tradurre in “buona salute” dal gallese, sfuma e poi cambia velocità più volte, trasporta lontano ma non disorienta mai. Non è affatto semplice ritrovarsi dentro un album che non ha canzoni deboli: che siano i violoncelli, suono della speranza, che siano i momenti strumentali in cui si legge Joyce, che siano i cori di fanciulli – sempre un rischio zuccheroso ma no, non qui che si fa contrappunto di innocenza -, che sia una ninna nanna eniana, l’ex ragazzino dei Coral incanta con una grazia impegnativa ma che lavora di sottrazione. Perché è come se Ryder-Jones volesse scomparire, mimetizzandosi nella tenerezza di una paura adulta (nei confronti di insonnia e depressione) pur riuscendo a trovare una via di fuga, una botola segreta nell’oscurità della notte. Oggi, ascoltandolo, mi sembra un uomo felice o almeno un essere umano che tenta di trovarla davvero, questa arcana promessa. E se la quota esistenzialista britannica risponde al nome di Bill, dall’America non si può che sottolineare la solennità di un lavoro maestoso firmato da un certo Josh, per gli amici Father John Misty. Mahashmashana non è solo un disco ma un antidoto al terrore di vivere: lo stile con cui scrive, la scelta degli strumenti da suonare, tutto è giusto, tutto assume la forza di un inno. Misty, carico di un’energia sacra e libidinosa, gigioneggia con fascino ardente grazie a un sound che mischia il Cohen dongiovanni e crooner di Death of a Ladies’ Man con suggestioni à la George Harrison. Oscillano le canzoni di Mahashmashana, grazie al potere di accompagnamenti titanici, controcanti sciropposi, e dissolvenze prolungate. Il dissacratore, il santo e il satanasso che confessò candidamente, “il mio umorismo è la mia creatività e il mio scetticismo è un dono”. Provate a dargli torto. Provate ad attaccare un disco così, con quella voce tirata eppure muscolare, che sembra strapparsi e non lo fa mai, tornando elastica, morbida, come le gambe di un ballerino che furoreggia nella migliori ballroom d’America.
Gli USA si faranno ricordare anche per la propulsiva giostra ritmica di Childish Gambino, i beat melodici di Freddie Gibbs, il balsamo twee di Helado Negro, la neo-psichedelia oziosa di Luke Temple, la drammaticità lynchiana dei Mercury Rev, la nostalgia nu-soul dei Thee Sacred Souls, la brevitas introspettiva del rap di Vince Staples, e chissà quanti altri. Se l’Australia si illumina con il ritorno trionfale dei Dirty Three e quello jazz e prismatico che si dipana nella matrice tastiere-basso-batteria dei Necks, i francesi possono godersi il tocco retrofuturista che anima Pulsar de L’Impératrice, l’equilibrio toccante e sensuale del groove pop di Malik Djoudi che con Vivant offre insidie elegantissime, e il sunshine pop barocco del bretone Olivier Rocabois.
E il nostro Belpaese? Potrebbe non aver brillato come in passato ma il progetto avant-jazz dei CENOBIUM e il nuovo disco dei vicentini Delicatoni meritano sicuramente una postilla: se i primi, capitanati dal bassista Andrea Lombardini, con MMXXIV, hanno reinterpretato le tradizioni afroamericane ed europee, così come le influenze post-rock, intrecciando suoni acustici ed elettronici, i secondi, sempre più bislacchi e dinoccolati, con Delicatronic, regalano un carnevale sonico irrefrenabile, fatto di bassi chirurgici, fiati jazzy, sintetizzatori umanisti e chitarre jingle jangle. E l’atteso ritorno dei vorticosi C’mon Tigre stabilisce la sempiterna e autentica connessione con il suono, continuando a sfuggire a qualsiasi classificazione. Con un disco pensato come colonna sonora di un film inesistente, il collettivo delle meraviglie, che si proietta solitamente nel futuro, stavolta guarda al presente instaurando una collaborazione – che è anche emotiva e sensoriale – con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model), una Intelligenza artificiale, istruito su contenuti e stile, i cui riferimenti arrivano dagli stessi musicisti e dagli scritti di Raymond Carver.
La nostra è principalmente una provocazione artistica, un invito a guardare le cose da punti di vista differenti, potrebbe tuttavia concretizzarsi in un modus operandi differente portando nuovi stimoli, scardinando un metodo di produzione che forse, alla luce di tutti questi cambiamenti rivoluzionari inerenti allo sviluppo tecnologico, non può essere considerato l’unico. La sua perfetta conclusione sarebbe quella di vedere poi il film realizzato, e che le musiche facessero da amplificatore accompagnando il lavoro registico, che dovrà calibrarsi sulla base alla narrazione musicale già esistente.
Instrumental Ensemble – Soundtrack For Imaginary Movie Vol 1 è l’esperienza capace di farci sorridere, ballare, cantare, e ascoltare nuovamente con una dose di felicità che tende al bene, al bello. In attesa che il prossimo brano, dei ventitré, possa spiegarci che eravamo felici perché già sapevamo che lo saremmo stati dopo, in un preciso istante, sotto un qualsiasi cielo, sopra un qualsiasi prato. Con una qualsiasi, precisa, colonna sonora.
Album come evoluzioni: alla voce Fontaines D.C., IDLES, Jessica Pratt, Geordie Greep, Laura Marling, si trovano lavori che crescono a ogni ascolto, confermando la potenza dei brani, la bellezza immacolata di certe registrazioni, i barcollamenti armonici, la bulimia ossessiva e compiaciuta di un certo perfezionismo. Sono tutti lavori spiazzanti, in modi e toni diversi, chi è sopra le righe, chi si nasconde dietro veli di squisite beatitudini acustiche, chi è un mistero interessato a osservare lo spirito del nostro tempo, chi viaggia nel futuro, in ogni caso siamo davanti a preziose testimonianze del potere di trasformazione della musica.
Penso allo shakuhachi e al clarinetto di Shabaka, al violoncello di Mabe Fratti, ai sintetizzatori modulari e l’arpa di Nala Sinephro, alle orchestrazioni spirituali dei Sons of Viljems, penso a tutti gli strumenti che hanno costellato i dischi di questo lungo e impervio anno, attraverso un viaggio di note oltre il limite della coesistenza tra dolcezza e intuizione: strumenti che si fanno ascensori sensoriali, all’interno dei circuiti di aggregazione di altri strumenti che qui impugnano lo scettro dell’estradizione di un corpo metafisico. La bellezza della musica, coniugata al potere di un ricordo non solo nostro, si manifesta in una seconda memoria, della quale non sappiamo nulla, che deconfigura il tempo. E lo ha fatto anche stavolta, trasformandoci in altro, portandoci su coordinate ignote, in tempi a noi segreti. Non mi ricordo esattamente quando ho iniziato a respirare più musica che aria però oggi so per certo che senza certi dischi, certi accordi, certi cambi di armonia, certi incontri, non potremmo dirci davvero felici. Buona fine, buon inizio.
_________________________________________________________________
- Adrianne Lenker – Bright Future
- Aladean Kheroufi – Studies in Dying Love
- Anastasia Coope – Darning Woman
- Arab Strap – I’m Totally Fine With It Don’t Give A Fuck Anymore
- BADBADNOTGOOD – Mid Spiral
- Bill Ryder Jones – Iechyd Da
- C’Mon Tigre – Instrumental Ensemble (Soundtrack For Imaginary Movie Vol. 1)
- Cenobium – MMXXIV
- Childish Gambino – Bando Stone & the New World
- Delicatoni – Delicatronic
- Dirty Three – Love Changes Everything
- Father John Misty – Mahashmashana
- Fontaines D.C. – Romance
- Freddie Gibbs – You Only Die 1nce
- Geordie Greep – The New Sound
- Helado Negro – Phasor
- IDLES – TANGK
- Jessica Pratt – Here In The Pitch
- John Cale – Poptical Illusion
- L’Impératrice – Pulsar
- Laura Marling – Patterns
- Luke Temple – Certain Limitations
- Mabe Fratti – Sentir que no sabes
- Malik Djoudi – Vivant
- Mercury Rev – Born Horses
- Michelle Gurevich – It Was The Moment
- Nala Sinephro – Endlessness
- Nicolas Jaar – Piedras 1
- Orville Peck – Stampede
- Olivier Rocabois – The Afternoon Of Our Lives
- Paolo Benvegnù – Piccoli Fragilissimi Film Reloaded
- Shabaka – Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace
- Sons of Viljems – Lithospheric Melodies
- Thee Sacred Souls – Got A Story To Tell
- The Cure – Songs of a Lost World
- The Smile – Wall of Eyes
- Tindersticks – Soft Tissue
- Vince Staples – Dark Times
- Warhaus – Karaoke Moon
- Yannis & The Yaw – Lagos Paris London






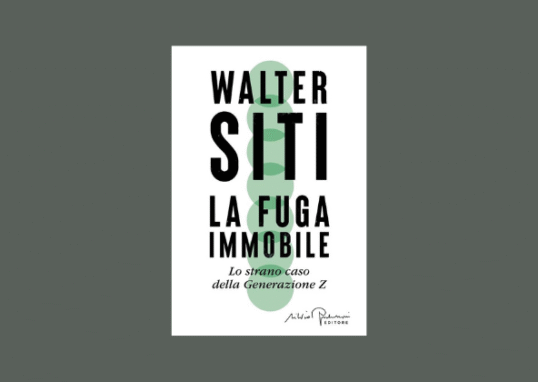
Recuperate molte uscite passate in sordina, grazie!