
Pubblichiamo il dialogo tra Emmanuel Carrère e Nicola Lagioia avvenuto lo scorso 14 marzo all’interno del Festival letterario Libri come, tratto dal numero di maggio de Lo Straniero. Quest’anno la cerimonia conclusiva del Premio Lo straniero, attribuito dai redattori e dai collaboratori della rivista, si svolgerà all’interno del festival teatrale di Castiglioncello Inequilibrio domenica 28 giugno dalle ore 11:00. Qui i premiati; puoi sostenere il Premio contribuendo a questa raccolta di fondi.
Nicola Lagioia: La si dovesse dire in sintesi, potremmo dire che Il Regno è un libro narrativo sulle prime comunità cristiane, o sugli Atti degli apostoli, o su quei due colonizzatori di menti e spiriti che furono san Paolo e san Luca. Un libro non sull’infanzia ma sull’adolescenza del cristianesimo (come scrive lo stesso Carrère), sulla sua fase più ribelle e irrequieta. Bisogna però vedere che tipo di racconto sull’adolescenza del cristianesimo è Il Regno. Il che mi consente di farti la prima domanda. Me ne offri tu stesso l’opportunità quando scrivi: “quelli che hanno conosciuto i dibattiti politici del dopo Sessantotto francese, ricorderanno la domanda di prammatica: da dove parli? A me sembra ancora una domanda pertinente. Perché un pensiero comunichi qualcosa, bisogna che quel pensiero sia espresso da una voce, che la voce provenga da un uomo, e che io sappia come quel pensiero si è fatto strada nell’uomo che ho di fronte”. E allora la prima domanda che ti farei è proprio questa: “da dove parli?” o meglio “da dove scrivi questo libro intitolato Il Regno?”.
Emmanuel Carrère: Parlo a partire da un gusto, da una curiosità antichissimi per il cristianesimo e parlo un po’ da un duplice punto di vista, cioè quello dell’uomo che sono io ben sopra la cinquantina, che nei confronti del cristianesimo nutre una vivissima e molto amichevole curiosità, ma allo stesso tempo quello di un non credente, di un agnostico, la cui lettura è piuttosto una lettura storica e romanzesca. Ho avuto dunque voglia di ripartire dal Nuovo Testamento da quel punto di vista che vi ho appena descritto. Al tempo stesso si dà il caso che questa esperienza varrà pure ciò che vale ma quando avevo una trentina d’anni, in seguito a una crisi personale in un periodo molto caotico della mia vita, sono stato un credente molto fervido, addirittura dogmatico, che andavo a messa non dico tutte le domeniche ma addirittura tutti i giorni, mi confessavo e facevo la comunione… Dunque questo Nuovo Testamento che oggi percorro da storico, da romanziere, un po’ da investigatore, per così dire amichevole ma scientifico, c’è stato un momento in cui io l’ho letto come credente, quasi un credente fondamentalista, integralista, assolutamente deciso comunque a credere alla verità letterale dei Vangeli, a crederli ispirati assolutamente da Dio.
C’era dunque la possibilità di entrare in questo testo attraverso queste due porte: quella della fede, che valeva quello che valeva, non era certo una fede di gran qualità ma insomma… e questa posizione non ho avuto l’impressione che mi conferisse qualche legittimità particolare. Semplicemente questo approccio mi consentiva di tentare di tenere tutte e due le estremità di questa catena. Speravo di produrre un libro che potesse interessare molte persone, ma malgrado tutto c’è una linea di divisione, ci si entra come credenti o come non credenti. Speravo al tempo stesso di poter interessare entrambe le categorie, cioè che fosse letto con interesse e profitto da chiunque entrasse da qualsiasi delle due porte e avere io stesso la possibilità di entrare da qualunque dei due ingressi opposti, anche due piccole porte di servizio nascoste, non dei gran portoni. Idealmente uno vorrebbe stare sul crinale e vedere entrambi i versanti della montagna ma su questo tema non si può mai essere sul crinale, si può solo fare qualche passo sull’uno o sull’altro versante e in fondo con questo libro speravo di mettermi a vagare sul confine che separa la fede dalla miscredenza o dall’incredulità, e avevo qualche esperienza personale che mi consentiva di poter visitare questa frontiera… Penso che sia questa la risposta che ti devo perché è molto importante la questione di chi parla e da dove parla, è importante che il lettore sappia con chi ha a che fare e la posizione dell’autore.
Personalmente non credo all’obiettività, non penso che ci sia un discorso di verità, meglio dire chi parla rischiando cioè che la presenza dell’autore sia narcisistica e indiscreta, però perlomeno il lettore sa con chi sta parlando, con chi ha a che fare, con quali presupposti e con quali pregiudizi. Chi è costui che sta parlando, per me è forse una miscela inscindibile di etica e di vanità: c’è un po’ dell’etica dello scrittore, ma la vanità è senz’altro presente.
Nicola Lagioia: Durante il tuo periodo cattolico, i due anni di cui racconti nelle prime cento pagine del libro, leggevi soprattutto il Vangelo di san Giovanni, poi però nel Regno ti interessi di san Luca e di san Paolo. Personalmente ho trovato Paolo il personaggio più irritante e al tempo stesso il più affascinante di questa coppia. Paolo oggi sarebbe forse un integralista per come lo racconti, però poi a un certo punto trova la fede cristiana e allora rinuncia alla violenza, cerca di tenere a bada l’arroganza anche se rimane in qualche modo arrogante, è probabilmente vergine, non gli interessano le droghe né altri tipi di eccessi del mondo pagano, è convinto che la fine del mondo sia imminente… insomma oggi sembrerebbe quasi un integralista trasformato in un bacchettone. Però allo stesso tempo è molto carismatico, è un vero e proprio magnete. Così ti chiedo: chi sono san Paolo e san Luca in questo libro?
Emmanuel Carrère: Sono dei personaggi che hanno un status assai diverso, Paolo è un immenso personaggio storico e hai ragione a dire che qualsiasi cosa uno ne pensi, anche senza nessuna simpatia, ha un rilievo romanzesco enorme, è un gran personaggio da romanzo. In fondo è un personaggio che conosciamo assai bene perché le sue lettere, le epistole di San Paolo, due terzi delle quali sono considerate autentiche persino dagli esegeti più critici e più esigenti, sono dei documenti… È già un autore nel senso moderno del termine, cosa che non si può dire di nessuno degli autori del Nuovo Testamento, le lettere le ha scritte Paolo in prima persona, così si sa esattamente cosa pensa e come si esprime… Gesù, invece, non sappiamo esattamente chi fosse, come si esprimesse, e abbiamo letto di Gesù attraverso ciò che viene detto e scritto di lui, forse parole riferite in modo infedele, mentre a Paolo abbiamo un accesso diretto e quindi è al tempo stesso un personaggio di enorme rilievo e un personaggio che conosciamo veramente. Luca invece era come dicevi tu. Sono un’ottima coppia, come Don Chisciotte e Sancho Panza, come Holmes e Watson.
Ancora di più, dico io, perché Paolo è un personaggio di grandissimo rilievo e Luca è il cronista, il memorialista, umanamente una personalità molto più simpatica certo ma in fondo più secondaria, più modesta, forse neanche tanto intelligente, il fedele scudiero che accompagna l’altro, che lo segue nelle sue follie, preoccupandosi un po’, ma comunque andandogli appresso. D’altro canto c’è un altro motivo che ha fatto sì che Luca mi interessasse e finisse malgrado tutto per essere l’eroe del mio libro, e cioè che Luca ha scritto un Vangelo che mi interessava moltissimo e mi piaceva tentare di immaginare chi potesse esserne l’autore, perché mi interessano gli autori di questi quattro libri, dei piccoli libri, dei tascabili che comunque costituiscono la base della nostra civiltà… Chi era uno di questi quattro, di che materiale mentale viveva, che cosa credeva veramente, come era giunto dentro questa storia, da dove traeva le notizie in suo possesso. Sembrerà molto pretenzioso che uno si dica vicino a un evangelista, ma io Luca me lo sentivo molto vicino, a differenza di Giovanni che avevo letto molto un tempo e che è un autore in realtà assai più misterioso, che incute timore. Luca è un autore molto umano, molto familiare, un ottimo autore per me, e però uno scrittore senza grandi misteri, è molto concreto, molto quotidiano, nel senso dei particolari… Tutte ragioni che me lo rendevano particolarmente amabile. Durante la stesura del libro, così come Paolo è stato un compagno particolarmente ingombrante, non proprio uno con cui si andrebbe in vacanza, Luca è stato un compagno molto “amicone”, qualcuno con cui mi intendevo veramente molto bene. Mi è piaciuto moltissimo Luca, e in un modo forse un po’ narcisistico mi sono proiettato in lui, se posso permettermi di dirlo.
Nicola Lagioia: A un certo punto nel Regno parli di un’altra scrittrice francese che cercava di addentrarsi letterariamente nell’antichità: Marguerite Yourcenar. Lì c’era proprio il tentativo di restituire lo spirito autentico dell’epoca di Adriano, ma noi questa cosa non possiamo farla, dici tu: i secoli che ci separano dal mondo antico sono per noi necessariamente filtrati da ciò che siamo diventati e da tutto quello che è successo nel frattempo. A proposito di questo, c’è una cosa che ho trovato delle più interessanti. Tu spesso utilizzi due pilastri della cultura laica e moderna per parlare del cristianesimo: uno è la psicanalisi e l’altro è il comunismo russo successivo alla Rivoluzione di ottobre. C’è chi ritiene che il comunismo sia un’eresia cristiana. Dall’altro, leggendoti mi è venuta in mente una definizione spiritosa di Ennio Flaiano, quando diceva la psicanalisi è “una pseudo scienza inventata da un ebreo per convincere i protestanti a comportarsi da cattolici”. Ci vuoi dire come utilizzi psicanalisi e comunismo per parlare del cristianesimo?
Emmanuel Carrère: Beh, si fanno degli accostamenti a partire da quello che uno conosce. Di psicanalisi ho una certa esperienza, anzi diciamo parecchia, è stata una passione per molti anni, in qualità di paziente; quanto al comunismo, me ne sono sempre interessato e conosco la storia del comunismo abbastanza bene, tuttavia tra le due cose c’è una vera somiglianza: diciamo che le storie del cristianesimo dei primordi sono anche dei bisticci politici tra piccole fazioni come tra Lenin e gli altri in seno all’Internazionale dopo la Rivoluzione di ottobre con le esclusioni, le cacciate. C’è un’altra cosa comune: si può ben dire che il comunismo è un eresia del cristianesimo, ma in ogni caso si può dire che non vi sono stati tanti movimenti nella storia del genere umano che pretendessero non solo di cambiare lo stato delle cose, o lo stato della società, ma che pretendessero veramente di dar vita a un altro genere di umanità.
Nell’uno e nell’altro caso, cristianesimo dei primordi e comunismo, c’è l’idea che si assista a un mutamento radicale dell’essere umano e che si stesse creando un nuovo essere umano, e qui forse è la mia cultura storica a essere carente, ma non credo esistano molti esempi storici di un ambizione altrettanto folle di trasformare radicalmente l’essere umano. Qui è come nei libri di fantascienza, è una mutazione vera e propria, per far sorgere un essere umano diverso. È stato divertente raccontare le dispute tra Paolo e la chiesa cosiddetta legittima, quelli che erano stati compagni di Gesù in vita, e accostarvi tutto questo. Bisogna cercare di immaginarsi la situazione: ci sono delle persone che sono stati i discepoli legittimi riconosciuti di Gesù, ne sono stati famiglia, parenti, fratello, gente che ha vissuto con lui, che ne ha condiviso le prove quotidiane, i pasti e poco dopo arriva un tizio che non solo non lo ha mai conosciuto di persona, ma in più ha perseguitato i suoi primi adepti e dice grossomodo “la verità sulla vostra fede sono io che la detengo e quindi d’ora in aventi sono io che me ne occupo”. È una opa lanciata su questa piccola impresa e c’erano delle ottime ragioni per cui i primi cristiani la prendessero veramente male. La chiesa cristiana primitiva, peraltro totalmente ebraica, ha accolto molto male quest’ebreo il quale diceva lui stesso che l’ebraismo non aveva più nessuna importanza, che questa Legge con la L maiuscola andava messa nel cassonetto. C’era qualcosa di scandaloso in tutto ciò, il che ha fatto sì che parte delle epistole di Paolo e parte degli Atti degli apostoli rendano conto e ragione di questo conflitto, che non è un conflitto religioso ma è un conflitto politico al cento per cento, una disputa tra la casa madre e qualcuno che ti ha lanciato un’opa, no?
Nicola Lagioia: Entrerei ora nella “bottega” dello scrittore perché Emmanuel spesso lo fa nel suo libro. Tu dici a un certo punto che almeno da L’avversario in poi non consideri più “romanzi” i libri che scrivi. Sarebbero piuttosto un ibrido tra narrativa, saggistica, autobiografia. In Italia l’autofiction ha avuto parecchi scrittori che hanno provato a cimentarsi con il genere. Ad esempio Walter Siti parla di alcuni suoi libri come “autobiografia di fatti non accaduti”. Però i fatti tuoi sembra siano realmente accaduti (alla lettera del testo), e allora ti volevo chiedere visto che nei tuoi libri tiri spesso in ballo compagni di strada, amici, mogli, ex mogli… come ti comporti con queste persone? Gli fai leggere il libro prima della pubblicazione? Chiedi la loro autorizzazione? Qualcuno, vedendosi riconosciuto, si è mai arrabbiato?
Emmanuel Carrère: Sì, è successo, in realtà una volta sola sul serio. Certo, quando si scrivono libri si mette in scena la propria vita, e si ha il diritto di raccontare sul proprio conto tutto ciò che uno vuole. Il punto è cosa si può dire sul conto di altre persone. Nella ventina di anni in cui ormai sto praticando questa forma, che non è fiction letterale, non parlo soltanto delle esigenze del rigore, perché per me la scrittura non è una storia immaginaria, quindi anche se utilizzo la tecnica del romanzo sono storie che non sono immaginarie. Insisto, mi interessa che il lettore sappia che ciò che io narro è vero, è una questione di status di ciò che si racconta.
Da quando scrivo questo tipo di libri ho conosciuto tutti i casi di cui ho narrato, c’è stato un unico libro che ho scritto contro le persone e senza sottoporglielo per la lettura, e le cose sono andate piuttosto male con queste persone. Si intitola La vita come un romanzo russo, vi si trattava di mia madre e della mia compagna del tempo, che io ho tirato in ballo in termini dolorosi, che hanno fatto loro del male. Non posso rimpiangere di averlo fatto perché per me è stato invece salutare, e peraltro per fortuna non ha causato nessuna catastrofe, però ho avuto l’impressione di trasgredire a una regola alla quale credo, perché penso fermamente che non si abbia il diritto da scrittori di scrivere qualunque cosa si voglia sul prossimo, di offenderlo e ferirlo. Questa è una regola in cui credo, l’ho trasgredita una volta, spero di non doverlo mai più fare, e il libro che ho scritto subito dopo, Vite che non sono la mia, è stato il contrario del libro precedente. Qui si trattava di persone reali e a tutti ho dato il libro da leggere prima della pubblicazione, dicendo che avrei modificato quanto eventualmente mi avessero chiesto di cambiare. Il mio editore mi ha detto, sei pazzo, non resterà più niente, non c’è un solo caso nella storia di qualcuno che sia stato contento di ciò che uno scrittore ha scritto di lui. Invece, contro ogni previsione, è andata molto bene e uno dei momenti più commoventi della stesura del libro è stata l’ultima fase con le persone interessate, come si trattasse di persone che avevano posato per il proprio ritratto. Alcuni me lo avevano ordinato, quel ritratto, però dopo era come se avessimo passato del tempo a fare delle sedute di ritocco.
Comunque c’era una confidenza vicendevole, hanno capito che dovevano accettare di stare al gioco e che non si sarebbe trattato di ritratti di come si vedevano loro ma piuttosto di come li vedevo io, e se c’era qualcosa che non andava me lo dicevano. Nel complesso è stata una cosa di grandissima fiducia vicendevole di cui serbo un ricordo commosso. Ci sono altri casi di questo tipo, ma per Limonov le cose sono andate in maniera diversa. Limonov è vivo, è una figura pubblica, è uno abbastanza adulto perché io potessi avere paura di fargli del male, certo che a lui non avrei dato il libro da leggere prima della pubblicazione. Di fatto è stato contento del libro e se anche non lo fosse stato non mi importava niente perché non sarebbe stato grave. Se domani faccio un libro su Sarkozy e lui non è contento francamente non mi ritrovo con un gran problema morale, abbiamo il diritto di scrivere su uno come Sarkozy. Quanto a Paolo e a Luca, devo dire che non hanno sollevato alcuna obiezione…
Nicola Lagioia: Philip K. Dick è un autore che ritorna spesso nel Regno. In particolare, in una delle scene più riuscite del libro. Dick entra quasi fisicamente nel periodo cristiano di Emmanuel, intorno all’inizio degli anni novanta: Emmanuel sta con la sua ex moglie Jacqueline, non si rende conto che il rapporto sta andando a rotoli e come se non bastasse nasce il secondo figlio e la ragazza alla pari presso la coppia si licenzia. A questo punto Jacqueline e Emmanuel devono cercare una sostituta e fanno una specie di casting. Tra le candidate, si presenta una tale Jamie Ottomanelli, che più che una ragazza alla pari è una signora cinquantenne che sembra una via di mezzo tra una mezza barbona e una fricchettona fuori tempo massimo. Leggendo il libro mi immaginavo proprio visivamente Jacqueline che sussurrava a Emmanuel “No, no, ti prego questa no”. A un certo punto però Jamie vede spuntare dalle cose di Emmanuel un libro di Philip Dick e dice: “Oh, un libro di Philip Dick”. “Conosce Philip Dick?”, chiede Emmanuel. “ Certo che conosco Dick, sono stata la babysitter di sua figlia”. Così Emmanuel pensa: “Me l’ha mandata Dio, Jamie Ottomanelli”, e contro il parere di Jacqueline la prendono in casa e a quel punto, come c’è forse da aspettarsi da una che ha fatto da babysitter in casa di Philip Dick, questa signora si piazza in casa Carrère e trasforma in un incubo la vita dei suoi abitanti. Si disinteressa dei bambini, e la prima cosa che fa è disegnare un murale sulla parete di casa.
Questo mette in crisi Emmanuel. Da una parte si dice: “un attimo, se io sono cristiano quelli come la Ottomanelli sono gli ultimi, i pazzi, quelli di cui è nostro dovere occuparsi”. Al tempo stesso tutto si svolge nella rispettabile casa borghese di due intellettuali francesi. A Philip Dick tu hai dedicato una biografia, Io sono vivo e voi siete morti. Dick porta scompiglio in casa Carrère. Ti vorrei chiedere proprio di lui, come grande scrittore di fantascienza, ma anche come cristiano, ed eventuale profeta.
Emmanuel Carrère: Il fatto è che Dick è un personaggio abbastanza importante di questo libro perché a un certo punto si è costretti a chiedersi qual è la differenza tra uno come Dick e Paolo. Dick è uno scrittore di fantascienza, peraltro geniale, che scriveva storie di un’immaginazione e una fantasia sfrenata, che poi a un certo punto arriva a pensare che si tratti di rapporti assolutamente esatti sulla realtà. D’altro canto alla fine della sua vita Dick ha tentato lui stesso di capire il senso di quello che scriveva, ha avuto una specie di esperienza mistica, su cui non ha mai cessato di interrogarsi, e gli ultimi dieci anni della sua vita li ha passati a cercare di capire cosa diavolo li fosse successo. Riteneva di aver incontrato qualche cosa. Questo qualche cosa era Dio, qualsiasi cosa sia ciò a cui diamo questo nome? O erano gli extraterrestri? Erano un’espressione della sua leggendaria paranoia? Alla fine cosa distingue la paranoia dalla vera rivelazione mistica, qual è la differenza tra le due? Si è posto veramente questi interrogativi.
C’è un celeberrimo testo di Freud, Il presidente Schreber. Vi si parla del magistrato Schreber che è il prototipo del paranoico, e che credeva a cose totalmente inverosimili. È come se alla fine della sua vita Dick si fosse trovato nella condizione sia di Freud che di Schreber, come se al tempo stesso stesse analizzando la proprio paranoia tentando di capire cosa c’era di vero e cosa no. In fondo se uno prende da una parte la rivelazione mistica di Dick e dall’altra parte quella di San Paolo duemila anni prima, altrettanto repentina, altrettanto rivelatrice, altrettanto decisiva, all’infuori della questione del successo dell’uno come fondatore di una religione, cos’altro permette di distinguere la rivelazione di Dick da quella di Paolo? Se uno è credente pensa che Paolo abbia avuto a che fare con il vero Dio, mentre Dick no, non era the real thing, era un herzat creato dalla sua fantasia. Ma se uno non è credente la differenza tra Paolo di Tarso e Philip Dick è inesistente. Per me è stato interessante tenere sott’occhio il caso di uno come Dick, spirito vicino, un contemporaneo morto neanche trent’anni fa, autore di libri di fantascienza, gran scrittore contemporaneo. In lui c’è qualcosa di molto prossimo a quanto osserviamo in Paolo di Tarso. E lui spesso si riferisce a Paolo di Tarso. È stato divertente il fatto che non avessi riletto il mio libro su Dick alla fine del mio periodo cristiano, però è un libro collocato costantemente sotto l’autorità della figura di Paolo. Si parla di San Paolo nel mio libro su Dick, e viceversa di Dick nel Regno.
Nicola Lagioia: Leggendo Il Regno si può fare un po’ di surf tra i libri di Carrère. Prima abbiamo citato quello su Philip Dick, ma nel romanzo tiri in ballo anche Jean Claude Romand, il protagonista di L’avversario. Jean Claude Romand è l’uomo che mentì alla sua famiglia per una serie di anni, si fingeva medico all’Oms, contraeva debiti anche con la sua amante, insomma una vita basata sulle menzogne. Infine trovò meno difficile sterminare la famiglia che raccontare la verità. Nel Regno Romand viene tirato in ballo quando è già stato condannato all’ergastolo: Carrère si avvicina a quest’uomo perché vuole raccontarne la storia, e a un certo punto Romand domanda a Emmanuel Carrère, “Sei cristiano?”
La fase cristiana di Carrère ormai sta finendo, dovrebbe rispondere no, e invece risponde sì e sul perché risponde sì dice una cosa che a mio parere è uno dei momenti più alti del libro: “Chi può saperlo se il Dio dei cristiani esiste o non esiste, significa in senso stretto essere agnostici: riconoscere che non sappiamo, che non possiamo sapere e, poiché non possiamo sapere, poiché non possiamo dare un giudizio definitivo, significa non scartare completamente la possibilità che nel segreto della sua anima Jean Claude Romand abbia a che fare con qualcosa di diverso dal bugiardo che la abita. Questa possibilità è ciò che chiamo Cristo e se gli ho detto, a Romand, che ci credevo o cercavo di crederci, non è stato per diplomazia; se Cristo è questo posso, anzi, dire che ci credo ancora.” In che senso credi ancora da questo punto di vista?
Emmanuel Carrère: Non posso commentarlo, ma mi sembra relativamente chiaro. Se parliamo del cristianesimo, ad esempio, a parte coloro che accettano tutto in blocco – e questa è un’altra cosa, questo accadeva a me vent’anni fa – in fondo tendiamo a chiederci qual è per noi il cuore del cristianesimo. Il resto sono dogmi, il resto sono cose che forse non hanno molta importanza per noi o non ne hanno nessuna; però c’è qualcosa – parlo per me, ma non credo di essere l’unico – che mi avvicina molto al cristianesimo; c’è qualcosa che resta vitale per me; e che cos’è? Questo varia a seconda degli individui.
Ci sono delle persone per le quali il cuore assoluto del cristianesimo è la fede nella resurrezione; Paolo diceva questo: se non credi nella resurrezione non sei cristiano. Ecco… essere cristiani è credere nella resurrezione; ma non è questo il senso che io do al cristianesimo; in effetti uno dei modi, se io cerco di andare al nucleo centrale del cristianesimo e della fede cristiana, per me direi che si esprime nell’esempio di un uomo come Romand. Non è il fatto che Romand abbia commesso questo gravissimo reato – ha ucciso tutta la famiglia, i genitori, i figli… – soprattutto ha mentito per tutta la vita, e in fondo non possiamo impedirci di pensare che è un uomo che continua a mentire continuamente, non può fare a meno di farlo, è la sua struttura psichica, è un uomo della menzogna. Quindi c’è una sorta di vertigine metafisica, addirittura religiosa.
Il titolo, L’avversario, è uno dei nomi di Satana, è una figura del diavolo, è una figura del male, l’Avversario è colui che mente. In prigione Romand a un certo punto si è convertito, è diventato molto pio, pregava continuamente… Il dubbio è concesso, è permesso, e molte persone, ricordo anche durante il processo di Romand, tra i giornalisti che seguivano il processo, molti erano anche un po’ disgustati da questa conversione, perché era veramente il colmo dell’abiezione e dell’ignominia. E possiamo sostenere questo perché, se hai passato tutta la vita fingendo di essere un medico mentre non è vero, a un certo punto vieni smascherato, e questo è quello che è successo. Se dite che siete in comunicazione con nostro Signore Gesù Cristo nessuno potrà dimostrare il contrario, è una fortezza che non può essere espugnata e lui la porta avanti e vi si ferma fino all’ultimo giorno della sua vita. È la menzogna più potente, la più poderosa. Per me il cristianesimo consiste nel dire: non è detto, non è sicuro, non è del tutto sicuro perché può darsi che nell’anima di Romand, e questo è già un postulato, forse nell’anima di quest’uomo sta succedendo qualcosa che noi ignoriamo, che non sappiamo, per cui quando afferma di esser in comunicazione forse non è una menzogna ma esiste qualcosa nella sua testa, una credenza che si chiama Cristo. È una idea di Gesù minima, ma nel contempo è abbastanza impegnativo voler credere a una cosa del genere. È una definizione assai poco ecclesiastica del cristianesimo. Ci sono tantissime cose che sembrano definire il cristianesimo. Ti ringrazio di aver letto quel passaggio, perché anche per me quel passaggio del libro è centrale. È uno di quei luoghi in cui si va a toccare proprio il cuore del cristianesimo.
Nicola Lagioia: Vorrei ora provare a farti una domanda politica, una domanda che c’entra forse poco con il libro, ma che mi è venuta in mente mentre lo leggevo. Barack Obama è cristiano, Angela Merkel è una fervente cristiana, il nostro presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è cristiano, François Hollande forse non è cristiano ma ha avuto una formazione cattolica, Putin è ortodosso; allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui le prime novanta persone più facoltose detengono una ricchezza pari a quella dei 3,5 miliardi di più poveri. Allora, per parafrasare proprio il vangelo di San Luca, “chiedete e vi sarà tolto”. Ecco, c’è qualcosa che è andato storto?
Emmanuel Carrère: Sicuro che c’è qualcosa che non torna, altroché! In fondo, in ogni caso, c’è qualche cosa che turba nel fatto che un messaggio così radicalmente sovversivo e così ribelle a qualsiasi istituzione come il messaggio evangelico, sia diventato lo zoccolo di una istituzione così durevole e potente come la Chiesa. È veramente strano, è molto strano, ma, detto questo, è un paradosso… è uno di quei paradossi di cui è intessuto il cristianesimo. Penso comunque che vi è una vaga coscienza di questo lungo tutta la storia della Chiesa. C’è sempre stata questa nostalgia della sua infanzia, vale a dire i tre anni in cui Gesù ha predicato in Galilea a una manica di poco di buono, di rifiuti della società, le persone verso le quali andava la sua stima e il suo affetto, una costante assoluta. C’è poi un’altra cosa sorprendente, l’associazione tra il cristianesimo e le posizioni politiche conservatrici, un fatto storico molto frequente. Sembrerebbe inconcepibile, difficile da immaginare che alla base del cristianesimo vi sia qualche cosa che autorizzi in qualche maniera posizioni conservatrici, reazionarie.
Il cristianesimo è fatto di paradossi di questo tipo, c’è qualche cosa di veramente paradossale. Quasi per definizione è una cosa non applicabile alla società, eppure esiste come una cosa che sta sul fondo della coscienza, un qualcosa che indica la direzione in cui bisognerebbe andare quantunque non si sia affatto capaci di andarci. Le persone che pongono veramente in atto il messaggio cristiano sono davvero rare, e quando lo fanno suscitano la nostra ammirazione, ma ci sono anche delle persone per cui è una cosa sedimentata nella loro coscienza e anche se un po’ caricaturale sarebbe triste se sparisse dalla coscienza degli uomini. È stato uno dei quesiti che mi sono posto scrivendo Il Regno. Molti di noi non siamo più cristiani, però che traccia ha lasciato questo nella nostra coscienza? Non è una cosa puramente culturale, storica, è qualcosa del cristianesimo che continua tuttora a tormentarci, in un modo che non trovo affatto negativo.
Nicola Lagioia: “Facciamo ora un gioco”, per citare un altro libro di Carrère, un gioco che ho pensato chiedendo su facebook se c’era chi volesse fare delle domande a Carrère. Ne sono arrivate una serie e io ne ho scelta una: “Molti scrittori ultimamente stanno tornando a occuparsi di questioni religiose; non solo Carrère ma anche Houellebecq o Amos Oz attualizzano le questioni religiose. Allora”, ci chiede questo amico, “cosa pensa Carrère dell’avanzata dell’Islam radicale nei territori più poveri del mondo, nella parti più povere delle nostre città? Non rischiano di assomigliare a quelle dei cristiani del primo secolo? E allora se fosse compito della chiesa cattolica arginare l’Islam radicale sarebbe più utile un uomo come San Paolo o un uomo come Gesù? E se invece fosse compito dell’Occidente laico arginare l’Islam radicale cosa bisognerebbe fare, non bisognerebbe forse dare fondo alla nostra seduzione più narcisistica e commerciale, al consumismo come antidoto al fanatismo?” Questa era un po’ la vecchia posizione di Houellebecq che diceva che per l’Islam radicale anziché sganciare bombe bisognerebbe paracadutare minigonne e reggiseni…
Emmanuel Carrère: Sono tante domande in una. Come prima cosa penso che nessuno si aspetti che io dica che approvo l’Islam radicale, e che considero bello sparare addosso alle persone quando non si apprezza ciò che dicono o scrivono. In ogni caso il cristianesimo dei primordi aveva poco a che fare con questo, l’antico cristianesimo non aspirava a nessun potere temporale. Apro una parentesi: quando confronto il cristianesimo dei primordi e il comunismo degli esordi, tra loro vedo delle differenze, e cioè che il cristianesimo primitivo non ha mai praticato lo sterminio fisico dei propri oppositori, e direi che questa è una differenza piuttosto importante. D’altro canto in una fase molto più tarda della sua evoluzione il cristianesimo ha anche conosciuto le sue brave intolleranze, i suoi bravi roghi, il suo fanatismo. Ma è una religione che è molto più antica dell’Islam, e che ha anche il vantaggio di essere diventata inoffensiva, forse molto più debole di quanto si pensa, come dimostra il fatto che si possa scrivere un libro come il mio senza suscitare alcuna ostilità negli ambienti cristiani, a parte qualche integralista che scrive articoli di disapprovazione e si ferma lì. Questo è un grande progresso. Cosa sia necessario fare per contrastare l’islam radicale francamente io non lo so proprio, e mi stupisce il fatto che ci siano delle manifestazioni nel mondo arabo per protestare contro le caricature di Maometto e non per protestare contro coloro che offendono l’Islam sparando addosso a chi ha fatto la caricatura di Maometto, cosa che per me rappresenta un’offesa molto più grave all’Islam, ma su questo punto, come tutti gli altri cittadini, non ho da dare lumi particolari, non sono un buon conoscitore dell’Islam, sono uno qualunque, in questo senso inorridito dagli eventi recenti e da ciò che non cessa di verificarsi dappertutto, terribilmente preoccupato per la piega che stanno prendendo le cose.
Nicola Lagioia (Bari 1973), ha pubblicato i romanzi Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi) (vincitore Premio lo Straniero), Occidente per principianti (vincitore premio Scanno, finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (vincitore premio Viareggio-Rčpaci, vincitore premio Vittorini, vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e La ferocia (vincitore del Premio Mondello e del Premio Strega 2015). È una delle voci di Pagina 3, la rassegna stampa culturale di Radio3. Nel 2016 è stato nominato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.



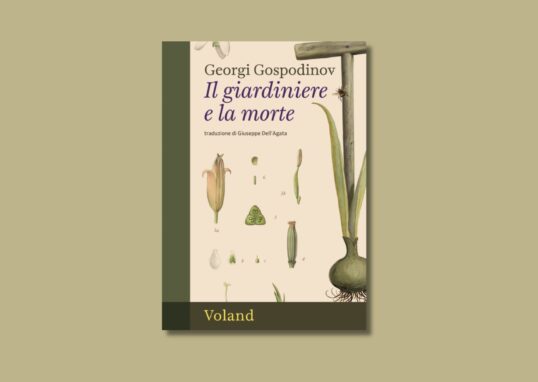
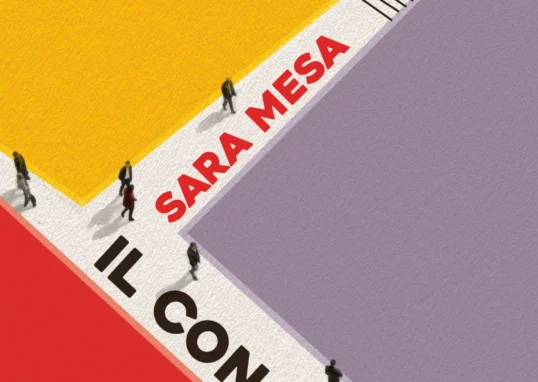
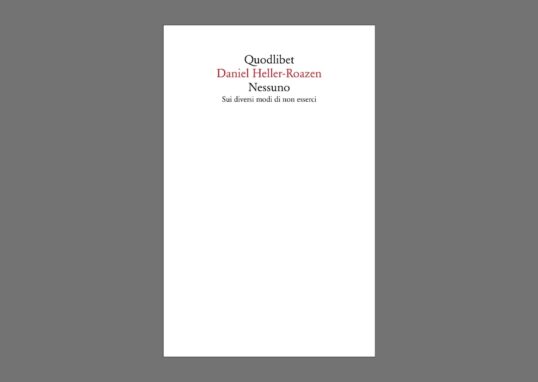

Grazie per aver messo a disposizione questa bellissima intervista. Ho un dubbio per chi l’ha tradotta: “Nella ventina di anni in cui ormai sto praticando questa forma, che non è fiction letterale”. “fiction letterale”? FIction “nel senso letterale del termine” o “fiction letteraria”? Grazie ancora!