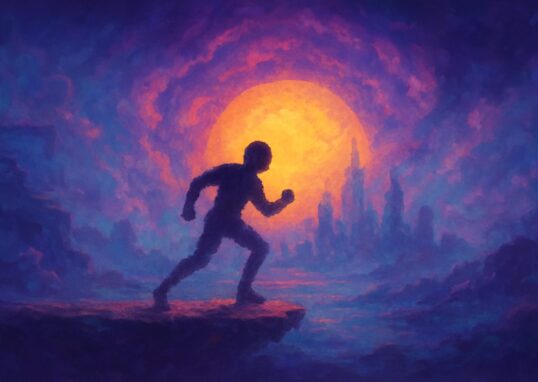Und mir scheint fast
Dass eine dunkle Erinnerung mir sagt
Ich hatte in fernen Zeiten
Dort oben oder in Wasser gelebt
[Franco Battiato – Un oceano di silenzio]
Nella mia ultima lettura (Santi Numi, 12 novembre 2021, per i pochi scansafatiche che seguono questa rubrichetta) rimbalzavo una domanda: cosa mi piace nei libri che leggo? Evidenziavo due aspetti e di uno ne parlavo proprio grazie al libro di Jacopo Masini, il divertimento, per l’altro rinviavo la riflessione a data da destinarsi. Sto parlando dell’inadeguatezza. Ora è arrivato il momento di parlarne. E quale libro migliore dell’insieme di saggi Una possibilità del linguaggio, Pierre Menard come metodo, ultimo lavoro di A. Z., che già dal titolo ti pone sorridendo una domanda: sei sicuro di aver capito di cosa stiamo parlando? No, assolutamente no, ed è questo il bello. È questa l’inadeguatezza di cui sopra. Siano benedetti i libri, romanzi, saggi, antologie poetiche, racconti, che non si capiscono alla prima lettura – e magari neanche alla seconda, o quanto meno non del tutto. Qualcosa che sfugge alla determinazione. Una scossa, una frattura, un cortocircuito, un entusiasmo senza precisa ragione. C’è un sottile piacere nel non vedere e nonostante questo, o proprio per questo, continuare ad avanzare. Basta intuire, cogliere per un momento il riflesso di una moneta d’oro alla fine del corridoio buio, il miraggio di un’oasi, per rimettersi in viaggio. Perché o è così oppure di fronte a questo saggio, ma più in generale di fronte ai lavori di A. Z., siamo vittime di una follia collettiva. In tal caso avvisatemi, e presto.
La mia attrazione per questo testo arriva da lontano. Alla domanda è nato prima l’uovo o la gallina? preferisco la versione sono nate prima le parole o le cose? Il linguaggio è un enigma affascinante che possiamo risolvere soltanto grazie al linguaggio, proprio come il più perfetto dei delitti risolvibile soltanto grazie alla confessione del colpevole stesso. È evidente che le cose, o buona parte di esse, esistessero ben prima che l’uomo si dotasse di un linguaggio in grado di identificarle. Esistevano nel mondo, nello spazio e nel tempo, ma esistevano per l’uomo? Probabilmente no, e in questa visione si comprende il potere fondante del linguaggio. C’è un romanzo, Amatka di K. T., che ha solleticato le mie fantasie: in un nuovo e lontano mondo le cose tendono a ridursi in poltiglia, sostanzialmente a scomparire, se il loro nome non viene scritto e pronunciato con dovuta e prefissata frequenza. Le cose, quando non sono più nominate, spariscono. E se nel romanzo questo accade sul serio, nel quotidiano questo accade in senso lato: ciò che sparisce dalla nostra lingua, scompare anche dalla nostra vista. Ma torniamo ai saggi di A. Z. che il giro perlustrativo, questa volta, è durato anche troppo a lungo. Spiegare questo testo è impresa impossibile, quindi mi limiterò a parlarci sopra, ad amplificare gli spunti. Che poi è quello che faccio ogni volta che scrivo su queste pagine, ma meglio specificare che magari qualcuno s’aspettava di capirci qualcosa.
Ad accompagnarmi in questo tentativo goffo e grottesco di lettura mi faranno compagnia quattro testi + 1, tutti dei saggi più o meno noti. Prima però vorrei riportare in modo più o meno preciso le note che ho appuntato al margine del testo: l’effetto che ho provato durante la lettura è stato quello di una sbornia. Euforia, nausea, vomito, sonnolenza, vergogna, mal di testa, entusiasmo. Avvicinandoci così tanto alle cose ne deformiamo l’immagine fino a ricostruirne una versione distorta dentro di noi. In questo insieme di saggi A. Z. ci fa salire sulle montagne russe di questo peculiare posizionamento. Pierre Menard è l’esempio estremo di questa posizione, personaggio creato dalla penna di Borges che si pone l’obiettivo di riscrivere il Don Chisciotte con le stesse identiche parole, ma non copiandolo, perché il suo senso sarà tutt’altro rispetto a quello del Cervantes. Possibile? In letteratura sì, questo e altro è possibile. Tutto è possibile. In questo inganno, in questa parola che è creazione e bugia, A. Z. insegue il pensiero di Foucault, gli scritti di Piglia e Bolaño, le sintesi di Kiš, la visione scientifica di Bojowald e la sindrome visionaria di Lynch. E lo fa con la naturalezza di una guida turistica, con il sorrisino di un barista ben felice di servirti l’ennesimo giro di bevute nonostante l’evidente sbornia. C’è tanto di quel materiale che si potrebbero scrivere centinaia di pagine per commentare le altrettante centinaia di pagine scritte da A. Z., ma poi si potrebbe procedere ancora a commentare le centinaia sommate alle altre centinaia, all’infinito. In Pensieri Lenti e Pensieri Veloci si legge che l’abisso è vertiginoso, a tratti psichedelico. Proviamo a seguire le impressioni delle vertigini.
Di fronte al conflitto, pagina 13, proposto grazie alla posizione di Kiš verrebbe da evidenziare quanto l’uomo occidentale sia per sua natura, e cultura, un essere tendenzialmente bipolare e binomiale, che oscilla tra i due poli. Chi ha una minima dimestichezza con la filosofia orientale è consapevole che tutti i conflitti sono polari, ma che il loro conflitto non può mai finire con la vittoria né dell’uno né dell’altro. Come ricorda C. nel Tao della Fisica la loro sarà sempre una manifestazione dell’azione reciproca. Rubando una citazione all’I Ching, potremmo dire che ciò che fa comparire una volta l’oscuro e una volta il chiaro è il senso. La nostra prospettiva è quella di una freccia a cui estremi sono posizionati i poli, gli opposti. In oriente tale freccia si curva, si ripiega su sé stessa e i poli diventano le due estremità di una circonferenza sempre in movimento. Il polo nord e polo sud della Terra. I limiti del linguaggio potrebbero dunque non essere più in antitesi con le potenzialità del linguaggio stesso se i due poli non devono più escludersi a vicenda. Blanchot diceva che le contraddizioni non si escludono vicendevolmente, ma neppure si risolvono. Così i due poli, così il conflitto. Ying e Yang in continuo mutamento e correlazione.
La follia, pagina 15, e la prima volta, pagina 25, condensano la prospettiva bambina di A. Z. in questo viaggio. Perché la follia appartiene alla lingua dei bambini capaci di inventare continuamente significati e significanti, proporre soluzioni logiche del tutto impreviste a causa di una loro struttura mentale non ancora normalizzata e privata della magia della prima volta. Le cose che si materializzano nella mente dei bambini non sono tanto diverse da quelle che si materializzano nel laboratorio centrale di Cortazar, l’inventore dei cronopios e dei famas, il più bambino tra gli autori citati da A. Z. Che le tartarughe siano grandi ammiratrici della velocità è cosa del tutto naturale. I famas lo sanno, e ne ridono. I cronopios lo sanno e ogni volta che incontrano una tartaruga tirano fuori i gessetti colorati e sulla curva lavagna della tartaruga disegnano una rondine. In questo linguaggio bambino citerei anche Cărtărescu per l’effetto straniante, l’uso dei colori, la comicità involontaria, le meraviglie che si dischiudono davanti agli occhi e nella pagina, ma rischierei di annoiarci più del dovuto.
Sorvolando, per poi ritornarci più avanti, sui concetti di spazio, tempo, vuoto e pieno, giungiamo ad alcune pagine nelle quali si gioca con Menard, riscrivendo la sua esperienza come un vero e proprio metodo, una possibilità del linguaggio. A. Z. scrive che sebbene le parole del Chisciotte di Menard riproducano fedelmente l’originale di Cervantes queste sono uguali eppure completamente diverse. C’è uno sdoppiamento, con conseguente svuotamento e riempimento di senso, che si genera ogni volta che le parole vengono ripetute se cambia l’autore. Questa è una speculazione metatestuale, è un gioco a loop, ma se ci spostassimo dalla riproduzione scrittura-scrittura e ci avvicinassimo alla riproduzione scrittura-lettura? Non è vero anche in questo caso che le parole scritte dall’autore, qualunque esse siano e qualunque esso sia, sono uguali a quelle che il lettore, chiunque esso sia, leggerà eppure completamente diverse? La riscrittura operata da Menard non è ciò che la lettura fa da sempre con la parola scritta? Riprodurre nelle mente, sdoppiare la parola della carta, svuotarla di senso e aggiungere pescando dall’esperienza personalissima del lettore. Anche se l’ultima frase è un’affermazione, la mia resta una domanda. Con tanto di ?.
A partire da pagina 38, l’autore si avvicina a quell’abisso che prende la forma, se così si può dire, prima di una piega e quindi di un vuoto. Nel mezzo, l’impressione che A. Z. si accosti prima a quella che potremmo definire l’ombra di un senso, la riserva di senso di Foucault. Uso la parola ombra perché da un punto di vista scientifico questa non è altro che una proiezione e non esiste in sé, senza la presenza di una fonte di luce – quindi una lente d’osservazione – e varia proprio in base all’angolo d’inclinazione di tale fonte – quindi della stessa lente con la quale si guarda al senso, o meglio alle parole stesse. La speculazione linguistica di A. Z. è vicina ad alcuni aspetti della più recente ricerca scientifica è evidente nell’ossessione per quel vuoto che non solo si cerca di definire, ma infine si prova ad abitare. Questo allargamento di prospettiva – prima cos’è questo vuoto, quindi chi abita questo vuoto poi come si abita questo vuoto – è un processo simile alla teoria dei campi che, partendo da Einstein, ha rivoluzionato completamente il modo di vedere il mondo, almeno per riesce a vedere, ossia i fisici. Cos’è lo spazio, chi abita questo spazio e come si abita questo spazio sono le domande che chi ha sviluppato la teoria dei campi, e prima dei quanti, si è posto e continua a porsi. Tra vuoto e spazio non c’è differenza perché il vuoto è la forma che crea tutte le forme. La distinzione tra materia e spazio vuoto è stata abbandonata quando divenne evidente che le particelle potevano generarsi dal nulla, e nel nulla svanire di nuovo. Fisica, misticismo, filosofia, letteratura e linguaggio agiscono nel reale per mezzo dell’astrazione. Le riflessioni di A. Z. non sono lontane dai testi di Chang Tsai o dagli appunti di Thirring. Non è un caso se il reportage intitolato Il vuoto, pagina 59, riunisce spunti ottenuti dalla lettura di Feynman e Rovelli e dallo scambio epistolare con Bojowald – letteratura e fisica sono già state connesse da A. Z. Ad aggiungere filosofia e misticismo ci penso io traducendo le ultime parole di questo reportage. Il vuoto è, ma non esiste. Una frase non troppo diversa dai primi versi del Daodejing: Il Dao che può essere detto non è l’eterno Dao (dao ke dao fei chang dao). Quindi anche il Dao è, ma non esiste.
Questo ci porta a un’altra riflessione, stimolata da alcuni passi presenti a pagina 68: l’osservazione sposta l’oggetto osservato. Tutto cambia, in costante dinamismo. Ciò che è eterno non è pronunciabile dall’autore e anche il linguaggio non può avere pretese di eternità – con buona pace dei poeti che speravano nell’immortalità letteraria. Le manifestazioni del vuoto sono, come le particelle subatomiche e quindi le parole, non statiche e permanenti, ma dinamiche e transitorie. Ed è il momento di chiudere con un’ultima riflessione sui concetti di tempo e spazio che A. Z. ripropone in coda e che noi abbiamo già rimandato troppo a lungo: lo spazio, nella sua declinazione di forma, ha perso ogni valore deterministico e si piega ben volentieri alle bugie letterarie, al contrario il tempo pare essere l’ultimo baluardo della ragione, estrema ratio del realismo. Però è proprio grazie al ribaltamento del concetto di tempo che il fantastico straripa e produce gli effetti più stranianti; la grande potenzialità del linguaggio è quella di invertire l’irreversibile freccia del tempo. In questa chiave si leggono i capolavori di Borges, di Lynch, ma anche le invenzioni di Adams, il successo di serie TV più recenti, i multiversi Marvel. Perché tempo e spazio sono ridotti al ruolo soggettivo di elementi del linguaggio. Non c’è spazio se non ci sono oggetti, ma allora non c’è linguaggio se non ci sono due uomini. O ne basta uno? Come parliamo a noi stessi? Parliamo sul serio? Qualcuno a cui voglio molto bene mi ha detto che il linguaggio riduce e amplifica, che è una perdita nello stesso istante in cui determina ciò che non è determinabile. Diventa funzione delle cose, così come il tempo è funzione del mondo e ne permette la sua interpretazione anche se ormai è chiaro che non esiste in sé. Le cose dentro lo spazio sono lo spazio. Il tempo ne permette la lettura. Il linguaggio dentro le cose è le cose. Le parole ne permettono la lettura.
Una piccola curiosità: A. Z. riscopre la terzina dantesca, nel senso che molto spesso all’interno del volume riscontriamo una triplice ripetizione. Le parole che compongono le terzine sono: amore – vita – morte; metatestuali – metanarrativi – metaletterari; implica – nomina – tematizza; spazio – tempo – linguaggio; poesia – amore – azione; falso – inganno – equivoco; mondo – pensiero – linguaggio; analogie – slittamenti- deviazioni; linguaggio – pensiero – rappresentazione; sono nove e nove non è altro che tre per tre. Fine della curiosità.
Dopo aver letto le prime due opere di A. Z., la Bomba e il Ritorno, credo di aver individuato un percorso – nonostante la variabilità di forma e contenuto, prima un romanzo, poi i racconti e infine i saggi. Il tentativo di imitare un codice, di decostruire il codice e infine di interpretarlo in tutte le parti che lo compongono. A. Z. ha spiegato e si è spiegato, ha spiegato sé stesso a sé stesso e anche a noi, portandoci nel suo laboratorio centrale. Ha provato a spiegarsi, a dispiegarsi, dilaniarsi, schiudersi, diradarsi nelle sue stesse ossessioni, senza il filtro narrativo. La confessione di un assassino che si credeva innocente, poi non solo si è accorto di aver ucciso per davvero ma ha iniziato a cercare l’arma del delitto e il movente. Ha smesso di applicare per iniziare a cercare, come nelle scienze quando il praticabile deve sostituirsi al pensabile. Esiste un proverbio cinese in uso nelle arti marziali, ma riproducibile per qualsiasi arte e quindi per tutte le cose del mondo: copia la forma, dimentica la forma, comprendi la forma, ricostruisci la forma. Se le prime tre fasi A. Z. le ha terminate non ci resta che attendere la ricostruzione. Il segreto potrebbe nascondersi nelle sue pagine. Infatti nella premessa l’autore giura totale fedeltà a una e una sola delle diverse tesi portate avanti nel libro, ma quale? Che sia forse questa la strada da percorrere per creare nuova parola letteraria? Blanchot evidenziava il ruolo del diario come strumento dello scrittore per ricordarsi di sé quando non scrive. È molto affascinante l’ipotesi della metamorfosi alla quale A. Z. si è esposto, ma sarebbe riduttivo considerare queste pagine come un diario. Forse un diario letterario, delle ossessioni quotidiane, dei retro-pensieri di chi scrive quando non scrive.
La parola è una forma di governo così liberale da farsi usare persino per comunicare l’incomunicabile ed è così dittatoriale che è necessario usarla per comunicare anche le banalità, diceva un amico. La parola è infame.
A. Z. parla oppure taci per sempre, non c’è via di fuga nella scoperta.
Francesco Spiedo (1992) nasce a Napoli, da madre ansiosa e padre operaio, sperimentando fin da subito le conseguenze dell’iperattività. Cresciuto a San Giorgio a Cremano, studia per diventare ingegnere anche se non praticherà mai. Precedentemente animatore, cameriere, concierge, addetto alla sicurezza e ad altre attività non riconosciute dal Ministero del Lavoro, inizia a scrivere su commissione e su riviste, sotto falso nome e come ghostwriter. Stiamo abbastanza bene (Fandango Libri, 2020) è il suo primo romanzo. Crede in Maradona e Woody Allen.