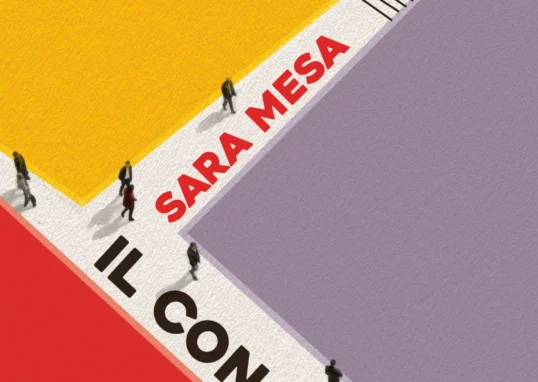Foto di Diego Cuoghi
Per larga parte dei lettori di minima&moralia, Massimo Zamboni non ha bisogno di presentazioni.
Parliamo della mente musicale principale del gruppo probabilmente più influente (come va di moda dire da alcuni anni, “seminale”), degli ultimi quarant’anni in Italia, i CCCP-Fedeli alla linea/CSI. Se Giovanni Lindo Ferretti era il frontman carismatico, il mistico punk che salmodiava testi ipnotici, a metà tra manifesti majkovskijani e litanie popolari, Zamboni creava quelle atmosfere sonore memorabili, immediatamente riconoscibili, stranianti e insieme liberatorie, che hanno influenzato profondamente tutti gli artisti della scena indipendente dagli anni ‘80 in poi.
Un perfetto significante musicale per le parole ardenti e profetiche di Ferretti, talvolta simili a un volantino di un gruppo extraparlamentare, talvolta a una preghiera medievale: la chitarra di Zamboni sapeva esprimere tutta l’energia dirompente dell’essenza punk come restituire la solennità, in un certo senso sacra, dell’impegno ideologico.
Ma Zamboni non è stato, e non è, solamente questo: la sua carriera solistica (come direbbe correttamente Richard Benson), aperta da Sorella sconfitta nel 2004, lo ha visto protagonista di numerose collaborazioni con artisti anche molto diversi fra loro (come Nada e Angela Baraldi) e colonne sonore per registi quali Daniele Vicari, Davide Ferrario e Olivo Barbieri.
Dopo circa dieci anni di silenzio, Zamboni ha recentemente pubblicato un nuovo disco, La mia patria attuale (per Universal Music Italia): un disco spiazzante, per sonorità e tematiche, rispetto alla precedente produzione dell’autore e quindi, proprio per questo, profondamente coerente con la ricerca in perenne divenire che ne ha contraddistinto l’ispirazione.
Se in alcuni brani sembra veramente di riascoltare i migliori CSI, in altri alcuni potrebbero faticare a riconoscere uno dei padri del punk italiano in brani che ricordano il Guccini più classico.
Ma, in realtà, a una conoscenza più profonda delle tematiche storiche dell’autore, appare tutto più comprensibile e coerente.
Ne abbiamo parlato con l’autore.
Qual è stata l’ispirazione di questo progetto?
L’ispirazione è l’ultimo anello di una catena molto lunga. Un percorso che mi riguarda da tempo: situare le proprie appartenenze, capire quali sono i nostri territori, che cosa significa “casa”. qual è la nozione di “suolo”, “terra”, “nazione”, “patria”…tutte parole molto impegnative da affrontare, ma che sono dei veri e propri puntelli per la nostra personalità, che altrimenti rischierebbe di essere smarrita in molte inutilità, in una serie di possibilità che non portano da nessuna parte. Credo, invece, che il confronto con creature immobili, residenze così forti, con tutti i concetti appena esposti, insomma, sia assolutamente salutare. Anche per scappare via, per rifiutarli, non parlo di necessaria accettazione, tutt’altro, ma di un meccanismo di scambio, di un confronto molto fertile, dal mio punto di vista.
Quindi, dopo tanti anni di divagazioni, assolutamente importanti per me, dalla Mongolia a Berlino, dall’Unione Sovietica all’Emilia, è arrivato il momento per me, da adulto, di affrontare il tema più spinoso: Ho una patria? Esiste una patria? Mi sento italiano? Voglio sentirmi italiano? Sono una cellula aliena in un luogo che non riconosco e che non mi riconosce?
Credo sia anche interessante come interrogativi del genere vengano dal pilastro di un gruppo che si chiamava CCCP.
Ovvero, che un artista storicamente schierato a sinistra rifletta su un tema da sempre consunto e manipolato a fini propagandistici dal populismo di destra.
Certamente, io credo che nessuno del “noi” (che non so ben definire ma che so esistere) abbia mai esposto la bandiera italiana se non in occasione di qualche vittoria in un campionato mondiale o europeo. C’è un’istintiva timidezza nel fare questo, una sorta di precauzione, ognuno di noi sente la distanza da questo tricolore che, in realtà, ci dovrebbe rappresentare. Del resto, vorrei ricordare che è nato proprio nella mia città, a Reggio Emilia, più di due secoli. I partigiani avevano su di sé il tricolore, si chiamavano “patrioti”, il P.C.I. esponeva un tricolore, nel quale chiaramente il rosso dilagava, non ha mai dimenticato la nazione in cui esprimersi. “Noi” siamo più in difficoltà in questo senso, perché sappiamo quanti soprusi si sono consumati in nome di questa possibile patria, quante menzogne, quanti infingimenti. L’Italia è una è patria molto abile nei bizantinismi, abbiamo visto cucinare questa parola in tutte le salse, nessuna delle quali ci è parsa convincente.
Forse, è ora di tornare a esaminare la questione.
Parlando di Emilia, e dell’impatto più immediato del disco, talvolta nell’ascolto affiorano delle atmosfere gucciniane. Non so se è stato un preciso e consapevole riferimento o più una vicinanza spontanea, un’affinità sentimentale, essendo stato Guccini un grande interprete del tema stesso di “casa” e territorio (non solo nell’album Radici ma sempre più negli ultimi anni con la mitologia poetica di Pàvana).
Credo sia più una vicinanza di sentimento, non ho pensato direttamente a Guccini per questo disco, anche se è sicuramente l’unico cantautore che ho amato in vita mia. Nella nostra cultura è molto diffusa questa capacità, tutta italiana, di scrivere canzoni dai testi anche profondi, in buona parte, e credo che ognuno di noi l’abbia assorbita, senza nemmeno accorgersene. Questo, appunto, è capitato anche a me, pur non avendo praticamente mai ascoltato nessuno di quel genere. Non per disprezzo ma perché semplicemente la mia vita andava da altre parti, non avevo bisogno di quella modalità di espressione. Il fatto che io mi avvicini ora a questo genere… sorprende me per primo.
Ma al di là di questo, riflettendo ho capito come in realtà sia stata una scelta voluta: se parliamo di patria, di nazione, tra italiani, allora dobbiamo farlo con le armi che ci sono proprie. Quindi, nessun scimmiottamento anglosassone, nessuna elettronica continentale.
Io vorrei che ciascun ascoltatore, una volta messo questo album nel suo lettore o sul giradischi, pensasse: “Sono in Italia”, con tutto il bene e con tutto il male che ciò può comportare.
In alcuni brani si sentono echi chiari della tua esperienza precedente, potrebbero stare in un disco dei C.S.I. senza destare sorprese (e per ciò che mi riguarda è un complimento)…
Lo accetto volentieri.
…ma ci sonò dei brani come “Italia chiamò” o “Il nemico” che, invece, hanno un respiro più cantautorale classico e sembrano quasi voler rovesciare, attraverso quel codice, la retorica nazionalistica, sia quella di stampo trionfalistico che quella di stampo xenofobo.
Spesso nell’additare l’arrivo di un nemico straniero non ci accorgiamo che chi alimenta, dietro le nostre spalle, quella fiamma, in realtà ci è molto più nemico.
Nemico della nostra democrazia, della nostra intelligenza, della nostra voglia di esserci.
Nell’ultimo brano, Il modo emiliano di portare il pianto, è interessante come, in un disco dedicato alla patria, affiori anche la fierezza dell’identità locale, in un omaggio alla particolare sensibilità emiliana. Un brano molto serio, liricamente elevato, che compie il percorso di riconquista identitaria del disco.
Certo, l’Italia è in realtà una federazione di regioni più che un paese unito. Sentiamo moltissima distanza tra una regione e l’altra e io, da emiliano, non sono esente da questo: se dovessi pensare alla mia vera “patria”, per me sarebbe quella che vedo attorno a me, ai confini perfetti di questa regione. Però questa rivendicazione non è un ripiegamento, anzi è un’espansione: l’Emilia, tra i suoi pregi, ha sempre avuto quello di non chinare mai lo sguardo, cioè di considerare tutto ciò che avviene al mondo come qualcosa di “casa nostra”. Non c’è una chiusura imposta dai tre confini, ma c’è un allargamento dettato dalla consapevolezza di questi confini. Questo per me è un valore assoluto.
Come è un valore assoluto uscire dalla parte spiritosa, ironica, convenzionale, che è un gioco abbastanza semplice, mentre è molto più difficile il contrario, trovare parole assennate per parlare della tua regione, delle tue appartenenze. Scavare in profondità, anche in maniera poco accattivante se vogliamo, ma porsi con un’altra modalità, che non sia quella necessariamente dello scherzo, della leggerezza, Sento i secoli che passano, sento le genealogie prima e dopo di me, sento questa voglia di scavare in profondità, più che di estendermi.
Mi ha colpito molto Canto degli sciagurati: dal titolo potrebbe ricordare un brano di De Andrè, ma in realtà potrebbe benissimo essere una delle Canzoni, preghiere e danze del II millennio- sezione Europa.
Diciamo, che “gli sciagurati” rappresentano un ruolo eterno, non ho voluto dare a loro una connotazione di classe. Non sono ribelli, non sono contadini, non sono rivoluzionari: è la condizione umana che insorge contro l’impossibilità di andare avanti, contro la coercizione. Il video che abbiamo ricavato da questa canzone, girato da Piergiorgio Casotti, è un complemento fondamentale per intenderne il senso.
Vi si racconta, come in un piccolo film, la storia di questi sciagurati che si offrono alle pallottole dei loro aguzzini in maniera assolutamente sfrontata, sfacciata, sembra quasi che chiamino gli spari, poiché non c’è offesa maggiore che puoi fare al tuo nemico che irriderlo esponendo il tuo corpo in maniera irrimediabile.
Nel panorama culturale, non solo musicale, italiano trovi qualcosa di interessante in cui riconosci il seme delle vostre esperienze?
Fatico un po’ a rapportarmi con queste cose, perché al di là degli amici storici come Vasco Brondi o Vinicio Capossela, che nonostante la distanza artistica sento dei veri e propri compagni di strada, non frequento nessuno, non leggo niente, non guardo la tv…
…”non faccio sport”…scusami, era obbligatoria!
Calcola che ho il manifesto con quella frase all’entrata del mio studio. Tuttora per me è così. Sono paradossalmente ripiegato su me stesso, anche se in realtà non è vero: intendo dire che ho ancora così tanto da scrivere, cantare o da comporre che non voglio concedermi distrazioni.
Questo è anche un pensiero che ho trovato espresso in maniera eccelsa da Emily Dickinson, citando a memoria: “fosse anche lo scomparire del sole/ io non leverei il capo dal mio lavoro”. Ho ancora troppe cose da fare.
Dickinson è per me un monumento.
Quali sono, oltre a lei, i tuoi autori di riferimento?
In Italia, senza dubbio i grandi più vicini a noi, della seconda metà del Novecento: Fenoglio, Pavese, Calvino, ma ce ne sono molti altri a cui attingere. Se devo andare indietro nel tempo, sento molto vicino il respiro dell’Ottocento americano, quando c’era ancora uno spirito autenticamente democratico, penso a Walt Whitman, ma anche a Jack London. L’idea di stare in mezzo alle persone, un’idea forte che è arrivata fino agli anni ‘60 del secolo scorso, con la beat generation e la folk music. Poi tutto è diventato una serie di discorsi che non portano a niente. Credo di detestare ciò che produce l’America al giorno d’oggi, a parte ovviamente giganti immutabili come Patti Smith o Laurie Anderson, per intenderci. Poi, ci sono i russi, che qualsiasi cosa scrivano è un capolavoro! Riguardo alla letteratura italiana contemporanea fatico molto: c’è questa follia collettiva chiamata…romanzo.
Non porta ormai da nessuna parte, ci sono personaggi che non portano a nulla, sono solo un riflesso delle “grandi manovre” dell’autore. Sempre più difficile è trovare voci alte.
La forma-romanzo è in crisi da un secolo, ma si insiste, credo che sia giunta l’ora di aggiornare il nostro lessico.
Durante il lockdown, mi sono riletto Iliade e Odissea e sono giunto alla conclusione che ci saremmo anche potuti fermare lì.
Trovo molto importante questo non voler regalare i classici, in un certo senso la “tradizione”, alla destra.
Certo, è un discorso pasoliniano. Ma la destra, infatti, non è interessata alla tradizione, ma solo a mantenere i propri privilegi. I discorsi sulla sacralità della patria vanno sempre bilanciati dalla realtà in cui poi in trincea ci mandavano gli altri.
Pasolini scrisse: “io sono una forza del passato”. Un’affermazione che potresti sottoscrivere?
Certo.
Io sento tutta la forza del passato e, al contempo, anche tutta la sua fragilità.
Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e ilfattoquotidiano.it.