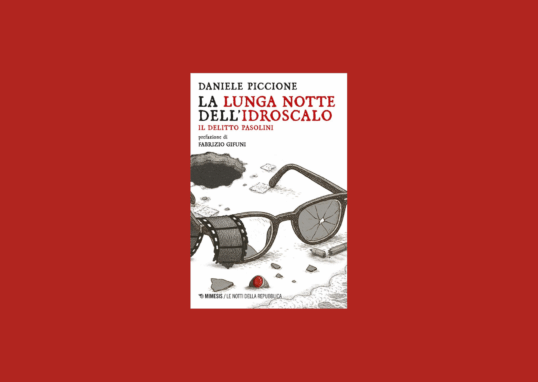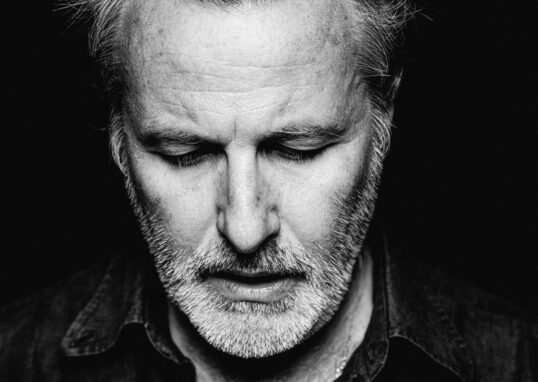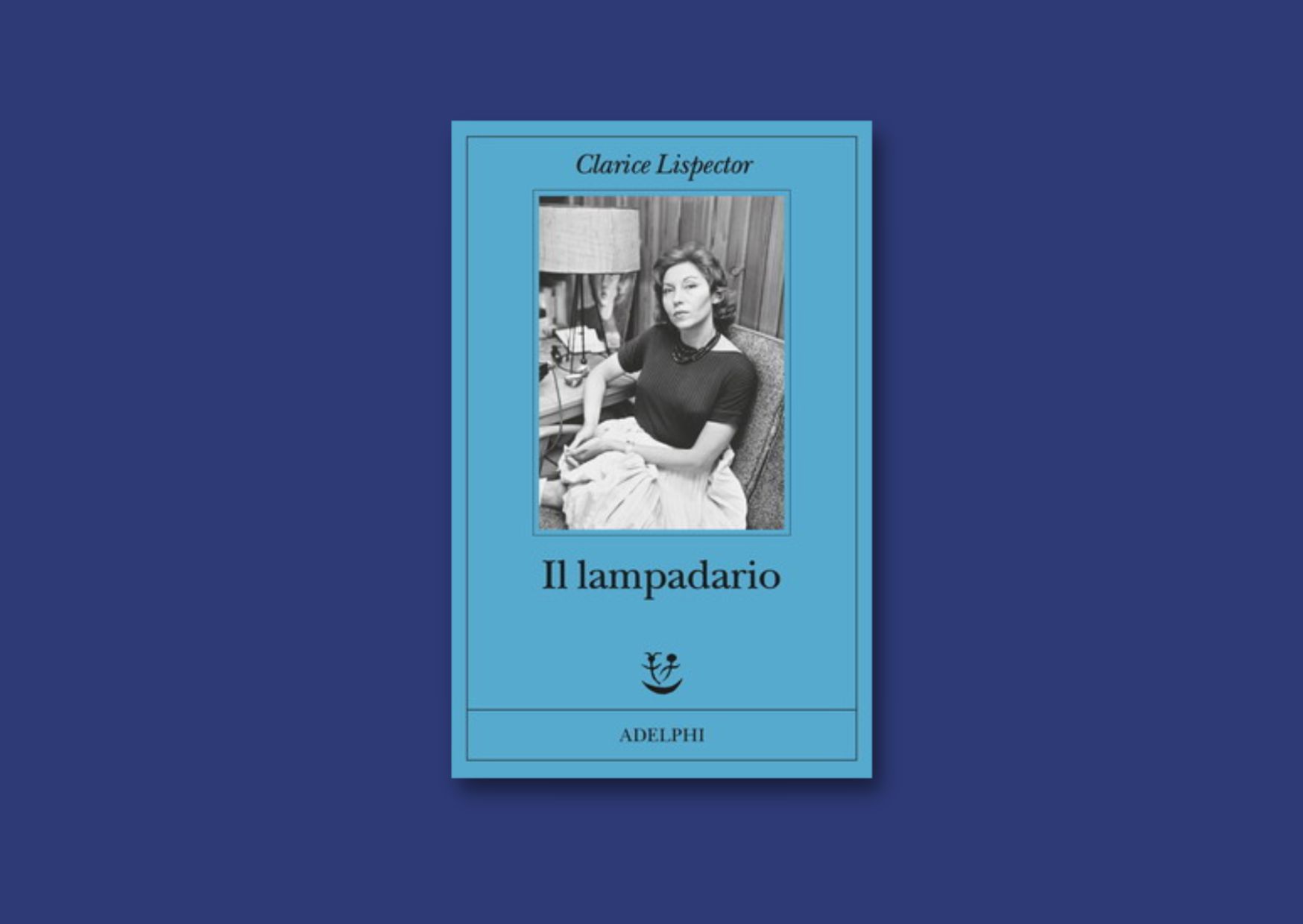
C’è una concezione della letteratura per cui la narrazione si collocherebbe a metà strada tra il puerile e l’oltraggioso, come se raccontare fosse da inabili ritrattisti la cui tavolozza è una crosta di tinte fuse in un solo colore. Si segue una linea facile, incline alla pigrizia, affetta dal pavido desiderio di ritrovarsi nel percorso uniforme di una storia. Roba da giallo per l’estate, che già a inizio settembre, quando la prima frescura rende meno ospitale la spiaggia al mattino, assume tutte le sembianze del senso di colpa. Di questa concezione non c’è esponente più irremovibile di Clarice Lispector, che del suo Acqua viva fa manifesto fanatico di quell’inenarrabilità capace, a suo giudizio, di cogliere la vita, il cui fluire non accorda privilegio ad alcun prima e alcun poi: “[e] la vita è questo istante irraccontabile, più grande dell’avvenimento in sé” (Clarice Lispector, Acqua viva, Adelphi 2017, p. 10). E ha ragione Christina Soto van der Plas quando, senza alcun senso di pietas, confessa che una scrittura così drena, stanca, strema, e alla fine si procura una giustificata antipatia, associata al diritto auto-ascritto di saltare righe, pagine, o persino riporre il libro ai primi accenni di lasciva frammentarietà (https://lareviewofbooks.org/article/un-reading-clarice-lispectors-the-chandelier). Ma cercare una linea su cui adagiarsi, prendere un respiro e godersi una pausa, nei libri di Lispector, è come incamminarsi per una via ferrata in scarpe da tennis: un autolesionismo che vuol solo procurarsi qualche livido e più d’un motivo di rancore. Meglio imbracarsi, munirsi di caschetto e iniziare a salire, sapendo che non si potrà neppure contare sulle prestazioni di quel particolare dispositivo di sicurezza noto come dissipatore.
Da questa intransigenza priva di misericordia si potrebbe trarre una morale certosina, un’etica esasperata, una politica oltranzista della letteratura come esposizione agli accidenti di tutto ciò che è renitente al dicibile se qui non toccasse invece parlare di una sorta di raggiro, di un inganno bell’e buono, di uno spudorato tentativo di abiura, che Lispector sembra consumare ne Il lampadario, tradotto da Virginia Caporali e Roberto Francavilla per i tipi di Adelphi (Clarice Lispector, Il lampadario, Adelphi 2022). In questo libro, il secondo nella carriera della scrittrice ucraina, iniziato a Rio nel 1943 e concluso a Napoli l’anno successivo, niente sembra funzionare. La sorella Tania Lispector Kaufmann dubitava di ogni sua pagina. Il poeta sodale di Clarice, Lúcio Cardoso, consigliava quantomeno di cambiare il titolo, giudicato troppo povero. La risposta, com’è tipico della Nostra, fu senza appello: “Il titolo resta anche se [Tania] ha ragione. Non c’è niente di buono. Il mio problema è che ho solo difetti, quindi se tolgo i difetti non rimane quasi nulla, se non una rivista per adolescenti” (v. Benjamin Moser, Why This World: A Biography of Clarice Lispector, Oxford University Press 2009, p. 149).
A differenza del primo romanzo, Vicino al cuore selvaggio (Adelphi 2003), scritto in frammenti che saltano continuamente da scena a scena, Il lampadario sembra formare un insieme coerente. Verrebbe da gridare al tradimento per chi, come lo scrivente, di ferrate se n’è fatte e ha imparato a godere delle ribalte di effetti sinestetici che destano le improvvise frenate nel flusso narrativo, se quest’impressione di coerenza non fosse invero un escamotage. Un inganno, dunque, ma non un’abiura. Anzi, una radicalizzazione di una postura teorica che Lispector, zelota dell’anti-narrazione, non abbandona neppure nel libro che più d’ogni altro getta false piste. I lunghi segmenti narrativi che lastricano la via d’accesso alle vicende della protagonista, Virginia, sembrano descrivere eventi che sono lacerti di monologo interiore, spezzati da stridenti inframezzi di dialoghi commisti ad azione.
Se ci si ostinasse a leggerlo come romanzo che racconta, si potrebbe sinteticamente dire che Il lampadario si compone di tre piani-sequenza. Nel primo c’è la piccola Virginia dall’infanzia travagliata a Granja Quieta, dominata dalla figura irrequieta e pervasiva del fratello maggiore Daniel, con il quale dà vita alla “Società delle Ombre”, votata alla pratica ascetica di Solitudine e Verità. Il secondo piano sequenza ritrae Virginia adulta che vive in città, lontana dal fratello Daniel, e alle prese con la vita emotiva di Vicente, il compagno, un sostituto funzionale di Daniel, che le richiede più di qualche contorsione. Virginia è una donna che certo è più sicura e ferma che non in adolescenza, eppure non si sente mai davvero all’altezza del tenore e dello stile dell’ambiente intellettualista e borghese in cui si trova gettata. Nella terza sequenza, dopo la morte della nonna, con una vita cittadina in sospeso, Virginia fa visita alla sua famiglia per darsi all’indagine auto-etnografica e farsi una ragione di un amore che non si smorza neppure davanti a delusioni affettive e cadute di stile: “[N]on bisogna vergognarsi di amare la famiglia – era questa la sensazione inspiegabile” (p. 230). C’è invero anche una quarta scena conclusiva, su cui è bene però mantenere il silenzio per chi volesse leggere Il lampadario come fosse Le persiane verdi.
Ma chi ha amato libri come La passione secondo GH, Acqua viva o Un soffio di vita dovrebbe rifiutarsi di cedere al raggiro del trompe-l’oeil e provare a stanare la simulazione cui ci espone questo falso racconto. Cos’è, davvero, Il lampadario?
Secondo un lettore raffinato come Benjamin Moser, che pure non lo considera una ricaduta nella narrazione, Il lampadario è la celebrazione di un’impossibilità: Virginia non è in grado di partecipare alla vita ed è destinata a un perenne isolamento, non importa dove viva o chi frequenti. Questo perché, continua Moser, per Virginia il mondo esterno non esiste: “La libertà di Virginia viene solo dal proprio interno” (Moser, Why This World, p. 51). Celebrazione di un’impossibilità, quindi, che sprofonda nel solipsismo metodico: tutti i mostri della modernità illuminata. Ecco: rigetto una tale lettura, certo plausibile, ma che sacrifica il mio piacere di lettore a un giro a vuoto senza sosta, viziato per giunta da una diade così stantia come il fuori e il dentro. Credo all’opposto che Il lampadario sia celebrativo di tutt’altro, qualcosa che per sua natura non conosce né silenzi destinali né confini tra spazi seclusi. Per rintracciare il vero protagonista del romanzo, vorrei qui affidarmi alla guida sicura di Andrea Zanzotto, benché egli non parli certo de Il lampadario, ma de Le stelle fredde di Guido Piovene. Chi crede che, raschia raschia, l’anima profonda di queste due opere sia la stessa, perdonerà un salto esegetico tanto controintuitivo. Chi di contro non lo ritiene sensato potrà gradire, almeno lo spero, lo stile iridescente eppure sobrio di Zanzotto.
Quello di Piovene è un realismo intriso di visionarietà – e per converso, aggiungo, una capacità di visione che non scade mai nel compiacimento dell’allucinazione. E proprio come Virginia, il protagonista de Le stelle fredde capitola in un “perpetuo ritorno a un ‘luogo’ (inquadrato nel mito dei ‘luoghi natali’ secondo un’incidenza originalissima)” che “ha sempre davanti quella sede unica in cui prende sostanza la stessa unicità, l’individuazione, l’insostituibile storia-memoria del singolo” (Andrea Zanzotto, Premessa, in Guido Piovene, Le stelle fredde, Bompiani 2017, p. vi). E in quei luoghi natali si esercita “più liberamente la sua duttile, prensile capacità di definizione, che invece resta come bloccata davanti ai misteri del ‘luogo’, come avviene per un occhio che veda tutto nei più minuti rilievi, ma di se stesso riesca a cogliere qualcosa soltanto grazie a triangolazioni probabilistiche, a indizi per speculum et in aenigmate” (ivi, p. vi-vii). Come per il protagonista de Le stelle fredde, la produzione verbale di Virginia – se si vuole, unico e vero filo de Il lampadario – è un “chiarire”, un “razionalizzare”, un “verbalizzare”, ma continuamente sottesi “dall’alludere, suggerire, proporre corrispondenze mai del tutto avallabili” a “indicare qualcosa che sta fuori e al di là dello stesso discorso che viene portato avanti” (ivi, p. viii-ix). Come Le stelle fredde, Il lampadario è alfine “opera di poesia, che mette a disposizione qualcosa di assolutamente ‘altro’, in pura perdita, analisi e anamnesi, lotta col mondo e chiusura nell’io, senso dell’irreversibilità del tempo e violenza della memoria, stranezza e ovvietà, passione e ragione, impossibile e necessario incontro del sé con sé e con gli altri, irruzione del fantastico e impatto ruvido col reale” (ivi, p. x).
Sarà bene interrompere qui una pratica che lambisce il plagio – ma riconosce l’impossibilità di approssimare una scrittura tanto penetrante che pure non penetra mai ma sempre sfiora – e dare qualche indizio sulla plausibilità dell’accostamento tra i libri di Piovene e di Lispector. In ambo i libri c’è fobia, ossessione, uggia, incubo, sonno profondo, alterazione delle percezioni, ipocondria, perdita dell’io – insomma, una fenomenologia della disperazione che sembra davvero preludere a un congedo definitivo dal mondo. Eppure, tutto questo non è che il rovescio di altro: in ambo i libri (ma qui, va da sé, interessa soprattutto Il lampadario) c’è un momento di estroflessione cui i due protagonisti non possono sottrarsi mai, vale a dire il rapporto costante con quella che Lispector chiama “realtà innegabile” (pp. 64, 66, 81, 91). Una realtà che si fa beffa di chi la vive (p. 105), che sa essere “nuova e sincera” (p. 131), che appare “deformata e tenera, senza pensieri” (p. 199) anche nelle visioni che rasentano l’onirico. Una realtà, insomma, che ha tutte le qualità dell’esistenza e che pertanto non conserte a nessuno di sfuggirvi, neppure a Virginia. Altro che chiusura al mondo e monacazione degli interni! Il lampadario trasuda di un realismo incallito e invadente, che chiama Virginia a un costante sforzo di individuazione – quello che Jung intendeva come un processo di formazione per differenziazione – possibile solo in rapporto al cosiddetto esterno. L’individuazione di Virginia, nel suo continuo elucubrare, allucinare, avviluppare con parole pensate e sensazioni mute, si ha tramite corpo a corpo con le cose, un “passare dalla parte delle cose”, come scrive Zanzotto a proposito di Piovene, cui Virginia è costantemente chiamata.
Il lampadario è una proliferazione di mondi, un rapporto di osmosi tra dentro e fuori (metafore assai imprecise) che dà luogo a una riproduzione virginale, partenogenesi che permette una casta e persistente fusione tra un mondo interno in perpetuo flusso – “[p]er tutta la vita lei sarebbe stata fluida” (p. 9) – e quel mondo esterno la comunicazione con il quale, per Virginia, era l’“ultimo esistere”, “una frontiera” superata la quale “anche lei era silenziosa come una cosa” (p. 154). In questa concordia di spiriti, la “minaccia di una qualche transizione” (p. 11) è sempre alle porte: un consegnarsi al flusso di relazioni con la realtà circostante che richiede un’insistita negoziazione con le cose: “Faceva, profondamente ignorante, piccoli esercizi e prove d’intelligenza su cose come camminare, guardare gli alberi alti, aspettare nel chiaro mattino il tardo pomeriggio però aspettarlo solo un istante, seguire una formica identica alle altre in mezzo a tante, passeggiare lentamente, fare attenzione al silenzio quasi afferrando con l’udito un rumore, respirare in fretta, portare la mano in fervida attesa su un cuore che non si fermava, guardare con forza una pietra, un uccello, il suo stesso piede, oscillare a occhi chiusi, ridere a voce alta quando era da sola e poi mettersi ad ascoltare, abbandonare il corpo sul letto senza la minima energia sentendo quasi indolenzita da tanto sforzo di annullamento, assaggiare il caffè senza zucchero, guardare il sole sino a piangere” (pp. 27-28).
Insomma, Il lampadario sembra suggellare l’alleanza tra Lispector e quel vasto programma di superamento dell’antropismo auto-logico, più che logico, che tanta antropologia e filosofia materialista oggi cercano di consegnare al passato – non fosse che Lispector le anticipa di circa un cinquantennio. A principio e presidio di questo programma d’evasione dall’umano – che è liberazione dell’umano, sia chiaro – sta proprio il lampadario, l’irrinunciabile eponimo, che Virginia con rammarico si dimentica di guardare al suo ritorno in casa da adulta. Un atto mancato, questo, che dice della possibilità (indesiderata) di perdere un intero mondo: “Ah, il lampadario. Si era scordata di guardare il lampadario. […] Soprattutto non aveva visto anche molte altre cose. Pensò di averlo perduto per sempre. E senza capirsi, sentendo un certo vuoto nel cuore, parimenti le parve di avere perso in realtà una delle sue cose” (p. 273). Quel corsivo è la certificazione di presenza per il vero protagonista del romanzo, le cose, segnate dall’“impossibilità di non esser tali” (p. 274) – e se Virginia vive “al bordo delle cose” (p. 16), proprio al lampadario viene affidato il rito della fusione, ornato com’è dei tratti tipici di chi presidia i passaggi di vita e di morte: talora “si spargeva in crisantemi e allegria”, talaltra “era una casta semente” (p. 17).
Il lampadario è sede di un panpsichismo spudorato ma non mistico – ché sempre di realismo si tratta – che avrebbe fatto la gioia di Spinoza, di cui Lispector in fondo è proteiforme avatar. Un panpsichismo che non è ingenua collocazione della percezione negli oggetti inanimati, ma è piuttosto riconoscimento della capacità dell’indescrivibile connessione di tutti gli elementi del reale e delle loro interazioni ramificatissime: “[P]er nascere le cose devono avere vita, infatti nascere è un movimento – se si dicesse che il movimento è necessario solo alla cosa che fa nascere e non a quella nata non sarebbe vero perché la cosa che fa nascere non può far nascere qualcosa fuori dalla propria natura e così fa sempre nascere una cosa della sua stessa specie e quindi dotata anch’essa di movimento – è così che sono nate le pietre che non hanno forza propria ma che devono essere state vive altrimenti non sarebbero nate e ora sono morte perché non hanno il movimento per far nascere un’altra pietra” (p. 45). È questo un compendio tanto elegante quanto puntiglioso dell’Etica spinoziana, che del dentro e del fuori o dell’umano contro la cosa non sa cosa farsene – come d’altro canto del pensiero contrapposto alla vita biologica: “Lei pensava senza intelligenza la propria realtà come se la vedesse e mai avrebbe potuto usare ciò che sentiva, la sua meditazione era un modo di vivere” (ibid.).
Questo stare dalla parte dell’inanimato non è mai sacrificio del vivente a beneficio delle cose, bensì, dice Zanzotto, “sparire in esse sopravvivendo in esse” (p. xii) per approdare infine alla “ricognizione della propria impossibilità” (p. xiii), dell’impossibilità di un io separato dal circostante. Epperò, come si diceva sopra, non già un’impossibilità di essere al mondo, una difficoltà di uscire da sé, una censura dell’intramondano, ma una chiara consapevolezza che ci si individua solo in rapporto alle cose di cui è fatto il tessuto del nostro mondo: un mondo che per Lispector non si può mettere in parola – “Non ho sentito le parole, non so neanche quali potessero essere, però ti ho risposto, no? […] So cosa volevi dire… non importa che cosa hai detto” (p. 118) – e che pertanto chiama a un reiterato esercizio di ignoranza: sottrarsi a quell’ordine del linguaggio che impone all’essere umano un’esperienza già sempre codificata del mondo e tentare quell’obliquità che permette di vivere di lato, come altrove scrive Lispector: “È che sto percependo una realtà di traverso. Vista da un taglio obliquo. Solo ora ho colto l’obliquo della vita. Prima vedevo soltanto attraverso tagli retti e paralleli” (Lispector, Acqua Viva, p. 68). Vivere di lato, per Lispector, significa porsi in un “luogo dove la luce centrale non mi abbronza” (ivi, p. 70). E cos’è l’odioso ultravioletto se non l’ordine del linguaggio?
Ecco svelato l’espediente iperrealista che fa sembrare Il lampadario una pietra d’inciampo nella lotta di Lispector alla supremazia della parola su suoni, odori, sapori e vibrazioni. L’ingresso che impone a chi legge è sempre scomodo: con improprio e sfacciato dispotismo, chiama a un esercizio di fatica, che lascia a chi legge il manganelliano diritto di scagliare il libro fuori dalla finestra. Eppure, come ogni romanzo di Lispector, Il lampadario consente una prossimità con le cose che risulta tanto forte solo sulla via ferrata, a contatto con la roccia, sospesi in aria, nella fragile presa del moschettone e nella persistente minaccia di caduta. Col lussuoso vantaggio, però, di poter fare tutto questo anche sulla battigia – il che non è male, soprattutto a fine estate.
Mariano Croce insegna Filosofia politica presso Sapienza Università di Roma. Si occupa di critica sociale, postcritica, battaglie LGBTIAQ+ e politiche della trasformazione sociale.