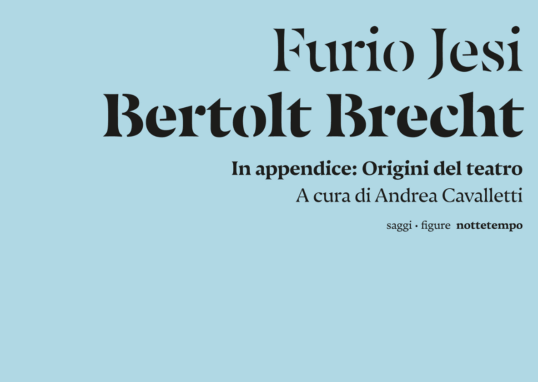«La casa stregata che rappresenta per la ragazza che sono qualunque parrucchiere è spesso ciò che mi resta dell’Africa e della storia della dignità dei miei antenati».
Per scrivere di questo romanzo bisogna assecondare un ritmo, e all’interno di quel movimento, tentare – così come fa l’autrice – di agitare o fermare o pettinare i capelli, come se fossero fatti, questioni aperte, scenari familiari o pubblici, cronistorie di migranti, angoli di città che parlano, esplorazioni adolescenziali, passeggiate adulte. Capelli come se fossero tessuto, trama e perfino il telaio sul quale far scorrere il fiume del racconto. Capelli quali simbolo di appartenenza e di vergogna, come fatica e contentezza, come leggenda trasportata dall’Angola al Portogallo, capelli come cosa viva e lucente. Acconciature che colorano le risate, che sfumano nel pianto, che assecondano il vento e il corpo di una favola. Questi capelli, quindi, il romanzo scritto da Djaimilia Pereira de Almeida (La nuova frontiera, 2022, traduzione di Giorgio de Marchis e Marta Silvetti), il romanzo molto bello e originale che una volta finito mette voglia di ballare anche se tra le pagine nessuno ha davvero ballato, mette voglia di avere capelli ribelli e crespi, perché solo così (ce ne siamo convinti) saremo in grado di raccontare la storia di una famiglia, attraverso due paesi, quattro generazioni. Solo i capelli, i parrucchieri cambiati, le piastre roventi, le creme, gli shampoo giusti, avremo l’esatta lente di ingrandimento, la visuale corretta, il punto di vista più ampio possibile. Se chi ha scritto il libro ci ha convinti di averlo fatto attraverso (e grazie) ai capelli, vuol dire che è stata molto abile, vuol dire che è bravissima.
Ora penso che Maria da Luz deve aver trovato affascinante il movimento dei vestiti stesi al vento. I vestiti al vento per lei sono stati il Portogallo.
Mila ha tre anni quando arriva a Lisbona, suo padre è portoghese, sua madre è angolana. L’autrice scrive di un viaggio spettinato, con la bimba aggrappata a una scatola di biscotti. Quello che conosce delle sue origini è legato ai nonni, ai loro racconti, ricordi e a qualche fotografia, o minuscoli oggetti. Mila (la nostra Djaimilia) usa i ricordi per quello che sono, veri solo in parte, superfici piene di buche, di errori, di mancanze. Ricordiamo qualcosa che ci è stato riportato, e quando rielaboriamo quella stessa memoria stiamo già riadattando, modificando, confondendo. Stiamo inventando, e la parola invenzione è ciò che rende credibile ogni memoir, questo più di altri. In fondo, Pereira de Almeida scrive un romanzo postcoloniale, una geografia politica e affettiva, che va dalle cucine alle strade di Lisbona prima della gentrificazione, dagli album di famiglia alle questioni razziali, dai sentimenti di appartenenza alla voglia di staccarsi e dirsi di nessuno. Mila è alla ricerca della sua identità, ma indaga il complesso meccanismo della memoria e dei vari procedimenti di scrittura, attraverso la trasposizione dei pensieri sui fogli di carta. Ogni storia può essere raccontata, sta alla scrittrice trovare il modo giusto per farlo. Scrivere è un atto semplice e complesso allo stesso tempo, e allora per dire del mondo si può partire da una bimba spettinata, da una scatola di biscotti, dalle strade di Luanda, dai bus e i mercati di Lisbona, da frasi pronunciate da una nonna, dai gesti di una madre, da ogni parrucchiera che agisce sui capelli dicendo male dell’acconciatrice precedente.
Questo libro è scritto in un imperfetto di cortesia. La cortesia è la virtù di ciò che non si può dire, come se non mi restasse altro che fare tante cerimonie con ciò che mi è familiare.
Appartenere o non appartenere? Cosa significa identità? L’autrice è portoghese o angolana? O entrambe le cose? O nessuna delle due? Pereira de Almeida insiste nel cercare un equilibrio tra le due cose, perché se si è figli di due culture si sta in bilico, ci si muove su un confine, e non si è parte di nessun territorio per intero, ci si mostra e ci si nasconde, si ride dell’origine africana, si ride della vita europea, si piange commuovendosi di entrambe le cose. Si è di nessun luogo, di nessuna cultura, ci si tira per la maglia in una direzione o nell’altra, ci si appende per i capelli e ci si lascia dondolare sperando di non cadere o di farlo trovando una nonna (di dovunque sia, non importa se morta oppure no) in grado di acchiapparci al volo.
Per non vergognarci mai più di noi stessi è necessario essere in cammino per diventare qualcosa.
Djaimilia Pereira de Almedia ha quarant’anni ed è considerata una delle autrici più importanti della nuova scena portoghese. Ha una voce interessantissima, colorata, ironica, ritmata, riflessiva, commovente e, l’attimo dopo, comica. Il suo romanzo, per certi versi, suona e – soprattutto – incanta, perché, tra le altre cose, ci costringe a trovare nuovi modi di indagare le nostre origini, le nostre memorie, i nostri transiti, a domandarci (di nuovo e meglio) cosa intendiamo con questioni identitarie, o quanto sia facile essere razzisti, anche senza volerlo (qualche volta), senza accorgercene anche con chi amiamo.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/