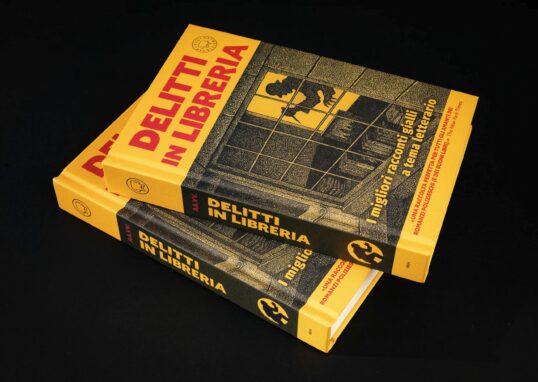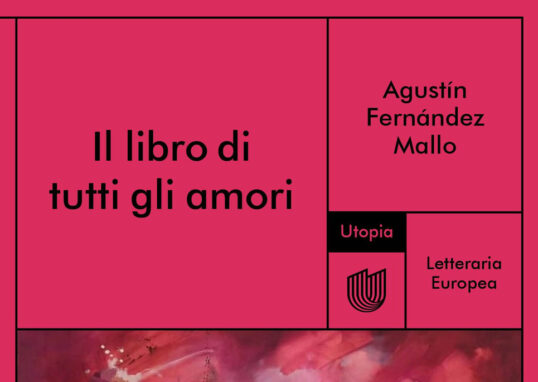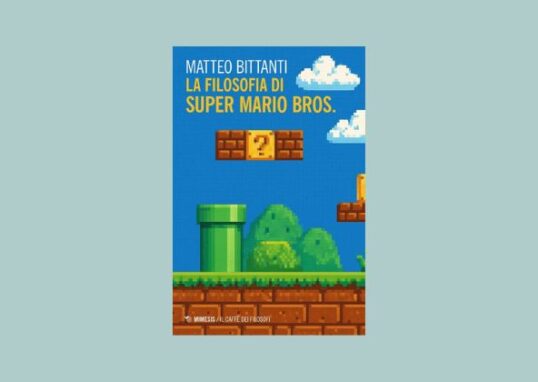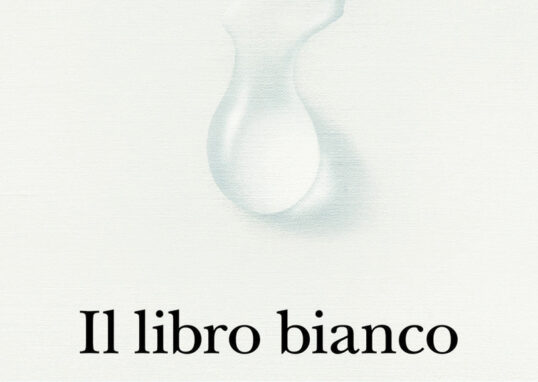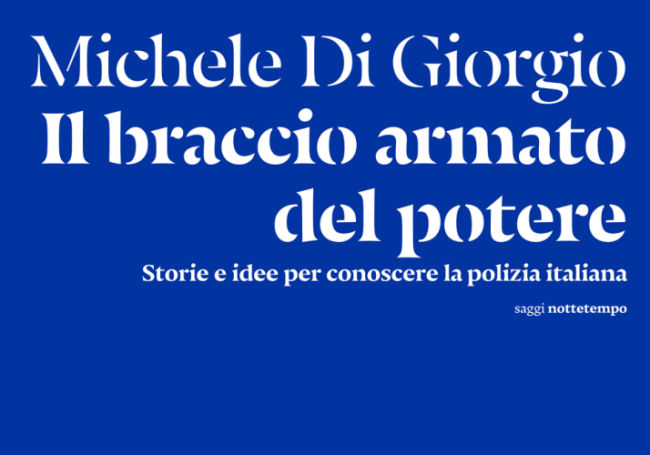
Pubblichiamo un estratto dal libro di Michele Di Giorgio Il braccio armato del potere. Storie e idee per conoscere la polizia italiana, uscito per nottetempo. L’autore presenterà il libro questa sera a Milano, alle ore 19 presso la libreria Anarres: interverrà con lui Carlotta Cherchi.
di Michele Di Giorgio
In numerosi mezzi d’informazione italiani gli approfondimenti dedicati alle polizie hanno assunto quasi sempre la forma di un tributo, di una celebrazione acritica o di un racconto a tinte rosee. Un racconto che ha spesso coinciso con quelli istituzionali. Il risultato è che gran parte di ciò che molti italiani sono convinti di sapere sulle polizie è in sostanza il condensato delle narrazioni che ogni corpo delle forze dell’ordine propone all’esterno grazie a collaudati, e spesso anche raffinati, strumenti di propaganda.
All’interno della stampa e della tv generalista, le stesse visioni hanno spesso influenzato le ricostruzioni e la rappresentazione del passato delle polizie italiane. Analogamente il dibattito pubblico sui problemi delle polizie è stato spesso silenziato e annullato da un coro uniforme che, ripetendo come un mantra la versione delle istituzioni, ha spento o ridotto in sordina le poche voci dissonanti e informate.
Eppure, delle polizie e del loro operato si parla e si discute ormai apertamente in molti contesti a livello globale e non mancherebbero, per corroborare il dibattito pubblico, consistenti e documentati lavori di ricerca sia sul presente che sul passato di queste istituzioni. Nel corso degli ultimi decenni, gli studiosi di scienze sociali hanno arricchito moltissimo la conoscenza che abbiamo delle polizie. E, parallelamente, nel campo degli studi storici si è creato a livello internazionale un vasto e florido settore di indagini in materia: dal Regno Unito, che vanta una tradizione di ricerca antica e solida, passando per la Francia, che negli ultimi trent’anni ha creato una storiografia di notevole spessore, fino a contesti nazionali più lontani e diversi, come quelli sudamericani, dove tali studi hanno raggiunto uno sviluppo molto importante.
Anche in Italia, partendo delle suggestioni lanciate da fondamentali e pionieristici lavori di sociologia usciti dal 2000 in poi, negli ultimi venticinque anni il panorama si è lentamente popolato grazie al lavoro di ricercatori che, con competenze e retroterra diversi, hanno indagato le polizie e il controllo del territorio nelle epoche e negli ambiti più disparati, dal Medioevo fino all’età contemporanea.
Se i lavori scientifici ci sono, non può dirsi altrettanto della saggistica divulgativa, che a partire dall’inizio degli anni Ottanta ha progressivamente perso interesse per il tema, lasciando un vuoto enorme sull’argomento, salvo qualche rara eccezione.
Solo dopo il 2001, sulla scia dei fatti del g8 di Genova, si è ricominciato a parlare in maniera diffusa di polizie, ma limitatamente a quella gravissima singola serie di episodi, su cui esiste ormai una pubblicistica che a spanne conta più di duecento libri. Più di recente, altri lavori si sono concentrati sugli omicidi commessi dalle forze dell’ordine (Aldrovandi, Cucchi e altri), ma in maniera spesso circoscritta ai singoli episodi o alle vittime.
In sostanza, sul fronte dell’informazione e della divulgazione nel contesto italiano è mancata finora, come ha scritto il sociologo Giuseppe Campesi, “la capacità di veicolare efficacemente a un pubblico più ampio le principali acquisizioni della ricerca svolta sulle polizie”. Eppure, nell’attualità e nella storia del paese esse hanno giocato sempre un ruolo di primo piano e conoscerle più a fondo resta essenziale per comprendere il passato e il presente dell’Italia.
Una maggiore conoscenza è fondamentale anche per svolgere quel ruolo di osservazione e monitoraggio necessario ad assicurare la tenuta democratica delle forze dell’ordine. È per questo motivo che le questioni di polizia non devono essere pensate soltanto come materia per tecnici, specialisti o studiosi, bensì come temi che riguardano nel profondo la collettività, la società e la vita di una democrazia. Così come la sicurezza e i suoi attori andrebbero trattati come un bene pubblico su cui vigilare e discutere: un diritto di tutti, specialmente per le categorie sociali più deboli.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente