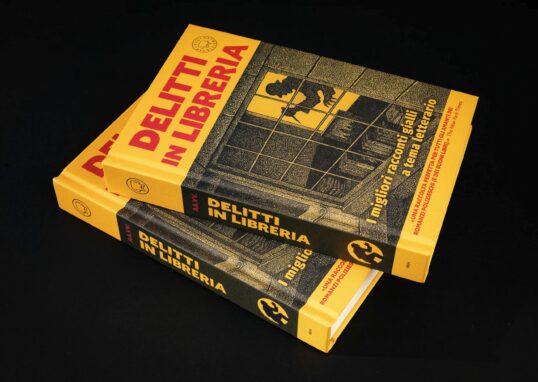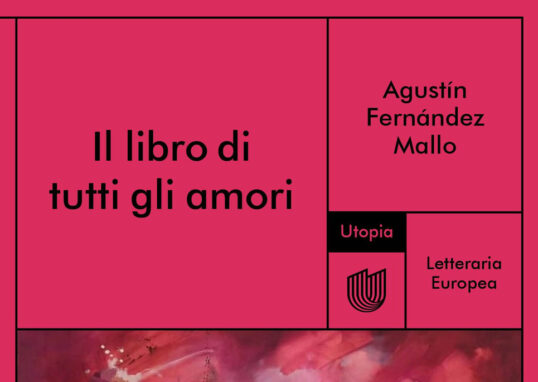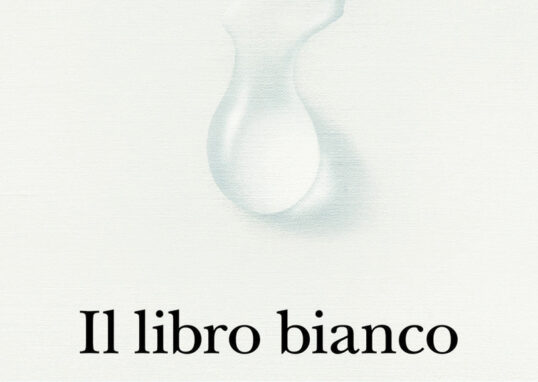Come scrive una poetessa? O meglio, come scrive una poetessa – una che ha sempre scritto poesia – quando scrive narrativa? O meglio ancora, cambia davvero qualcosa se una poetessa scrive narrativa? Cambia il suo approccio? Non ci giurerei. Cambia il suo metodo, forse, ma non ne sarei così sicuro. Cambia il suo sguardo sulle cose? Decisamente no. Cambia l’ipotetica scelta del tema di cui scrivere? No, di nuovo. Non cambia – e parliamo di poetesse e di poeti molto bravi, solo di loro – il modo originale con cui ci si approccia alla scrittura.
La poetessa, e adesso ne sveliamo anche il nome, Rosmarie Waldrop, quando ha scritto il suo unico romanzo lo ha fatto agendo con la sua mente poetica, ha proceduto per scarti, accelerazioni. Ha seguito un processo che slegasse il racconto da una narrazione lineare. Ha scritto come in progressione, come se fosse una conversazione a due e a più voci, come se leggessimo lettere, senza mittente, senza destinatario, ma con più destinazioni. Ha scritto senza trame, a più trame. Il suo metodo ha assecondato il mistero e la rapidità del pensiero. Ha tenuto conto della realtà ma l’ha sommersa di immaginario, l’ha dispersa in dialoghi, frammenti, polvere sotto i tappeti. Ha lasciato alle lettrici e ai lettori il compito di scovarla e di ricomporla. Ha scritto un romanzo originale, bello, terribile e divertente allo stesso tempo: Il fazzoletto della figlia di Pipino, edito all’inizio di questo 2025 da Safarà, con la traduzione di Cristina Pascotto.
Il libro è introdotto da un bellissimo testo di Ben Lerner, che conosce bene le sfumature e le implicazioni del passare dalla scrittura di una poesia a quella di un racconto, da un volume di liriche a un romanzo. Sa che è tutto diverso, sa che è tutto uguale.
Come faccio a sapere cosa ha senso raccontare e cosa dovrebbe essere escluso? Oppure solo atteso, dedotto. Una serie di condizioni iniziali a cui potrebbe seguire qualcosa. La costante solare prima delle influenze dell’atmosfera e delle superfici riflettenti. I temi di una fuga.
Rosmarie Waldrop è un’autrice tedesca, nata nel 1935, naturalizzata americana. È molto nota nell’ambiente delle lettere internazionale, in particolare in quello della poesia. È andata oltre la scrittura e insieme al marito, poeta lui stesso e traduttore, Keith Waldrop ha fondato la Burning Deck Press, considerata una delle più importanti e influenti case editrici degli Stati Uniti.
La trama o non trama, in breve. Siamo a Bayreuth, Germania, nel 1926. Città nota per, tra le altre cose, la produzione di ceramica. La poetessa italiana Anna Maria Carpi così ne scrive in una celebre poesia: «Qui sul mio tavolo: / ho la luce accesa, / una tazza tedesca di Bayreuth […]». In quella città Frederika e Josef si sposano. Un matrimonio che anziché avvicinare due anime diverse, se non gemelle, ne estremizza le differenze e così due persone già molto distanti si allontanano sempre di più, smarriti in differenze glaciali, dando un nuovo significato domestico al concetto di spazio siderale. In quello spazio, in quelle incomprensioni, in quella economia da interni che spreca gesti, oggetti, amore, si colloca e muove un destino più grande, tristemente noto: l’affermazione rapida, rapidissima, del Nazionalsocialismo e perciò di Hitler e della fine del mondo così come fino a quel tempo lo avevamo conosciuto.
Vado di nuovo su e giù, Andrea. Fra tre periodi e due lingue. Tra letti e case. Analogie e supposizioni. Un uovo come un’altra gemella, un ricordo che assomiglia molto più a una congettura. Nessun metodo. Nessuna prova. Nessun progresso. E tutto per evitare di rispondere alle tue domande su Gillian.
La storia viene narrata da Lucy, la loro figlia, a lei Waldrop affida il suo intento, ovvero dimostrare che il male (come il bene) si annida nei piccoli gesti, nelle piccole cose quotidiane. La domanda è: quanto di quello che ognuno di noi, in privato, si riflette sul collettivo? Quanti piccoli tradimenti, bugie, errori, omissioni, incomprensioni, ferite, piccoli tagli possono indirizzare una comunità verso il disastro. Un mondo verso l’orrore più grande e la sua fine. Un’opera, questa, sul desiderio e sulla sua assenza, su come tutto sia politico. Come scrive Lerner, si tratta anche di un testo che analizza il problema della narrazione. Così facendo ne amplia le possibilità
Alcuni gesti. Un tradimento, lo schiaffo dato a un bambino, una canzone cantata male e un’altra non ascoltata per tempo, non capita, una mano che impugna con forza un coltello da macellaio e, infine, il gesto leggendario della figlia di Pipino il breve: lasciare cadere il fazzoletto da una finestra del castello di Schwanberg. Quel semplice gesto in seguito fondò la città di Kitzingen.
[…] Entrambe abbiamo lo spirito delle assassine. Quando nel mio sogno impugno il coltello, intendo colpire. Quando impugno la penna, intendo maledirla, e non certo per un amante o due, ma per i suoi desideri da quattro soldi.
Quello che incatena di questo romanzo sono il ritmo e il susseguirsi rapido delle immagini, l’incalzare delle frasi, l’uso dei tempi verbali, l’apparente saltare in avanti e poi tornare indietro, ma in fondo siamo stati sempre lì, trattenuti sulla pagina. La qualità della scrittura di Waldrop è di altissimo livello e pare non somigliare a nulla, assomiglia soltanto, per rimando e forza, alla poesia molto alta, che è capace di farti vedere il bene e il male insieme, dimostrando che tutto è collegato, ogni gesto d’amore, ogni atto crudele, ogni lacrima versata, ogni risata, ogni pagina attraversata.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/