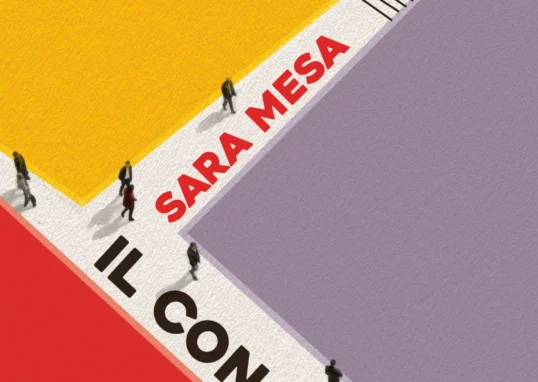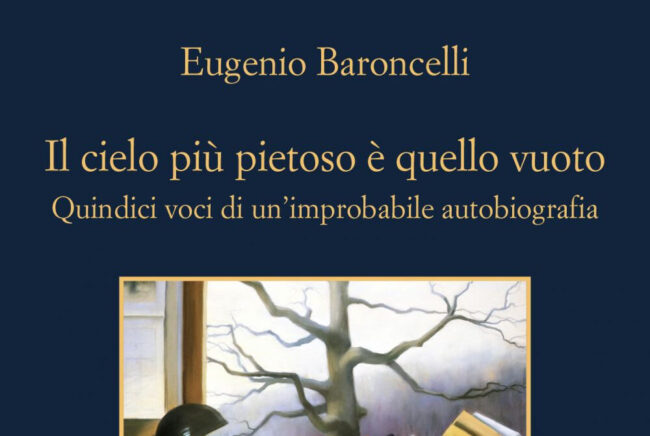
“È più bello scrivere a piccoli scatti,
su cento soggetti che sorgono all’improvviso,
sbriciolando per così dire il proprio pensiero.”
(Jules Renard, Per non scrivere un romanzo. Diario 1887-1910, Serra e Riva Editori 1980)
“Senza contare gli aborti, ho scritto fino ad oggi circa novecento Vite,
nessuna delle quali capace di passare con qualche verosimiglianza per la mia.
Il sentimento da cui è nato questo libro oscilla dunque fra il sollievo e la rassegnazione”
(Eugenio Baroncelli, Il cielo più pietoso è quello vuoto, Sellerio, 2025)
A leggere le prime pagine del nuovo libro di Eugenio Baroncelli, Il cielo più pietoso è quello vuoto. Quindici voci di un’improbabile autobiografia (Sellerio, 2025), sembrerebbe che lo scrittore, solitamente dedito alle vite degli altri, questa volta abbia deciso di raccontarci la sua vita per davvero. Così alla voce Infanzia, seconda in ordine di apparizione, con una prosa elegante e inaspettatamente lirica, rievoca l’insondabile penombra della casa di famiglia in cui Baroncelli bambino si muove tra epifanie e presagi:
Ho avuto un’infanzia di prodigi: sul fare delle notti, la casa diventava intransitabile – la grande casa a due piani, di stanze in ecclesiastica penombra, di balconi nella luce invecchiata della luna, di irrisolte sciarade sul patibolo delle finestre, di porte aperte dal vento di disgrazia perché potesse entrare la Morte quando ho fretta, che i nonni, persone di grande immaginazione e di devota superstizione, abitavano da sempre. C’erano dappertutto uomini morti di pallottole scadute e di veleni usati e donne dai volti rovinati dalle veglie. Si stava lì, tra lo stupore delle rondini. Si stava a così poca distanza dalla fatalità che certe volte io, con le mie mani inconsapevoli, quasi la toccavo. In tutto quel silenzio di guerra finita, in tutta quella penombra di giorno disilluso, la nonna contava sulle dita le rondini dal letto e le madri parlavano a bassa voce, nel linguaggio cifrato dei loro morti.
Questo passo magnifico mi ha riportata all’intensità espressiva e simbolica della Lingua salvata di Elias Canetti, o ancora a Leggenda privata di Michele Mari. Come nei precedenti libri la densità della prosa di Baroncelli è accentuata dalla spaziatura che frantuma la narrazione autobiografica in tanti piccoli testi: quasi la forma frammento fosse l’unica capace di salvaguardare la potenza dei ricordi destinati a mescolarsi con quelli degli altri, e il più delle volte a svanire. La scrittura interviene ripescandoli da quello strano contenitore che è la memoria, e illudendoci che il nostro piccolo e impotente “io” sia il narratore ideale delle nostre autobiografie:
Non mi ricordo quando sono nato. Di notte, dicono. Di lato, come il fuoco di una scaramuccia nella grande guerra. […]
Sono figlio dei ricordi di mia madre. All’alba del giorno in cui sei nato, raccontava, il cielo si annerì sopra di noi. […]
Sono figlio di cadaveri e rovine che non ho mai visto. In evidente ritardo sono nato, cieco e vecchio. Il cielo più pietoso è quello vuoto. Se adesso a questo libro impongo questo titolo, una ragione c’è.
[…] Sono nato sotto il segno del Cane. Sono nato nel cuore di un secolo così feroce che avrebbe meritato il titolo di cane lupo. Sono nato su una spiaggia di Viserba nel 1951. Venuto dal nulla, orfano di guinzaglio e di padrone, un cagnolino mi azzannò da dietro, a tradimento. (Più tardi l’uomo che mi aveva soccorso parve scontento della mia versione del fatto: segno evidente che già allora non ero il narratore ideale di questa storia.
L’infanzia (e in generale la vita passata) si dà in un continuo ricominciamento (riposizionamento?) di perecchiana memoria: “Sono nato”. Ma chi è nato? E quando? Nel 1951 come nel passo citato oppure nel 1944 come scritto nella bio? Baroncelli, è sempre e fortunatamente lui, e così si diverte a depistare i lettori, a fare lo sgambetto, ma sono molti i pensieri, propri e altrui, disseminati nel testo che ci mettono in guardia. Anche questa volta lo scrittore non ci racconterà esattamente la propria vita: del resto ci ha avvisato fin dal titolo che si tratta di un’autobiografia improbabile.
“Io sono nata. / Io sono. Io” sono i versi di Margareth Atwood riportati in epigrafe insieme a quelli di Montale e Cicerone; e lo stesso Baroncelli compare non virgolettato nell’esergo: “Scrivere è fingersi un altro. Scrivere un’autobiografia è esserlo”.
Nel genere che maggiormente celebra l’io, Baroncelli gioca con l’onomastica invertendo nome e cognome – “Quanto ai cognomi, il mio è Eugenio” – e sdoppiandosi, come l’artista Alighiero Boetti, in due entità separate: “È all’altro, a Baroncelli, che capitano le cose. Io vorrei stare nell’ombra e lui accende la luce. Io non so fare niente, e lui decanta la mia inettitudine. “Capriole onomastiche”, come le ha definite lui stesso, che confermano l’inattendibilità dell’io (autore e narratore) e dei fatti raccontati. D’altra parte è forse attendibile la memoria?
Se nel precedente Libro di furti Baroncelli ripercorre 301 vite rubate alla propria, qui ruba le vite degli altri per scrivere la propria (o per sbarazzarsene definitivamente come aveva già dichiarato ne Gli incantevoli scarti?); misura il proprio tempo con quello degli altri come quando, raccontando le passeggiate di Carl Seelig con Robert Walser, annota: “28 dicembre del 1944. Io sono al mondo da circa sette mesi. Il cielo è limpido. Il freddo è tagliente come la lama di spada. Nella clinica i due viandanti discutono sull’itinerario della passeggiata.” (Allora è davvero 1944 la data di nascita!).
O quando osserva di essere un coetaneo di W. G. Sebald fino al 2001, l’anno in cui il grande scrittore morì mentre finiva il suo ultimo libro; o ancora nel momento in cui di fronte alla fotografia di un Mallarmé seduto vede sé stesso: “C’è una fotografia che ritrae Mallarmé assiso su questa sedia. Un tempo la credevo impensabile senza di lui; oggi la credo impossibile senza di me dopo che ho fatto quattro strenui passi nel deserto del salotto.” E nel riportare Borges che racconta la morte di Dante a Ravenna, non si prefigura la propria, lui che nella città bizantina ci vive da moltissimo tempo? “Anni dopo, Dante moriva a Ravenna, non giustificato e solo come ogni altro uomo”.
All’invecchiare e al morire, peraltro, sono dedicati frammenti, anzi veri e propri aforismi, insieme arguti e toccanti:
Beati voi, padre e madre, che non avete occhi per vedere i miei svanire.
Un vecchio si affanna a guadagnare tempo da perdere. Un buffo tipo di risparmiatore.
Invecchio, certo, ma il merito e la colpa non è del tempo che passa.
Invecchio a causa dei morti che nella memoria continuano a morire.
Ho i giorni contati ma certo non da me.
Sia che parli di scuola (Baroncelli è stato anche un professore di liceo) oppure di donne, di macchine, di sogni (per citare alcune delle quindici voci dell’improbabile autobiografia) l’ironia è la cifra stilistica che più lo contraddistingue. Ironia, forza salvifica, perché ci strappa un sorriso quando “per vivere bene”, come ha scritto Luigi Meneghello, bisogna “assaggiare ogni giorno cucchiaini di morte”; e perché ci ricorda, come ha osservato lo stesso Baroncelli commentando Borges su Dante, che se la poesia non muore mai, i poeti muoiono sempre.
La riflessione sul mestiere di scrivere e sulla figura dello scrittore attraversa tutto il libro offrendoci importanti spunti su cui meditare e nel contempo ci svela la costellazione letteraria dell’autore a partire dall’amato Jules Renard con il suo inarrivabile “stile verticale” (ma Baroncelli riesce in molte occasioni a tenergli testa) a tutti gli scrittori e le scrittrici presenti anche quando non citati: i padri, e aggiungo io le madri, “contagiosi” che gli sono toccati in sorte. Tra questi per esempio Marcel Proust, perfetto per nutrire un’autobiografia, ma non solo: “C’è un libro, raramente o forse mai citato, dietro questo: la Recherche di Proust, quella storia del deperibile corpo di Marcel. Ci sono gesti e riti, non parole, che dal suo sonno risvegliano il passato.”
Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.