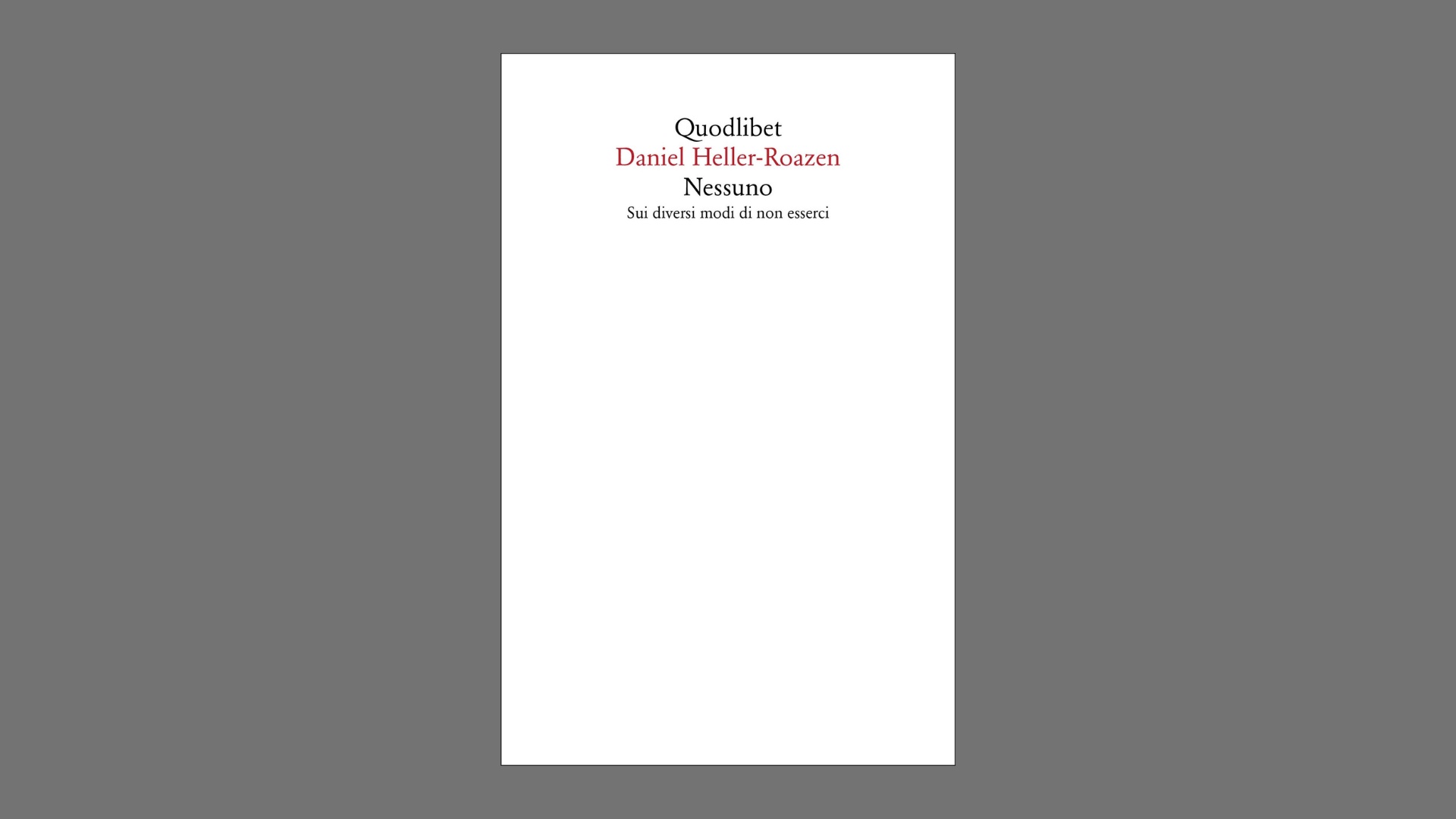
Il nuovo libro di Daniel Heller-Roazen si basa sull’idea che ogni qualcuno possa diventare nessuno attraverso una diminuzione di qualche sorta: nei diritti, nella capacità, nella presenza. Il modo più comune è forse quest’ultimo: non essere più presente. Se oggi è difficile che una sparizione resti a lungo un mistero, e quando capita il caso crea scalpore, nell’antichità accadeva di continuo. Erano soprattutto gli uomini a sparire: si allontanavano dalle loro case per combattere, per commerciare, per viaggiare, per pescare, partivano per mesi o per qualche ora e a volte non facevano ritorno; e il prolungarsi della loro assenza alimentava l’incertezza, e la necessità di prendere prima o poi alcune decisioni: il patrimonio dello scomparso doveva essere amministrato in attesa del suo ritorno o poteva essere ereditato? Per quanto tempo la moglie avrebbe dovuto aspettarlo prima di potersi sposare di nuovo?
I legislatori di ogni civiltà hanno dovuto confrontarsi con problemi simili. La legge, solitamente, distingueva due fasi: nella prima si presumeva che lo scomparso fosse in vita, finché non ne venisse provata la morte; passato un certo numero di anni, spesso sette, la presunzione e quindi anche l’onere della prova si invertivano. La scomparsa di una persona mette dunque la legge nella particolare posizione, non avendo fatti certi su cui fare affidamento, di dover trasformare un’ipotesi in realtà, almeno sul piano giuridico. Di inventare dunque, come si fa in letteratura; e non a caso la scomparsa è sempre stata un formidabile motore narrativo, tanto romanzesco quanto cinematografico. Affascina poco, di certo, la conferma della supposizione del legislatore, con l’effettivo protrarsi dell’assenza dello scomparso; ma stupisce sempre l’avverarsi dell’insperato e dell’improbabile, ed ecco allora che il tema del ritorno diventa, per Omero così come per Pirandello, Balzac o Zola, un’inesauribile fonte a cui attingere per raccontare storie sempre nuove.
Parlare di scomparse significa allora richiamare discipline molto lontane tra loro. Nel suo precedente lavoro pubblicato in Italia, Il tatto interno, Daniel Heller-Roazen ragionava su una domanda fondamentale: attraverso quale senso sentiamo di essere vivi? Per trovare delle risposte ripercorreva, alla luce di quel tema, buona parte della storia della filosofia, da Aristotele e Merleau-Ponty. Questo nuovo saggio, Nessuno, che tratta invece i differenti modi di essere nessuno, gli consente di allargare a dismisura le fonti e i campi del sapere a cui attingere; accanto a quella della filosofia, qui c’è spazio per la storia del diritto, e soprattutto della letteratura, da sempre ricchissima di personaggi che finiscono col non esserci, in un modo o nell’altro. Già, perché scomparire è solo una delle tante maniere per diventare nessuno.
Dopo la scomparsa delle persone fisiche, ma giuridicamente ancora tutelate in attesa del loro ritorno, viene preso in esame il caso opposto: vale a dire quando qualcuno è senza dubbio vivo, ma diviene nessuno in quanto diminuito nei propri diritti. La figura dell’esiliato è sicuramente la prima a venire in mente, ma la letteratura offre innumerevoli variazioni sul tema, sia in merito alle cause che agli effetti dell’indegnità e dell’ignominia: si va dal Gulliver emarginato dagli Houyhnhnm perché troppo somigliante agli Yahoo, al Peter Schlemihl titolare di quella “storia straordinaria” in cui scambia la propria ombra con un’infinità di monete d’oro, per scoprire poi che nessuno vuole più intrattenere rapporti con lui; la sua è una vera e propria “morte civile”, locuzione dai tanti casi d’uso, adoperata per descrivere tanto la scelta di vita di chi prende i voti ed entra in un monastero, quanto la sorte di un oppositore politico quando un regime oppressivo sale al potere.
L’espressione è quasi per un presagio per il terzo e ultimo caso di diminuzione proposto nel saggio, che è proprio la morte. Un cadavere è ancora una persona o è già una cosa, una volta appartenuta a qualcuno che non c’è più? Un corpo senza vita è pura somiglianza (“Un cadavere è la sua propria immagine”, scriveva Blanchot) e rappresenta allora il massimo grado dell’essere nessuno? Il terreno per proseguire una trattazione rigorosa sembra a questo punto essere venuto meno da un pezzo, e invece il saggio si avvia verso la conclusione con una brillante trattazione di spettri e fantasmi – e anime morte, naturalmente – che infestano la letteratura.
Sulle pagine della London Review of Books a Daniel Heller-Roazen è stato rimproverato di aver trascurato la psicologia; su queste invece gli verrà dato il merito di non essersi occupato d’attualità, com’è sempre meglio fare quando si trattano temi universali. Chi vorrà dedicare un po’ del proprio tempo a questo libro, pubblicato da Quodlibet nella traduzione di Giuseppe Lucchesini, saprà senz’altro tracciare da sé i fili che legano i suoi temi al presente. Sono tempi, questi, non facili per chi abbia il desiderio di diventare nessuno: il modello di rete sempre più centralizzata e controllata verso cui si sta muovendo internet complica la vita a chiunque abbia necessità o voglia di oblio, anonimato o semplicemente disconnessione; e sono del resto tempi ancora peggiori per chi invece, diminuito nella libertà, nella dignità o nei diritti fondamentali, si trovi a essere nessuno suo malgrado.
Gilles Nicoli è nato a Roma sette giorni prima che Julio Cortázar morisse a Parigi. Scrive soprattutto di libri, cinema e videogiochi.






