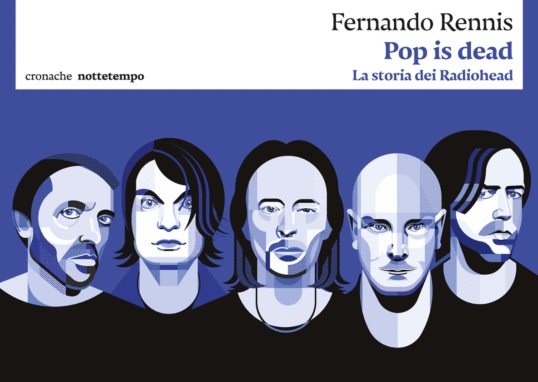Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash
di Sacha Piersanti
Sarà la suggestione del suo titolo, la sapiente eppure istintiva costruzione ritmico-melodica dei suoi versi, sarà la mossa compattezza delle sue strofe, o l’odore buono o di rifresco che s’alza senza gerarchie dalle sue immagini, ma Il libro dei Liquidi – The Book of Liquids di Irene Santori (Aragno, pp. 209, 15 €, opera che inaugura la collana bilingue “Parallela”) sembra davvero fatto d’acqua, scritto com’è lasciando che colino o fluiscano ricordi e narrazioni, sensazioni e situazioni cui la voce del poeta tenta di dar forma. Compito ingrato, per certi versi più affine alla condanna che alla scelta, e al tempo stesso miracolo tutto umano della parola, questo di dover dar forma all’informe, di dar ordine al disastro, che Santori affida a un io insieme lirico e narrante la cui consistenza non è meno liquida della materia da gestire eppure deve essere, deve convincersi di essere solido filtro e diga: «…Ma io. / Questo sì, / questo nato di parto, in tutto il celestino, imbracciato / io / c’ero. Non questo e quello vedo, ma questo / e non lo invento // lo giuro…» (Ma io, p. 47).
Articolato in quattro macro-sezioni che – ci avverte la Premessa – seguono fedelmente nel titolo e nei disegni alcune pagine di un “Libro dei Liquidi” realizzato dall’allora cinquenne figlio dell’autrice, Il Libro dei Liquidi si presenta come indagine, scavo, scoperta di una memoria individuale, di una storia personale, singola, che sembra, però, trascendere se stessa, se ogni elemento o dato privato s’accorge sin da subito di essere parte di un tutto, sineddoche di una Storia sempre più grande e sempre altrui: corso e ricorso di un io che è oltre e ulteriore rispetto a se stesso, cosciente di essere né più né meno di un anello di quell’unica catena che è l’umanità: «come per gli alberi / se mi tagli comprendi / la mia era / quanti giri ho fatto // via dal ramo dissimile, senza sinonimi, materno» (perfetta vita dell’anello, p. 51).
Coscienza tipica della poesia di Santori, questa, che sostanziava già i suoi precedenti lavori, specie Hôtel Dieu (Empiria, 2015), e che qui trova più fertile pienezza andando a costruire un percorso organico e puntuale che sancisce come ogni andata non sia che un ritorno, ogni è un già stato. Dal ricordo di «trent’anni fa» posto quasi in apertura (il racconto di un’esperienza di caccia che nella sua vividezza si tinge dei colori dell’archetipo sacrificale) al viaggio in Israele cui è dedicata la suite di chiusura, Il Libro dei Liquidi si muove tra Storia e cronaca, aneddoto e mito, appunto e diario, lungo una traiettoria che è al tempo stesso lineare e, più che circolare, concentrica, sviluppando al proprio interno sezioni e sotto-sezioni che pur nella loro evidente compattezza sono in continuo dialogo, in continua rifrangenza col resto e tra di loro, col risultato di consegnare al lettore un’opera piena di riferimenti concreti, di nomi, di luoghi, di racconti specifici che sono, in fondo, le diverse modulazioni di una stessa materia originaria.
Merito, questo, del procedimento creativo di Santori, che, non accontentandosi di imbastire allegorie o didascaliche metafore, lascia che gli elementi narrativi e emotivi liberino da sé il proprio principio figurale, si mostrino nudi nella propria irriducibile forza evocativa, arrivando prima di tutto all’orecchio del lettore come naturalmente portatori di un significato primordiale: «una pecora contromano / da lontano fissa il suo cranio / accanto a quello / di un somaro issato per il naso / nel pronao blu reale / del macellaio sano di mente / di schiena col pugnale e non so quale / taglio di un cammello / scoppiato come / il copertone / del blindato. // Sgocciolano come se piovesse ma non spiove / – fa’ spazio dentro al secchio al mio polmone – // e questa è Nablus / e questo è niente» (Uccidi e mangia, p. 151).
È così, allora, che in questo Libro dei Liquidi ogni lutto sembra rievocare la scoperta umana della morte, ogni parto o incontro la scoperta umana della nascita, ogni contatto o amplesso lo splendore e insieme il trauma della scoperta umana del corpo proprio e altrui, un colpo di fucile la sassata contro Abele o i chiodi dentro Cristo, i disegni di un bambino i graffiti di Lascaux – elemento, quest’ultimo, non a caso in filigrana ricorrente in una prosa che cola e ricola fino a sfarsi e perdersi tra le pagine del libro e che autorizza a riconoscere tra i fratelli in versi di Santori i mai troppo celebrati Pierre Jean Jouve e René Char, oltre al «minatore» dell’io per eccellenza, il nostro Caproni.
Ma si diceva “prima di tutto all’orecchio”, e in fondo sta forse qui lo specifico più proprio del dettato di Santori, che, tra pause dilatate e fitti colpi ritmici, docili rime interne e violente spezzature, sa modulare e rimodulare tanto il suono quanto il silenzio che si porta dentro ogni singola parola, soppesandone spessore e impatto acustico come fosse, sempre, la prima volta che si ritrova a pronunciarla. Di nuovo, è la liquidità dei significanti, l’opacità o la trasparenza del fluire dei fonemi a farsi sostanza, ad attraversare l’io che di loro s’impregna e loro riproduce, dando l’impressione di una trance dai toni oracolari, significativamente spesso affini all’ecolalia o al petèl, quasi quell’io fosse il luogo preposto a far risuonare o risillabare voci altrui: «il santuario mano mano / gemma l’emicranio / mentre all’ombra del diadema / divisorio / sibila l’altalena altalenante / ma / deserta / sibilano le camere di Qumran ma / di coccio / e a me mi calma / un mare senza porto / Ma / Morto» (Insolazione, p. 167).
Tramite una personalissima tecnica di dripping fonetico-verbale, fedele a quei liquidi di cui dice e di cui è fatto questo libro, dal sangue al mare al brodo, dal seme al latte al pianto, e a una medianica lucidità che non è mai posa ma unica, urgente modalità di stare al mondo, così, Santori sembra farsi abitare, materna e ctonia, dalle figure più diverse, tenendo per sé la precaria solidità di una frattura, di una crepa: di un taglio. Non è un caso che ad accompagnare la semantica del liquido siano coinvolti qui termini-chiave più o meno evidentemente legati non solo all’elemento maternale ma puntualmente alla fisicità del femminile: al di là della topica affinità acqua-parto o terra-madre, e di tutte le possibili letture psicoanalitiche in questo senso, cui pure accenna l’ottima Postfazione firmata da Martin Rueff, Il Libro dei Liquidi senza proclami né bandiere si fa portavoce della condizione culturalmente fratturata della donna (s’ascolti il Monologhetto di Jean des Anges, uno dei momenti più alti del libro, pp. 73-75, o s’incontri Maria Assenza, nella penultima sezione) ed emblema di quella ontologicamente lacerata degli umani tutti. Che il libro si chiuda con l’uncino interrogativo di una domanda, con la paziente speranza d’un «cauterio», di nuovo no, non è un caso, ma l’epilogo obbligato di una ricerca poetica che alla comoda simulazione di una sutura sa preferire l’abissale verità della ferita.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente