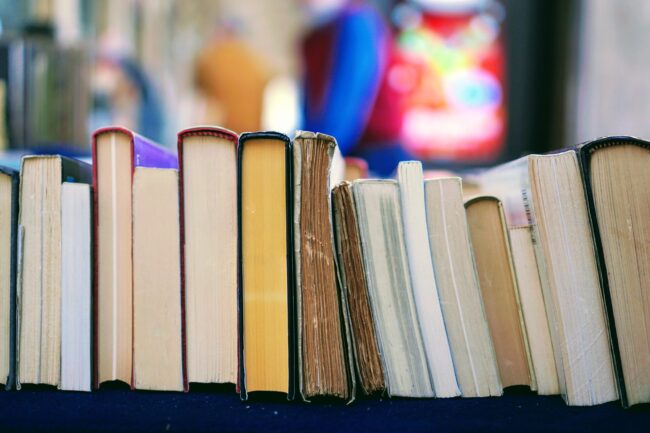
Photo by Tom Hermans on Unsplash
di Andrea Donaera
Nonostante le mai sopite trenodie attorno a una presunta “morte del romanzo”, la percezione – dal punto di vista di chi, semplicemente, legge libri, senza la bava alla bocca di chi guarda i primi posti nelle classifiche di vendita – è che in questo momento, in Italia, si stia verificando un virtuoso rimaneggiamento di alcuni paradigmi letterari che fino a pochi anni fa sembravano inossidabili. In particolare è la questione dei generi a essere sottoposta, pare, a un ridimensionamento che in alcuni casi suscita uno stimolo a succose riflessioni. Per farla semplice, in qualche modo viviamo un periodo in cui sempre più spesso viene da chiedersi: ma ’sti generi letterari esistono ancora – per come li abbiamo finora conosciuti?
Esempi piuttosto eclatanti in tal senso possono essere rintracciati in alcune pubblicazioni operate da grandi editori negli ultimi mesi. Su tutte l’eccellente romanzo di Gilda Policastro La parte di Malvasia (La Nave di Teseo, 2021): un’operazione letteraria che gioca sulla configurazione esteriore per irretire (positivamente) il lettore. Nel paratesto, il libro appare come un noir, con tanto di fascetta a firma di Maurizio De Giovanni e sintesi della trama dove tutto sembra ruotare attorno a un’indagine e un omicidio. Certo, è facile percepire (anche solo leggendo la nota biografica dell’autrice, dove esperienze di critica letteraria si incrociano con pubblicazioni di poesia) che non si tratterà di un giallo da spiaggia, ma di un lavoro connotato da una robusta postura letteraria: quello che non è facile percepire, fino a quando non si comincia a leggere effettivamente l’opera, è il tranello che Policastro tende a chi entrerà nel testo.
La parte di Malvasia è un romanzo fondato su un’esperienza linguistica peculiare, dove il ritmo della narrazione è soggiogato all’accumulo di immagini, parole, percorsi psichici, accadimenti, tutto tenuto insieme dal filo (al contempo labile e granitico) dell’indagine poliziesca e dalla fantasmatica figura della vittima. Insomma: è come se si fossero incrociate le intenzioni letterarie teorizzate da Edoardo Sanguineti o Amelia Rosselli, ficcandosi in modo parodico in un contesto alieno, cioè quello della letteratura di genere – addirittura il genere più amato in Italia, seguendo una genealogia che ha toccato il suo apice alcuni anni fa con Valerio Magrelli.
Il risultato è un vortice letterario straniante ma avvolgente, dove chi legge si trova costretto a proseguire, spinto dalla posa ipnotica di ogni pagina, ma anche, contemporaneamente, dal desiderio di capire dove effettivamente andrà a parare questo giallo-non-giallo. L’autrice, sui social, ha dichiarato in modo velatamente scherzoso di non apprezzare la scelta dei librai di collocare il suo libro negli scaffali dedicati a noir, gialli, thriller. E invece è proprio tutta qui la potenza dell’operazione editoriale dietro a quest’opera: un romanzo fuori da ogni genere, dotato di una temperatura letteraria altissima come poche altre negli ultimi tempi, ma che al contempo riesce a esistere nelle librerie in modo vistoso, senza essere relegato nei comparti ‘per lettori forti’ (espressione orrida), ma posizionato in bella mostra insieme a bestseller e ad altri lavori di enorme successo commerciale.
È in questo gustosissimo tranello che si configura il ribaltamento dei generi cui si faceva cenno sopra: richiamare lettrici e lettori verso qualcosa di famigliare, per poi avvolgerlə in qualcosa di inaspettato – rendendo, così, il genere letterario soltanto un espediente, un canto di sirena, e non più un contesto di scrittura stringente.
L’esperienza di Policastro sembra essere possibile specialmente grazie all’appartenenza dell’autrice al campo della poesia. I suoi importanti studi sulle scritture in versi del secondo Novecento e le sue pubblicazioni come poetessa confermano che esiste in alcuni casi una sorta di arché letterario, un dispositivo in grado di generare delle scritture ulteriori: proprio grazie alla frequentazione della letteratura ulteriore per eccellenza, cioè la poesia. Non è forse un caso se, in tempi recenti, opere narrative di grandissimo spessore siano, in modi più o meno espliciti, adiacenti quantomeno al concetto di ‘poesia’.
Si pensi ad alcune raccolte di prose, presenti in libreria nella sezione narrativa, ma frutto di processi letterari connessi più che altro alle possibilità offerte in dote dalla poesia: il libro molto amato dal pubblico Con passi giapponesi di Patrizia Cavalli (Einaudi, 2019; nella cinquina del Premio Campiello 2020) o il contenitore di capolavori minimi Geografie di Antonella Anedda (Garzanti, 2021). Opere a firma di due tra le più importanti poetesse italiane contemporanee, che non sono romanzi, che non sono racconti, che non sono poesie: ma che entrano, con marchio major, negli scaffali di ogni libreria accanto alle letterature più midcult e mainstream.
Inoltre, ormai nota ai più, l’esperienza di un’apprezzatissima poetessa, Maria Grazia Calandrone, che con il suo Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 2021) è candidata allo Strega, avendo realizzato una vera e propria opera poetica che, quasi miracolosamente, assume allo stesso tempo anche la forma del romanzo.
Opere che osano ancora di più, verso questa direzione, si rintracciano nell’editoria indipendente – che sembra sempre più lontana dal rincorrere i gusti stereotipati del grande pubblico, favorendo la costituzione di un immaginario editoriale proprio, con la speranza di creare nuovi gusti, senza assecondare quelli già codificati. È il caso dello stranissimo esordio Io e Bafometto di Gregorio H. Meier (Wojtek, 2021), dove racconti, poesie, filastrocche, incantesimi e prose vanno a comporre un’opera letteraria che rifiuta ogni senso, per esplodere però di significato come poche altre volte nei libri italiani recenti. Ed è impossibile non notare il caso (corroborato anche da un certo successo commerciale) di Urla sempre, primavera, di Michele Vaccari (NNE, 2021): un libro-mondo dove accade di tutto sia nella trama che nella forma, definito giustamente da Vanni Santoni «l’unico esempio italiano di slipstream», cioè un’opera che sfonda ogni genere letterario, arrivando a contenerli tutti – dalla fantascienza alla poesia, dal romanzo d’avventura al reportage storico-narrativo.
Infine sono necessariamente da segnalare alcune eclatanti incursioni da parte di importanti poeti nelle scritture narrative brevi più canoniche, cioè i racconti: Le stelle vicine di Massimo Gezzi (Bollati Boringhieri, 2021) è un libro straordinario (non a caso a un passo dalla cinquina dell’ultimo Campiello), in cui lo sguardo del poeta esonda nella prosa allestendo un mondo di accadimenti minimi che deflagrano in una dimensione emotiva capace di creare un coinvolgimento trascinante fino ai bordi della commozione; la stessa capacità specifica dell’occhio poetico si incontra nell’abbacinante Sonno giapponese (Italic Pequod, 2018) di Gabriele Galloni, dove la narrazione viene affidata a una metaforica e non esplicitata videocamera a circuito chiuso, sbirciando nell’orrore di vite comuni che, nel backstage delle loro esistenze, assumono connotati orrorifici e disturbanti.
Verrebbe da pensare, dunque, che le persone che si immettono nella scrittura narrativa provenendo da un apprendistato fatto di studio della poesia (ed esercizio attorno a essa) siano attualmente quelle maggiormente in grado di intervenire all’interno di un campo culturale che sembra fermo da troppi anni: la settorializzazione dei generi letterari, inquadrata in campi tematici e schemi stilistici, sembra essere sotto assedio, arrivando in modo roboante in libreria, invadendo ambiti, sporcando e pasticciando la nitidezza rassicurante del giallo, dell’horror, della sci-fi o addirittura del cosiddetto ‘romanzo tradizionale’.
Questo processo è uno dei tanti che danno la sensazione di vivere in tempi sul serio interessanti – checché ne dicano figure nostalgiche del Novecento o personalità critiche con poca voglia di analizzare la letteratura circostante (in Italia, nella critica letteraria degli ultimi anni, vale sempre di più la regola secondo la quale quando non si sa di cosa parlare meglio ripiegare verso un qualsiasi borbottio lamentoso privo di argomentazioni). Tempi interessanti perché qualcosa sta accadendo, in un ambito frastagliato ma spesso percepito come pachidermico (lento, grigio) come quello dell’editoria. E tali piccole mutazioni sembrano poter provenire, prevalentemente, da chi si immerge del tutto nella grande forma liquida della letteratura, dove poesia, prosa, generi e non-generi coesistono, con il fine ultimo di creare – banalmente, ma faticosamente – libri belli da leggere.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente



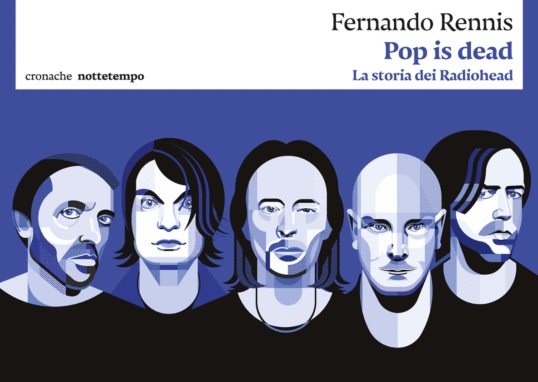



Preferisco rifugiarmi nei classici. Tutti scrittori? No. Di scrittori autentici, in un secolo, ne nascon pochi.
Dove mettere Nicola lagioia. Con il suo ferocia che va bene come romanzo tradizionale che come noir. O Antonella Lattanzi col suo il giorno che incombe !??
Giocare con i generi può essere segno di grande abilità narrativa oppure, come suggerisce Sergio, indizio di poca cosa letteraria
Sì, ma quel che dice Sergio non conta, MAI. Scrittore frustrato capace solo di sparare banalità nei commenti e per il resto inesistente. Probabilmente un fake.
Comunque, se Donaera ha ragione e io penso abbia molta ragione, quel che ci vuole è un equivalente letterario dei Maneskin.
Una disamina molto interessante e aperta. Ho gradito molto ” il checché ne dicano figure nostalgiche del Novecento o personalità critiche con poca voglia di analizzare la letteratura circostante (in Italia, nella critica letteraria degli ultimi anni, vale sempre di più la regola secondo la quale quando non si sa di cosa parlare meglio ripiegare verso un qualsiasi borbottio lamentoso privo di argomentazioni). ” Le cose vanno dette anche più volte: bravo Andrea.