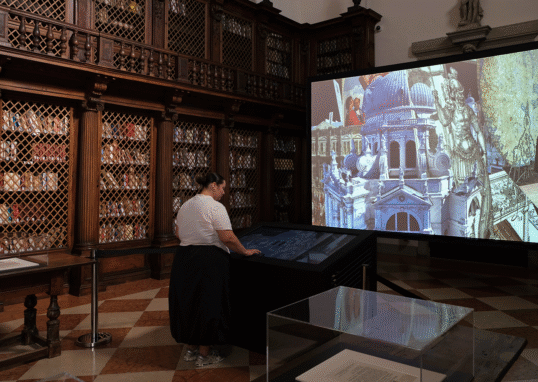Questo testo è stato originariamente pubblicato sul sito del settimanale Carta vent’anni fa, per raccontare in modo un po’ impressionista la prima notte bianca romana – che si è svolta nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2003 – e il suo “naufragio” nel grande black-out che fece piombare al buio l’intero Paese (fonte immagine).
Ci eravamo preparati per uscire con meticolosa lentezza. Sospettavamo che ci sarebbe stato un fiume di gente da attraversare, perciò era meglio prendersela calma. A mezzanotte eravamo a Campo de’ Fiori, ma quello in cui ci imbattemmo era ben al di sopra dei nostri incubi peggiori. Solo per attraversare la piazza ci volle un’ora. Più di una volta mi ero perso di vista con la gente con cui ero venuto, mentre mi imbattevo in un’infinità di altre persone che non vedevo da tempo. I cellulari davano segni di cedimento. Questa storia della notte bianca l’avevano pubblicizzata proprio bene, non c’è che dire, in giro c’era gente di tutte le età che voleva entrare in tutti i posti possibili, e naturalmente nessuno aveva rinunciato ad avvicinarsi con l’auto, e tutti, ma proprio tutti, erano incollati al telefonino in cerca di qualcuno che si era perso o si doveva incontrare.
Cercammo invano di metterci in fila per entrare a Palazzo Farnese. Dopo aver rinunciato constatai con frustrazione che anche per andare al bagno o per ordinare una birra le attese non erano da meno. I bar del centro erano miracolosamente assurti al grado di night club, e si erano messi a vendere alcolici a prezzi esorbitanti. Ma a nessuno importava troppo. A parte il clima, sembrava di essere alla semana grande di Bilbao o qualcosa di simile, e tanto bastava ad accendere gli animi. Il brusio ininterrotto della gente ci accompagnava ovunque, assieme a un profumo d’erba che la gente fumava in tranquillità. Per una sera si era arrivati una legalizzazione di fatto? Forse sì, forse no, ciò che era certo è che la legge sulla tolleranza zero, spacciata minacciosamente dalle tv solo poche ore prima, sembrava piacevolmente lontana.
E un’altra cosa certa era la gente. Gente ovunque, che camminava in tutte le direzioni, affascinata forse più dalla calca e dalle luci della città che dai monumenti da visitare, vanitosamente orgogliosa di questa notte in bianco gemellata con quella parigina. Per strada qualcuno che, dal tono di voce, sembrava aver votato tutt’altro che a sinistra, commentava che però Veltroni su queste cose ci sapeva fare. E che di sicuro adesso si stava sfregando le mani per la contentezza. Spettacoli, esposizioni, letture e concerti erano un po’ ovunque, tutto era a disposizione di tutti, ma quasi tutto era inavvicinabile per via della gran folla. Sentivo qualcuno mugugnare per l’organizzazione. “Ma perché non hanno chiuso l’anello ferroviario?” si chiedeva una coppia di vecchietti. Anch’io cominciavo a stufarmi di tutta quella calca, ma che cavolo: una volta che sei in ballo…
Si era formato nel frattempo un gruppo eterogeneo, fatto di amici di amici, e ci spostavamo a fatica perché era un’impresa ardua mettersi d’accordo e non perdersi nessuno. L’idea di andarcene alle Belle Arti fu di una ragazza e tutti l’accettarono di buon grado, perché si sperava di trovare meno calca e un po’ più di spazio pro capite. E in effetti così fu. Passeggiavamo per i corridoi del palazzo di Via di Ripetta imbattendoci in gente e opere improbabili, finché non cominciò a piovere. Un tempismo perfetto per una notte così. La gente cominciò a riversarsi dentro, sedendosi un po’ ovunque nell’attesa che spiovesse, ma era chiaro che non sarebbe successo tanto presto.
Poco dopo arrivò la ciliegina sulla torta: era saltata la luce. Sulle prime pensammo che fosse un modo per far capire che stavano per chiudere, ma erano appena le tre o giù di lì. Poi qualcuno si affacciò per annunciare che si trattava di un black-out. Dai cellulari che squillavano in continuazione apprendemmo che non era un fatto isolato, ma riguardava tutta la città. E fuori pioveva sempre più forte. L’odore della pioggia e del sudore cominciò a invadere l’androne del palazzo. Io ero sulla soglia e da lì guardavo svogliatamente un po’ dentro e un po’ fuori. In molti avevano rinunciato a trovare un modo per andarsene e si erano messi chi a fumare, chi a bere, chi a fraternizzare con perfetti sconosciuti. Qualche temerario, ogni tanto, tentava la sorte gettandosi a correre a capofitto nella pioggia, e sguazzava nelle pozzanghere finché il nero della notte non se lo inghiottiva.
Dopo un po’ lo facemmo anche noi. Mica potevamo restare lì fino all’alba. Corremmo come matti verso Piazza Augusto Imperatore, ma la pioggia era davvero troppa e alla fine ci rifugiammo sotto i portici. C’era molta gente lì sotto, che chiacchierava divertita della situazione. La pioggia, il black-out… Qualcuno malignava suggerendo che adesso Veltroni le mani se le stava mangiando, e qualcuno già si figurava i titoli dei giornali: “La notte bianca diventa la notte nera”. Proseguimmo per i vicoli del centro, dove il buio era davvero impressionante. Non si vedeva praticamente nulla, incrociavamo delle voci, ora lontane ora vicinissime, ed intuivamo a malamena i movimenti di chi ci veniva incontro, perché l’unica cosa che si riusciva a vedere erano cupi triangoli di cielo gravido di pioggia, su in alto, tra un tetto e l’altro. Più di una persona, un una sorta di contagio da luogo comune, si domandò ad alta voce se le notti romane, nel medioevo, fossero proprio così.
Ovviamente no, non potevano esserlo, e non solo per le differenze architettoniche, ma perché le vetrine dei negozi erano accese, e anzi nel buio totale sembravano esserlo ancora di più, e calamitavano lo sguardo mano a mano che ci avvicinavamo a Piazza del Parlamento. Non si vedeva quasi a un palmo dal naso, ma le luci dei generatori illuminavano i vestiti appesi e i manichini senza testa, che come fantasmi silenziosi ci accompagnavano lungo il tragitto. Sembrava quasi che ci scrutassero incuriositi da dentro le loro teche. La suggestione durò soltanto un attimo, perché la pioggia cominciò a cadere di brutto, e quindi via, di volata fino al Pantheon. Sotto le colonne c’era moltissima gente ad aspettare che spiovesse, o che avevano gettato la spugna si erano arresi all’idea di passare la notte così, tra una sigaretta e l’altra, perché non sapevano dove andare. C’era chi veniva da fuori città, e molta gente raccontava che gli autobus erano talmente colmi che gli autisti non facevano più salire, e non si fermavano nemmeno più. Si erano fatte le quattro passate, tanto valeva aspettare mattino.
Di lì a poco si diffuse la notizia che il black-out riguardava tutta l’Italia. Qualcuno gridava all’attentato, altri più realisticamente, pensavano che i francesi – invidiosi – ci avessero tagliato la corrente. Come apprendemmo più tardi, intenzioni a parte, era l’ipotesi più vicina alla realtà. Altri ancora si immaginavano che Veltroni il giorno dopo, per mettere una pezza alla situazione, avrebbe dichiarato che si era trattato in realtà di una performance, una performance collettiva all’insaputa degli stessi partecipanti, e che tutto era stato accuratamente progettato in anticipo. Guardare una Roma immersa in quel buio irreale, da sotto le colonne del pantheon, aveva preso in effetti una piega onirica e un po’ teatrale.
Nel frattempo all’odore di pioggia si era mescolata nell’aria una strana eccitazione che scuoteva un po’ tutti. C’era chi urlava senza un perché, e c’era qualcun altro gli rispondeva. Poi a qualcuno venne un’idea semplice quanto bizzarra. Il display rotondo di un cellulare proiettò una luce blu elettrico sul monumento: con quel buio pesto era piuttosto visibile, e il cono di luce prendeva tutta l’ampiezza del portone d’ingresso. Il tipo cominciò a giocare con le ombre cinesi. C’è stato un boato di approvazione. Da più parti cominciarono ad applaudire con sempre maggiore entusiasmo gli animali che si avvicendavano sul muro. Poi arrivò il momento in cui qualcuno cercò di intonare una canzone, e altri cominciarono ad andargli dietro. Incominciammo a domandarci se per caso non ci fosse qualche strumento in giro.
In quel momento si levò dal buio una musica ritmata e travolgente, e tutti cominciarono a domandarsi cosa stava accadendo. Come spuntando dal nulla una banda si era messa a suonare, lì, sotto le colonne del Pantheon: dodici, forse quindici persone avevano tirato fuori trombe e clarini, sassofoni e tamburi e in men che non si dica avevano cominciato a suonare una musica dal sapore balcanico, radunando attorno a sé tutta la gente e il loro entusiasmo. In tanti ballavano nel buio più completo, come rapiti da quella sorpresa inaspettata, e battevano le mani tenendo il tempo. Quando la canzone finì ne seguì un’altra, e poi un’altra ancora, e ogni volta la gente applaudiva e gridava, eccitata dall’abilità dei musicisti e da quella festa inaspettata, nata in modo spontaneo dal naufragio nel buio delle performance istituzionali. La contingenza e l’imprevisto stava regalando una magia particolare a quello che stava succedendo, che era quanto di più teatrale mi era capitato di vedere fino a quel momento. Un “evento” nel vero senso della parola.
La musica proseguiva, i ritmi si alternavano, quelli più jazzati a quelli di sapore ebraico, quelli più lenti a quelli più danzerecci. L’acustica era perfetta, e rendeva quel concerto ancora più incredibile. La luce gialla a intermittenza di un camion per le pulizie stradali cominciò a illuminare la gente e i musicisti come in un rave. I display variopinti dei telefonini facevano il resto. A un certo punto la banda attaccò quasi sommessamente un ritmo che tutti avevano subito riconosciuto. Le note di “Bella ciao” attraversarono la notte romana riempiendo piazza della rotonda e ci mettemmo tutti a cantare a squarciagola le parole. La mente di qualcuno andò alle recenti uscite di Berlusconi, che pochi giorni prima aveva detto che Mussolini non aveva mai ammazzato nessuno, e aveva rincarato la dose con la battuta sulla gente mandata “a fare le vacanze al confino”. “Lo vedi quali sono i valori su cui si fonda questo cazzo di paese!” cominciò a urlare a voce piena un ragazzo, visibilmente eccitato. Quando la canzone terminò la gente, spontaneamente, la riattaccò di nuovo, e questa volta soltanto con la voce. Un filo di musica si aggiunse sul finale.
Meno rapidamente di com’era arrivato, il buio se ne stava andando, ma la cosa ci aveva colto comunque di sorpresa. Erano le sei e cominciava a schiarire, se così si può dire, visto che la pioggia non aveva intenzione di smettere. I musicisti pian piano cominciarono a rimettere gli strumenti nelle custodie. Qualcuno andò a chiedere chi fossero e se facevano parte dell’organizzazione della serata. “No – rispose uno dei ragazzi – ci andava solo di uscire e suonare un po’. Siamo la Titubanda. Facciamo le prove in un centro sociale sulla Prenestina, se volete venire a sentirci…”.
Nel frattempo la pioggia si era fatta meno insistente e piccoli gruppi di persone cominciavano a incamminarsi in cerca di autobus. Così com’era venuta quella nottata se ne stava andando, disfacendosi alle prime luci del giorno. Ce ne restava però ancora tutto il sapore in bocca e la sensazione attaccata alla pelle. Poi altra gente cominciò a dirigersi verso Torre Argentina, nella speranza di trovare un autobus che andasse da qualche parte. Lo facemmo anche noi.
Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.