
Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo (fonte immagine).
Il libro che una decina di anni fa diede allo scrittore nativo americano Sherman Alexie la meritata celebrità si chiamava The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (in Italia è uscito un paio di anni fa per Rizzoli con il titolo fedele all’originale Diario assolutamente sincero di un indiano part-time). Alla sua uscita in America, nel 2007, venne riconosciuto e celebrata dalla stampa come la prova evidente che il “grande romanzo americano” alla fine era un concetto adattabile. Poteva esistere, per esempio, anche un “grande romanzo nativo americano”, e Alexie lo aveva appena scritto. Il Diario di Alexie era e non era un romanzo, era e non era un’autobiografia. Era per ragazzi, ma anche per adulti. A tratti disegnato e accompagnato da tavole a fumetti (della fumettista Ellen Forney), raccontava le avventure di un giovane nativo americano metropolitano che, come il suo autore, era nato e cresciuta nell’America di oggi.
Scrittore a tempo pieno (rispetto alla scrittura si definisce “workaholic e ossessivo compulsivo”), prima e dopo il Diario Alexie ha scritto altri romanzi, libri per ragazzi, poesie, sceneggiature. Ventisei volumi in tutto. L’ultimo è un eccellente memoir dal titolo You Don’t Have to Say You Love Me (come la canzone di Dusty Springfield, pubblicato lo scorso giugno in America, uscirà più avanti quest’anno in Italia per NN Editore). Alla versatilità del proprio scrivere, Alexie non dà grande importanza. Nelle interviste, quando è interrogato in proposito, attribuisce la cosa al suo essere uno scrittore nativo americano. “Non ci sono scrittori nativi che puoi considerare specializzati in un genere particolare”, dice. Dice che lui emula la categoria, e dunque non si specializza in niente. Ma non è vero.
La verità sembra più che, nei libri o nelle interviste, quando Sherman Alexie dichiara qualcosa che riguarda se stesso e i nativi d’America non sai mai quand’è serio e quando prende in giro (se stesso, nativi, non-nativi, te che leggi seriamente quello che dice). Scherza sugli stereotipi che da secoli circolano sui nativi americani, stereotipi che tecnicamente dovrebbero farlo inorridire, infuriare o anche solo irritare, ma con cui lui ha fatto pace ai tempi del liceo, capendo saggiamente che l’unico modo per rompere uno stereotipo è non rientrarci.
Nato in una riserva indiana, a Wellpinit, nello stato di Washington, non lontano da Seattle (dove vive adesso, in automobile Wellpinit-Seattle distano poco meno di sei ore), Alexie ha frequentato le scuole della riserva fino al liceo, decidendo a quel punto (autonomamente rispetto alla famiglia) di iscriversi a un normale liceo pubblico nella vicina cittadina di Reardan. Lì si è ritrovato in un ambiente tendenzialmente orientato verso gli stereotipi, nel caso dei nativi d’America tutti quanti infranti dall’arrivo di Alexie: un ragazzino americano come tanti altri che non corrispondeva a nessuna della qualità (o difetti) attribuiti ai nativi. Agli occhi degli altri liceali era “uno di loro”. La sua passione, insieme alla scrittura, era (ed è) la pallacanestro. Da ragazzo passava più tempo tra playground e tornei che ai powwow e alle altre cerimonie spirituali della riserva Spokane in cui è cresciuto (la madre era un’indiana Spokane, il padre era del popolo dei Coeur d’Alene). Ma di quella spiritualità sono inevitabilmente intrisi i suoi libri, titoli inclusi.
Danze di guerra, pubblicato in America nel 2009 e felicemente in uscita a inizio febbraio in Italia per NN Editore (di Laura Gazzarrini l’impeccabile traduzione, pp. 256, 17 euro), è uno dei suoi libri migliori (nel 2010 ha vinto il PEN/Faulkner Award per la fiction). E della sua capacità di vagabondare brillantemente tra i generi è forse uno dei migliori esemplari, presentandosi come un libro che è autobiografia, semi-autobiografia, finzione, poesia, intervista immaginaria. Le singole parti si compongono in un tutto che è un ritratto remixato dell’autore, con cui presenta al lettore schegge della sua vita, e scandaglia in modo esatto questioni diventate cruciali in questa nostra età contemporanea: l’identità in primis, e poi l’appartenenza, a un amore, a un lavoro, a una famiglia, a una città, a una casa, a qualsiasi cosa sia in grado di contenerci e convincerci di essere anche solo un po’ adeguati.
Il libro è comico e sentimentale, costellato di poesie che parlano della nostalgia dei telefoni a gettoni e delle telefonate a una ragazza da chiamare solo per verificare che non sia altrove a baciare un altro (“Vorrei / poterne trovare uno / e richiamare / tutto quel che / io / ho amato”). O della nostalgia delle compilation di canzoni, che dicevano l’amore meglio di quanto saremmo riusciti a dirlo noi: “Potevano volerci giorni / ascolta, scegli, pausa, / rifletti, registra, riascolta, cancella / e cambia”. Ma le pagine migliori della Danze di Alexie restano quelle in cui trova modi raggelanti e sempre autentici per raccontare l’inadeguatezza che si prova, a una certa età e in ogni momento della vita, rispetto a chi c’era prima di noi, padri e madri e avi lontani tutte le distanze, e a chi è insieme a noi. Un’inadeguatezza che porta a compiere atti in sé inenarrabili, anche solo per pudore, in cerca di qualcosa che stia a metà tra colpa e redenzione, trasformando i crudi fatti (pestaggi, tradimenti, omicidi involontari ma reali) in storie magnetiche che rendono la letteratura quanto di più simile ci possa essere alla vita.
Così Sherman Alexie racconta di un ragazzino nero entrato a casa sua per rubare qualche dvd, e ucciso per sbaglio, nel tentativo goffo di difendere il proprio territorio. Racconta dell’incapacità di amare gli amati, la moglie, i figli, il padre, la madre, provando comunque ad amarli ma sempre in un modo che suona sbagliato, insufficiente, inadeguato rispetto all’idea stessa di cosa debba essere l’amore. Racconta di un padre che a volte è un ubriacone bugiardo, e qualche pagina dopo è un eroe. Racconta di una moglie a cui dice che il desiderio è scomparso, ma non riesce a dire che l’amore quello rimane, lasciando che la relazione rimanga impigliata nell’incompiutezza del tempo presente. L’effetto che fanno i libri di Alexie è che non sai mai se le storie che racconta gli sono capitate sul serio, se sono vere o no. Ma quasi subito, dopo poche pagine, smetti di chiedertelo, te lo dimentichi, perché semplicemente ci credi. “Sono un genio bugiardo”, pensa uno dei suoi personaggi in Danze di guerra. Poi: “E cos’è mentire se non una forma di narrazione?”
È nata a Bolzano e ha vissuto ad Algeri e Palermo. Abita tra Roma e New York, dove traduce e scrive di libri, cinema e fumetti per La Repubblica, Il venerdì e D. Ha tradotto, tra gli altri, Charles Bukowski, Tom Wolfe, Jacques Derrida, A.M. Homes, Douglas Coupland, James Franco, Lillian Roxon e Lena Dunham, e ha tradotto e curato la nuova edizione italiana di Jim entra nel campo di basket di Jim Carroll (minimum fax, 2012). Insieme a Daniele Marotta è autrice del graphic novel Superzelda. La vita disegnata di Zelda Fitzgerald (minimum fax, 2011), pubblicato anche in Spagna, Sudamerica, Stati Uniti, Canada e Francia.

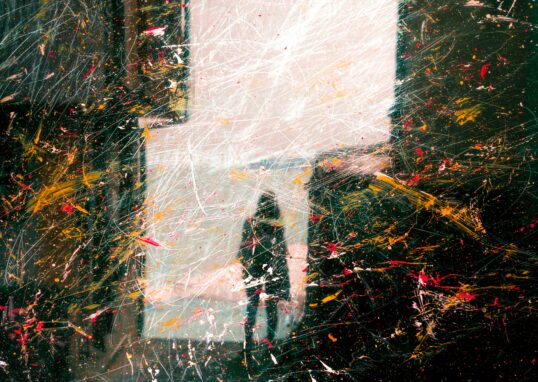

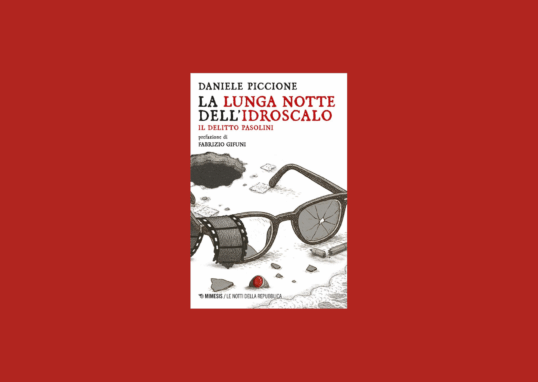
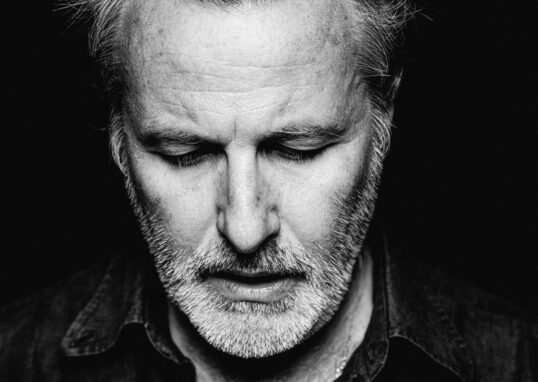


Ciao Tiziana,
in “Americani”, numero di Panta del 1994, il racconto di Sherman Alexie “Tonto e il Cavaliere Solitario fanno a pugni in paradiso” era decisamente uno dei più belli. Stasera riprendo quel libro per me fondativo (avevo sedici anni!) e ritrovo gli albori di Charles D’Ambrosio, Jennifer Egan, Jeffrey Eugenides, Donna Tartt, William Vollmann, David Foster Wallace. Per vent’anni mi sono chiesto come mai un paio di quegli autori – Sherman Alexie e Pam Houston – non fossero diventati famosi da noi, perché li trovavo bravissimi. Forse perché sono rimasti a lungo scrittori di racconti… Ma niente, sono solo felice di trovare stasera questo tuo articolo e mi sono lasciato prendere dalla nostalgia. Spero che tanti leggeranno il vecchio Sherman. Un abbraccio.
Negli ultimi due mesi sono uscite molte accuse nei confronti di Sherman Alexie relative a casi di molestie sessuali, e mi sorprende e mi turba che l’articolo non contempli queste informazioni, o anche che minima et moralia non abbia pubblicato un addendum relativo a questi fatti, compresa l’ammissione di Alexie stesso. (Non mi sorprende invece che l’editore non abbia preso provvedimenti, come annullare la pubblicazione dell’altro titolo di Alexie previsto, ma mi sarei aspettata un po’ più di rumore dai circoli culturali che lo circondano, che tante parole hanno speso sul movimento #MeToo). In questo senso, celebrare oggi Alexie come voce per le comunità nativo americane, quando lui ha sfruttato la sua posizione all’interno di queste comunità per perpetuare una oppressione che le donne nativo americane subiscono da secoli, ecco, mi sembra fuori luogo, che il suo valore estetico sia alto o no.