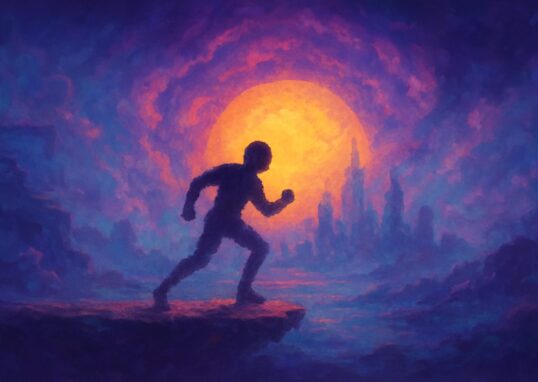di Stefano Trucco
Ma la musica è pessima, questo me lo concedi? Cioè, il rumeno con la tamarrata in spagnolo, e l’estone che faceva del, come dire, country baltico, e il patetico hair metal anni ’80 dei bulgari, e Achille Lauro con la sua cosa, sempre la stessa, e pure per San Marino (!), e i francesi… ecco, esattamente cos’era quella cosa mezza bretone e mezza dance?
Sì, il vecchio metallaro con simpatie punk che è in me istintivamente rifugge, come tutti quella della sua generazione che non si capacitano di come questa cosa che un tempo tutti – cioè tutti quelli che contano, noi maschi bianchi di mezza età – consideravano un ridicolo baraccone che non si poteva prendere sul serio, persino peggio di Sanremo, sia oggi, appunto, l’evento culturale più seguito al mondo, proprio come Sanremo è l’evento culturale più seguito d’Italia, e che una band italiana, i Maneskin, una band che fino a quel momento nessun competente aveva preso sul serio, l’abbia vinto l’anno scorso e che perciò quest’anno si sia tenuto in Italia, a Torino. La gente al PalaOlimpico però dava tutta l’aria di divertirsi tantissimo e la mia amica Laura che vive a Torino mi conferma che la città pure s’è divertita parecchio tutta la settimana con migliaia di turisti, e band e cantanti che andavano in giro a fare concerti nelle piazze e nei locali e l’Eurovillage al Parco del Valentino affollatissimo.
Detto senza alcuna vergogna, anzi: ho visto tutte e tre le puntate dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, senza perderne un minuto, cosa che faccio da un po’ d’anni. Pure la mamma 85enne ha gradito tantissimo. La differenza è che quest’anno per la prima volta sembra che gli italiani si siano interessati sul serio, con ascolti tivù altissimi e approfondimenti sui giornali e i siti d’informazione. Gli italiani hanno deciso, dopo tutti gli altri, che l’Eurovision è DIVERTENTE.
La reazione più comune, a volte accompagnata da un cauto interesse, come dire, ‘sociologico’ o ‘culturale’, è stata, fra i maschi di mezz’età come me che formano il grosso della chiacchiera musicale italiana, di sconcerto: cioè, com’è che questa cosa è diventata importante tutto a un tratto? Beh, incredibile ma vero, prendiamone atto.
Il fatto resta, aggiungono, che è tutta musica di m**** e in più che l’Ucraina ha vinto solo per motivi politici e insomma, questo dimostra che la musica all’Eurovision non conta nulla, che la vera musica è un’altra cosa. Ecco, parliamone.
Intanto, sì, l’Eurovision è sempre stato uno spettacolo politico nel senso più stretto del termine. Figurati in tempo di guerra fra due stati membri, l’Ucraina (vincitrice nel 2004 e nel 2016) e la Russia (vincitrice nel 2007), di cui uno identificato come l’aggressore e espulso, cioè la Russia (e qui c’è già una scelta politica, no?).
Prendiamo uno dei pezzi più divertenti di questa edizione, quello della Moldavia: “Trenuleţul” di Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, cioè l’unione di un gruppo punk-rap con un duo che fa musica più tradizionale, un po’ come gli Extraliscio in Italia. Hanno conquistato un onorevole settimo posto grazie al televoto.La canzone, con tanto di citazione dei Ramones – ‘Hey ho, let’s go!’ – parla di un viaggio notturno in treno da Chisinau, capitale della Moldavia, a Bucharest, capitale della Romania. Vai a vedere il testo e scopri che, senza dichiarazioni dirette, proibite dal regolamento, è un pezzo pesantemente politico su un tema caldo di laggiù, la possibilità di unione fra Moldavia e Romania osteggiata dalla minoranza russofona che ha pure creato un suo stato riconosciuto solo da Mosca, la Transnistria. Le uniche giurie nazionali a aver dato il massimo dei voti – 12 – all’Ucraina sono state quelle più vicine alla guerra: Moldavia, ovviamente, ma anche Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Parecchia roba per una canzonetta divertente che sentiremo parecchio in spiaggia quest’estate.
Ma è stato così fin dall’inizio. Solo, oggi un po’ di più.
La prima cantante della prima edizione del Eurovision, nel 1956 – molto sobria: da Ginevra, bianco e nero, sette nazioni, vestiti da sera, un sipario, fiori, un cameraman -, fu un’ebrea olandese, Jetty Paerl. Fuggita con la famiglia in Gran Bretagna per sfuggire all’invasione tedesca era diventata una delle voci più popolari della radio dell’Olanda libera dove cantava canzoni piene di speranza nel domani, come usava durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche canzoni satiriche contro i tedeschi e i collaborazionisti, e leggeva i messaggi per la Resistenza.
Nel 1956 c’erano ancora un bel po’ di macerie materiali e morali in giro per l’Europa e tutto poteva essere utile per sgombrarle, tipo copiare questa bella idea italiana di un festival della canzone organizzato come una gara, con vincitori e premi. Ovviamente col massimo buon gusto possibile.
L’idea, geniale, è che non si può votare per sé stessi ma solo per gli artisti delle altre nazioni. E’ questo, ce ne accorgiamo oggi che l’Eurovision è un buco nero lanciato a risucchiare il mondo intero (partecipa l’Australia, tipo, e se il Giappone volesse potrebbe tranquillamente), a aver reso l’Eurovision uno spettacolo eminentemente politico: non le nobili intenzioni dei burocrati che lo idearono, non le canzoni sulla pace e l’amicizia fra i popoli, non gli occasionali riferimenti politici (del resto proibiti), ma la necessità di trovare i voti, di presentare programmi che possano interessare (o canzoni che possano piacere), di creare coalizioni, di formare alleanze, di scambiarsi favori, – insomma, POLITICA, quella vera. Soft power, certo, e anche Nation Branding, cioè il lavoro sull’immagine che la nazione vuole dare di sé stessa all’estero. La vera musica politica, che non è la colonna sonora di una immaginaria rivoluzione a venire che qualcun altro dovrebbe prendersi la briga di organizzare ma per qualche motivo non lo sta facendo e allora tanto vale farci su una canzone o un film o un romanzo mentre si aspetta.
Prima votavano solo le giurie, poi venne il televoto, ora c’è un sistema simile a quello del Congresso degli Stati Uniti: ogni stato, quali che siano le dimensioni, ha un numero fisso di voti da distribuire, da 12 a 1, come il Senato; poi c’è il televoto, dove invece le dimensioni contano, come la Camera dei Rappresentanti. L’Ucraina, non particolarmente favorita dalle giurie (che avrebbero premiato la Gran Bretagna), ha vinto grazie a un massiccio televoto di simpatia un po’ da tutta Europa, Italia compresa. Risultato un po’ scontato e per fortuna che hanno portato un pezzo rap-folk – ‘Stefania’, una lettera d’amore alla mamma – più che dignitoso.
Succede che si formano blocchi politici, specie a partire dall’arrivo degli stati dell’Europa dell’Est e post-sovietici, che cambiano tutto lo spirito della competizione: gli scandinavi si votano regolarmente a vicenda, guidati dalla Svezia; Grecia e Cipro si votano con monotona regolarità; malgrado la guerra gli stati dell’ex Jugoslavia spesso si votano fra di loro (anche quest’anno la Croazia ha votato Serbia); poi ci sono i complessi scambi di voti degli stati ex URSS, però segnati dalla rivalità fra Russia e Ucraina; e i blocchi che non ci sono, come quello latino o mediterraneo, o non ci sono più, come il blocco francofono; e comunque nessuno vota mai per la Germania.
L’altra cosa importante è la lingua. All’inizio si poteva cantare solo nella propria, il che favoriva le lingue dominanti, cioè inglese e francese. Nei primi vent’anni domina il francese, perché lo usano ben cinque nazioni – Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Monaco. Poi, dopo un periodo negli anni Settanta in cui si può cantare come si vuole e questo permette agli svedesi ABBA di diventare un fenomeno mondiale cantando in inglese, si torna alle origini ma ci sono più nazioni e ora è l’inglese a dominare e se ne avvantaggia soprattutto l’Irlanda, che negli anni Novanta vince tre volte di fila. Infine, dal 1999 liberi tutti e la maggioranza delle canzoni sono in inglese, così che Irlanda e Gran Bretagna non vincono più. Ma c’è spazio per tutti e tutte le lingue hanno avuto la loro occasione, comprese due o tre inventate. L’Italia, che rifugge l’inglese, ha per due volte partecipato con canzoni in napoletano.
Quindi per gli stati che non hanno lingue particolarmente pop la scelta è sempre se cantare in inglese o la lingua natale o in un mix. Oppure fare come la Romania che quest’anno ha portato una canzone in spagnolo e nel 2007 in italiano. E cosa portiamo? Qualcosa di nostro, folkloristico, con strumenti tradizionali, magari con un arrangiamento un po’ più moderno? Oppure una cosa pop dance che potrebbe venire da dovunque? Una bella ballatona romantica con tanto sentimento e i capelli al vento? Qualcosa di più ‘moderno’ – Rock? Metal? Rap? Elettronica? Reggaeton? Un mix fra tutto? E se provassimo a mandare un artista vero? I ballerini ce li possiamo permettere quest’anno? Basta che si noti, dai.
Tutte queste notizie le prendo da un gran bel libro pubblicato di recente, ‘Capire l’Eurovision. Tra musica e geopolitica’ di Giacomo Natali (Vololibero, 2022). Natali racconta molto bene la storia dell’ESC e soprattutto racconta la partecipazione alla gara di ogni singolo paese e di come questa sia strettamente legata alla politica interna e internazionale, oltre che alla cultura, di questo paese, sia di quelli che ci hanno investito tantissimo sia di quelli che l’hanno preso alla leggera. Alla fine vi fate anche un bel ripasso di geopolitica, che di questi tempi viene utile.
E questo ci porta al secondo problema: ma è davvero musica così di m**** come dicono tutti?
Potremmo anche dire di sì. Gli artisti diventati veramente famosi grazie all’Eurovision si contano sulle dita di una mano: Abba, Celine Dion, Maneskin, più qualcun altro che non vinse, tipo Julio Iglesias. Fra l’altro noti sempre che c’è gente che sa cantare e suonare sul serio ma fa cose per nulla interessanti. C’è sempre un due o tre canzoni che si fanno notare (questa la canzone serba dei Konstrakta, per me) ma il resto è del tutto dimenticabile e dimenticato, per non dire proprio brutto. Ma non è così da sempre e dappertutto? Come disse Theodore Sturgeon, riferendosi alla fantascienza: “Ninety percent is crud, but then, ninety percent of everything is crud”.
Se Nietzsche contemplava la tragedia di vivere in un mondo in cui Dio era morto, noi, più modestamente, viviamo in un mondo in cui a essere morto è il rock, cioè la musica ‘giovane’ di almeno tre generazioni che però a un certo punto è diventata la musica di noi nostalgici di mezza età. Vecchi rocker convinti che nessuno oggi capisca la ‘vera musica’ e dediti a un ossessivo culto dei morti, basi di ogni classicismo. Le generazioni successive, in compenso, come musica identitaria hanno scelto il rap inteso nel senso più ampio del termine.
L’Eurovision ha sempre tenuto un po’ alla larga i generi considerati ‘importanti’, tanto il rock quanto il rap: è passato dalle chanson francesi eleganti al bubblegum pop, dalle canzoni neomelodiche e pseudo operistiche alla dance estiva latina – tutti generi che non sono considerati importanti da chi se ne capisce di musica. Piacciono alle persone sbagliate. Non sono, di solito, considerati ‘autentici’, concetto che comprende sia la personalità individuale che l’innovazione che la trasgressione delle regole. Insomma, il loop superomistico ereditato dalla musica classica e conservato dal jazz e dal rock che identifica la musica con la sofferenza dell’artista. Il noto processo dell’autonomizzazione di generi musicali che nascono come accompagnamento al canto religioso o di corte oppure, nel XX secolo, come musica di ballo e preferiscono dimenticare la modestia dell’origini e darsi una certa importanza.
All’Eurovision funziona la musica che si mette ai matrimoni, che si sente nei supermercati o in palestra, e che, in realtà, piace a un mucchio di gente, gente a cui non piace né interessa particolarmente essere sfidata. Vogliono divertirsi e magari anche commuoversi (le canzoni tristi vanno alla grande) e se c’è un po’ di messa in scena non gli dispiace per niente. Musica che non conta. Tipo quando si parla di generi in letteratura o al cinema e c’è il noir, la fantascienza, il fantasy, l’horror, il weird etc – ma mai il romance o come si dice da noi il rosa, perché piace alle persone sbagliate.
Il mondo però sembra fregarsene del giudizio dei competenti e va per la sua strada, che non è quella della reverenza a classici che un tempo si credevano ribelli e trasgressivi e si ritrovano a essere una musica identitaria generazionale pronta per l’oblio con la morte del suo fandom. Alla fine, non era altro che posizionamento sociale e etnico. Poi andrà un po’ meglio, certo: come per la classica e il jazz un certo numero di standard rimarrà nel patrimonio dell’umanità e il resto nelle mani degli accademici. Basta non irrigidirsi, no? Come se fosse facile: arriva un gruppo rock che finalmente sa come fare il suo mestiere e solo perché è italiano non lo si riconosce, così che i Maneskin, nati in Italia, hanno dovuto fare tutto da soli e diventare famosi in tutto il mondo senza chiedere il permesso ai competenti italiani. Way to go, kids.
Qui possiamo riunire i due capi della storia, la politica e la musica, e ci tocca tornare all’evento che ha condizionato questa edizione dell’ESC, la guerra fra Russia e Ucraina.
Parecchia gente è convinta che si tratti di una guerra per procura fra Nato e Russia, con gli ucraini inconsapevoli pedine (un po’ come i vietnamiti negli anni Sessanta). Ci può essere del vero ma è sgradevole questa negazione di qualsiasi agenzia agli ucraini: non si concepisce che essi possano avere un qualche interesse al proprio destino. Se decidono di resistere all’invasione è perché sono manipolati (troppa televisione, probabilmente: non per niente il presidente ucraino era un comico televisivo) e non perché all’improvviso hanno deciso che la loro indipendenza era importante e che il 24 febbraio 2022, come disse nel 1916 l’ultimo poeta occidentale che trovasse bella la guerra, ‘a terrible beauty is born’. Come non si capisce questo non si capisce quanto possa essere importante una manifestazione musicale fra nazioni di cui non si sa nulla e che fanno musica di m**** perché, come diceva un grande poeta italiano, ‘non si può essere un grande poeta bulgaro’.
Il libro di Natali è tutto su queste individualità nazionali fortemente consapevoli di esistere anche al di sotto della nostra soglia di attenzione e con le quali le logiche imperiali devono fare i conti, e che, fra le altre cose, sono fissate con l’Eurovision, che vedono come occasione di mostrarsi il mondo nel loro vestito migliore. Ecco, l’Eurovision come prototipo di un mondo in cui gli Stati Uniti non ci sono e la Russia può essere espulsa.
Musicalmente, invece, l’Eurovision è il prototipo di un mondo che ha deciso di ignorare il buon gusto dei competenti scoprendo che se ne può fare tranquillamente a meno e che ci si diverte lo stesso perché il buon gusto è sempre stato il peggior nemico dell’arte, e mala che vada si balla (grazie anche a una generosa dose di estetica camp e LGBT+). Del resto, se vinci l’Eurovision oggi c’è il rischio che ti invitino al Coachella o a Lollapalooza, e difatti gli Stati Uniti hanno messo su la loro versione, l’American Song Contest e pare sia andata alla grande…
(In copertina: foto di Vugarİbadov – Opera propria, CC BY-SA 3.0)
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente