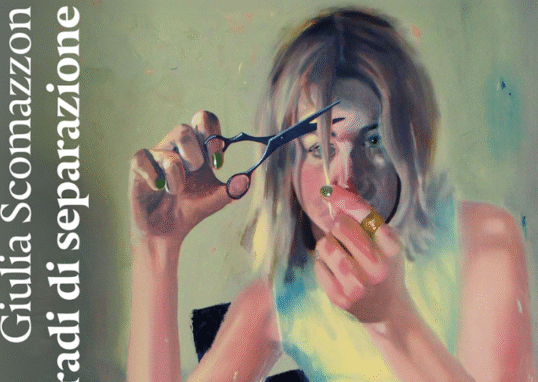di Simone Bachechi
Guido Morselli (1912-1973) ci aveva visto lungo, come molti di quei grandi scrittori, nel suo caso ancora oggi semi sconosciuto per quanto oramai sdoganato e ampiamente pubblicato ma del tutto ignorato in vita (tutti i suoi romanzi usciranno postumi), che hanno le antenne puntate sul futuro e riescono a cogliere nel presente le scaglie di quello che sarà da lì a poco, trasfigurandolo e anticipandolo, non nascondendo di fatto una malinconica nostalgia verso il passato tramite la tagliente ironia delle proprie opere le quali magari in forma di puro divertissement, distopia, ucronia o qualsiasi altro tipo di etichetta si voglia dare alle loro avventure narrative, riescono a gettare un acutissimo sguardo sul presente che nelle loro pagine diventa il futuro che incontriamo ogni giorno. Questo non perché dotati di particolari talenti divinatori o oracolari ma in quanto grazie a una ferrea logica deduttiva e un’attenta e ragionata analisi sul reale riescono e prefigurare un futuro che “è già alle nostre spalle” come osserva il protagonista del primo romanzo pubblicato di Morselli. Si tratta di Roma senza papa. Cronache romane di fine secolo ventesimo (Adelphi, pagg. 184), uscito nel 1974, l’anno successivo al suicidio dello scrittore emiliano ma lombardo di adozione.
Nato a Bologna, si trasferirà con la famiglia all’età di due anni a Milano dove trascorrerà un’infanzia relativamente tranquilla fino alla morte della madre del 1922 che lo segnerà profondamente, anche in considerazione del difficile rapporto con il padre spesso assente per motivi lavorativi. Inizierà a scrivere saggi durante gli studi giuridici del suo periodo universitario nel capoluogo lombardo, e si allontanerà ulteriormente dalla figura paterna che aveva cercato di indirizzarlo verso la carriera di promotore pubblicitario, riuscendo a ottenere dallo stesso, già dirigente della casa farmaceutica Carlo Erba, un vitalizio che gli permetterà di dedicarsi alla prediletta lettura e scrittura. Due sole le opere pubblicate in vita da Morselli, i saggi Proust o del sentimento (1943) e Realismo e fantasia (1947). Per il resto la sua parabola letteraria è segnata dai continui rifiuti degli editori, fra cui da ricordare la stroncatura di Italo Calvino a Il Comunista, rifiuti che forse fin troppo banalmente la vulgata vuole collegare all’estrema decisione di togliersi la vita nel 1973 nella dependance di famiglia a Varese, non troppo distante dalla ormai celebre Casina rosa presso Gavirate, il rifugio, oggi sorta di casa-museo, che Morselli aveva scelto sulla collina di Santa Trinità nei pressi del Lago di Varese dove si è dedicato per anni con lo zelo dell’eremita alle sue passioni letterarie, oltre che a fare l agricoltore e a cavalcare.
Spesso la fortuna postuma di un autore è direttamente proporzionale allo stigma ricevuto in vita, in parte la cosa che è accaduta a Guido Morselli. Curioso, ma non troppo, che le sue opere siano uscite con pressoché perfetta precisione cronologica dopo la sua morte, sulla cui cosa nessun giornale dell’epoca scrisse un solo rigo, tanto da ritenere lecito domandarcene il motivo e provare a azzardare una risposta. Forse non basta il trito cliché del genio incompreso, forse troppo inattuale, scomodo, in anticipo oltre misura sui tempi non è stato capito dai suoi contemporanei, lo sentiamo dire spesso in campo artistico, e non solo letterario, o forse è stato capito troppo, e in questo caso entra in gioco una motivazione “politica” in merito alla tacitazione (censura?) della sua opera da parte degli stessi. Caratteristico nelle opere di Morselli è l’ interrogarsi sul rapporto tra tradizione e progresso, con la tendenza a rimodellare la Storia tramite la scrittura. Palese nell’esordio postumo con il romanzo di Roma senza papa è l’utilizzo dell’argomento e dell’ambientazione ecclesiastica per parlare della modernità da parte di uno che non ci si è mai trovato troppo a suo agio e che si è interrogato nelle sue opere sul rapporto tra innovazione e tradizione, lui che si definiva “fobantropo”, che ha fatto dell’isolamento condizione esistenziale e artistica, come accade spesso per le grandi vocazioni, questo in un’epoca di impegno e “contestataria”, pre e post-sessantotto, nella quale la frenesia del progresso e delle trasformazioni non poteva che far guardare con sospetto a qualcuno con l’aria da “conservatore”.
Il fatto è che con Morselli c’è poco da stare a razionalizzare, eppure è bello e necessario farlo, perché come in Roma senza papa, la profonda erudizione su temi teologici, ecclesiastici e di storia della Chiesa è immensa e traspare a ogni pagina del romanzo, testimoniando uno sterminato lavoro a monte. Su questo sfondo si innesta l’affabulazione, il romanzo, formalmente un’ucronia. Ambientato intorno alla fine dello scorso millennio, trent’anni dopo la sua stesura (Morselli ha scritto nel 1966 il romanzo che verrà da lui terminato l’anno successivo), Roma senza papa narra le vicende legate alla discesa a Roma di un prete svizzero dal cognome e età imprecisati che torna nella città eterna dove anni prima ha svolto i suoi studi teologici. Don Walter, questo anagraficamente quello che si sa di lui oltre al fatto che sia coniugato con la moglie Lotte (il celibato degli ecclesiastici è stato abolito) si reca nella capitale della cristianità, l’Urbe inenarrabilis che traspare nel romanzo su uno sfondo alla Blade Runner, per avere udienza dal papa e per sottoporre auspicabilmente alla sua attenzione e a quella delle maggiori autorità ecclesiastiche il suo trattato teologico in difesa del culto mariano dal titolo Difesa dell’Iperdulia sul quale ha speso “30 mesi di lavoro oscuro, massacrante”, con un solo scopo: “riportare sul terremo proprio una discussione che sta diventando sociologica, etnologica, persino politica, mentre è soltanto: dog-ma-ti-ca”. “Non si può continuare con i polls e le interviste a discutere se la Madonna sia un’ebrea convertita come tante altre, o nella migliore delle ipotesi una santa.”
La Chiesa si sta protestantizzando, la società è già liquida, ben prima che questo assioma fosse teorizzato da Zygmunt Bauman nel suo celebre saggio del 1999, l’ortodossia sembra essere un lontano ricordo, l’ateismo è una religione. Sullo sfondo della Guerra Fredda la Chiesa flirta con l’Urss e si fa mediatrice della spartizione del mondo. Niente di nuovo in fondo in un tempo già ampiamente e da molto secolarizzato, e quindi non sufficiente a giustificare le doti “visionarie” dell’autore. Ma è nella prosa e nel tratteggiare certi scenari fantapolitici che ricordano i più grandi profeti letterari di distopie dalle quali attingono spesso con risultati discutibili autori contemporanei di immensi tomi che affollano le catene editoriali, spesso con il sapore del già visto, che Morselli mostra il meglio di sé. Al pari dei grandi autori fantastici o fantapolitici alla Bradbury o dei grandi satirici alla Swift, con un linguaggio di spericolate ebbrezze altamente letterarie dà conto della complessità del reale narrando con spietatezza e asettica precisione e non concedendo niente al lato emozionale della lettura, la società presente, futura o futuribile, la storia del mondo e la stessa esistenza.
L’impresa di Walter ricorda un’odissea che si esplicita nel ritorno nella città del suo apprendistato sacerdotale, una Roma luogo di incontro tra religiosi e laici nella quale il prelato svizzero si muove come un Leopold Bloom in abito talare. Dopo la più classica odissea omerica c’è stata quella modernista del protagonista del romanzo di James Joyce e con il romanzo (o comunque lo si voglia definire) di Morselli si ha una sorta di odissea post-modernista a sfondo ecclesiastico che si svolge tra i grandi saloni delle università pontificie, negli oratori, in convegni teologici che con il cicaleccio spesso grottesco e incomprensibile sono il basso continuo dell’opera. La pur esile tensione narrativa è data dall’attesa dell’udienza papale, in una sorta di astrusa e grottesca attesa di Godot. Se per Beckett il nome dato all’eminenza grigia del suo più celebre dramma ha i connotati di Dio (God), allo stesso modo si può notare che per il cattolicesimo il Papa sia Dio sulla terra. Il problema è che il papa si è trasferito a Zagarolo, a trenta chilometri dall’Urbe. Lì vive in un anonimo complesso residenziale pentagonale di villette a schiera, in un non-luogo, senza farsi vedere né sentire. Dopo il papa “storico” Giovanni XXXIII, ecco il papa “strano” morselliano, Giovanni XXXIV, il quale pur nell’immaginaria creazione distopica ha una sua valenza storica se si pensa che il romanzo è stato scritto nel 1966 e quindi in date congruenti alla successione allo stesso Papa Giovanni XXXIII. Questo l’espediente più impattante del romanzo e la sua maggiore forza profetica se si pensa alla preconizzazione di un papato a tempo e se si torna alle più recenti vicende del papa dimissionario Benedetto XVI, legate a doppio filo a un’idea molto terrena e quasi pop del papato, tema ripreso allo stesso modo molti anni dopo e sempre in anticipo rispetto alle vicende storiche da Nanni Moretti nel suo Habemus Papam (lecito domandarsi se il cineasta romano abbia preso spunto per il suo film dal soggetto morselliano).
Questo dato fattuale e diremmo essoterico non nasconde una tensione metafisica e una parte più esoterica nel romanzo di Morselli, il quale con lo stile misurato, quasi chirurgico della sua scrittura, eppure così debordante di fantastica ironia e satira è ciò che più affascina, interroga e anche diverte nelle descrizioni di una Roma decadente e futurista allo stesso tempo, nella quale ci si sposta con i bus-cotteri, o per una non meglio tratteggiata via pneumatica che per raggiungere dal centro dell’Urbe la nuova residenza papale impiega mezzo minuto, a dispetto del sovraffollamento dei mezzi dovuto ai continui scioperi, una città svenduta dal papato alle orde di pellegrini-turisti che evoca una delle minori piaghe delle grandi città d’arte dei giorni nostri soffocate dal cosiddetto overtourism, un fenomeno che sancisce nella finzione romanzesca la definitiva decadenza del maschio latino cooptato e sostituito nelle sue prerogative dalle “mignottelle”, procacciatrici di stranieri in gita di piacere nel bel paese ai quali ne propongono ulteriori, di piaceri, una città (ancora profeticamente) piena di buche e crateri ma nella quale persistono tratti del suo fascino decadente come suggeriscono alcune suggestioni quali quella della visione del Palatino che viene suggerita da una delle ectoplasmatiche comparse che accompagnano il girovagare del protagonista: “Va ammirato di giugno, alle otto della mattina, in una giornata di nuvole basse e di scirocco, quelle tali pietre altrimenti non hanno il loro colore”. Sono queste presenze che danno il senso straniante, grottesco e dissacrante del romanzo, tra segreterie apostoliche elettroniche, Gesuiti che producono il GR6, una droga che alimenta il sentimento religioso, progetti di riconoscere un’anima anche agli animali, la psicanalisi applicata al cattolicesimo con tanto di istituto dedicato, prelati che hanno la predilezione per le bibite gassate, varie e bizzarre teorie antropologiche e catecumenali quali quelle prospettate da un monsignore convinto “che gli abitanti del pianeta siano semplici concrezioni gassose e in quanto tali si possa procedere alla loro conversione in tal modo: A) liquefare i catecumeni, mediante apparecchi a conveniente pressione; B) imbottigliarli; C) aggiungere a ogni bottiglia un centilitro di acqua santa; D) agitare con energia. Chiameremo questo procedimento: “battesimo per commistione e soluzione”.
La laicizzazione e progressismo imperante della Chiesa sono gli strumenti che permettono iperbolicamente a Morselli di tessere la tela di ragno della sua narrativa da sempre incentrata sulla dicotomia reale-immaginario, passato-futuro (o futuribile), tradizione-innovazione. La Chiesa sembra diventata un’associazione caritatevole al pari della Croce rossa, testimone non più di un messaggio teologico universale ma al massimo custode di prerogative assimilabili a quelle dell’ONU, nella quale la Fede lascia il campo alla Pace, l’aroma dell’incenso all’odore di trementina, ove “San Pietro è solo un mausoleo. Certo, grazie agli amplificatori è anche un formidabile salone da conferenze, o da concerti.”, dove nella piazza contornata dal colonnato del Bernini, ora che il papa ha traslocato in un’anonima periferia, l’udienza domenicale viene trasmessa in 3D su schermi touch, con annessi tutti gli effetti esilaranti della globalizzazione e mercificazione del sentimento religioso, esemplificati nelle statuine del Sacro Cuore prodotte a Schio e vendute in California sotto la sovraintendenza e il controllo dell’opera missionaria dei francescani di Palo Alto, ad oggi (ma non allora) uno dei centri principali della Silicon Valley con i suo colossi del web e della new economy (che antenne aveva Morselli?). Una laicizzazione che nei fatti romanzeschi si concretizza in concetti quali quello della Socialsolidarietà, in sé opposto a quello di carità cristiana.
Da ricordare che lo scritto di Morselli è immediatamente successivo alla fine del Concilio Vaticano II, le cui tendenze riformatrici sono quelle che più idealmente possono dare occasione alla fervida mente di uno scrittore per le più acrobatiche speculazioni e scenografie che non mancano di virare a delle vere e proprie profezie, profezie raziocinanti, dicevamo: quella geopolitica ad esempio, in parte avveratasi quando sotto la maschera narrativa dell’esplicazione chirurgica eppure visionaria dei destini della Chiesa, in quello che noi definiamo il Medio Oriente, parlando dei destini socio economici di quelle terre dirà: “In quel sacro e fatidico Oriente che grazie ai progressi della tecnologia (essa pure provvidenziale, sappiamo), i sentori e i furori, del petrolio non ammorbano più”. Vengono in mente i modernissimi complessi di metropoli degli stati arabi del Golfo, vere e proprie cattedrali nel deserto sorte dal nulla su suoli fatti di combustibili fossili e ora ricettacoli e centri di smistamento finanziari dei capitali della globalità mondiale, oppure nel caso dello stupore e disappunto degli “indigeni” romani, orfani del Pontefice massimo, cosa che sembra mettere in crisi la loro stessa identità: “ero quirite e or sono Congolese – in omaggio all’usanza che ci impose – Chi da Roman passò Zagarolese” dove coi nostri occhi oggi, noi, quasi sessant’anni dopo ci possiamo leggere l’aura delle ansie dei molti su tematiche come quelle per l’immigrazione. Morselli ha scritto queste cose nel 1966…chissà che tipo di connessioni avesse e chissà che quelle rimuginazioni, elucubrazioni e monologhi interiori del protagonista di Roma senza papa, i suoi incontri e dibattiti con le varie figure del mondo ecclesiastico nel tempo che è costretto ad attraversare, riflessioni intrise di uno scetticismo di fondo, non siano le stesse dell’autore del romanzo, il quale con la sua visione disincantata e destinata alla solitudine e alla marginalità si è inflitto in qualche modo e suo malgrado la stessa condanna.
Da ricordare che Roma senza papa fu pubblicato anticipando le celebrazioni per il giubileo del 1975. A Roma, con o senza Papa, da poco è stata aperta la Porta Santa, rituale che dà inizio all’anno giubilare. Sarebbe bello infine, che in questo anno da poco iniziato, anno che per Santa Romana Chiesa da secoli significa anche remissione dei peccati, compresi quindi si immagina anche quelli di un suicida, che a Morselli stesso potessero essere rimessi i propri di peccati, e semplicemente potesse essere letto da più persone possibili. In tal senso già qualcosa sembra essersi mosso: il volume Gli ultimi eroi edito da Il Saggiatore lo scorso anno contenente tutti i suo racconti e testi teatrali è già una riabilitazione e Morselli ha lasciato dietro di sé una ulteriore grande massa di inediti. Del resto tutti aspettano qualcosa, una salvezza, una vincita, una promozione, una riabilitazione, un amore, qualcuno che ci ascolti, un’udienza, come nel caso del protagonista di Roma senza papa, un’udienza che nella fattispecie si risolve in un nulla di fatto, un en attedant Godot inevitabilmente fallimentare ma illuminante. Morselli attendeva una pubblicazione, e ne sono arrivate a cascata dopo la sua scomparsa, da Contro-passato prossimo a Il comunista fino a Dissipatio H.G. che è ritenuto il suo capolavoro e nel quale fa la comparsa l’inquietante “ragazza dall’occhio nero” che alla luce di quanto accadrà da lì a pochi anni assumerà significati altrettanto profetici e sinistri. Una semplice pubblicazione, non una rivelazione come NON accade nel finale del suo primo romanzo pubblicato postumo, una non rivelazione di fatto durante la famigerata e attesa udienza e un’epifania per un finale nel quale da non dimenticare figura un’altra profezia, quella sull’allunaggio, una tranchant, irrisolta e spiazzante conclusione ricca di iperbolici significati tutti da meditare e che fa di questo libro qualcosa da custodire nei giorni di puro svago dedicati a una lettura di mero divertimento o di voglia di riflettere sul mondo che ci circonda, una narrazione graffiante e provocatoria come solo dalla penna di un grande visionario può scaturire, in un romanzo eccessivo e barocco come una chiesa di Roma, fantastico come un romanzo di Guido Morselli.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente