
di Lorenzo Vargas
Nel 1971 Ursula K. Le Guin pubblica The Lathe of Heaven, un romanzo dove un uomo capace di modificare la realtà sognandone ogni volta una nuova, tenta disperatamente di limitare il suo potere demiurgico tramite l’utilizzo di droghe. Venuto a sapere di questo, l’apparato statale, nella persona di uno psichiatra, gli impone di interrompere l’assunzione di narcotici e mettere il suo terrificante potere a disposizione della comunità, ossia dello psichiatra stesso.
Si navigavano a costa gli ultimi anni della prima rivoluzione psichedelica, cominciavano a venir fuori le prime notizie sul progetto MKULTRA e in generale il ’68 sembrava perdere la rincorsa. Con l’inguaribile ottimismo che contraddistingue lə scrittorə di fantascienza, in The Lathe of Heaven, Le Guin prospetta (o documenta) il riassorbimento della prospettiva di un futuro migliore da parte della macchina del Capitale, comprese quelle stesse sostanze psicotrope che avrebbero dovuto liberare l’umanità dai vincoli della percezione e che invece sarebbero state relegate nel consueto limbo di paranoia e bigottismo per almeno altri cinquant’anni.
Nel ’71 di Le Guin, insomma, il sogno è finito e non ci resta che confrontarci con le macerie affastellate e disomogenee del reale, affrontare le nostre colpe e la connivenza col sistema. In uno sprazzo di pietà da parte dell’autrice lo psichiatra antagonista in Lathe impazzisce nel tentativo di appropriarsi del potere del protagonista (un po’ tipo Jafar col Genio della Lampada), donando così un ultimo tratto fantastico alla trama: il mondo di cui leggiamo è uno dove i responsabili prima o poi pagano.
Passano 50 anni, è il 2020.
In un esprit di simmetria che ha quasi dell’incredibile, gli allucinogeni fanno il loro trionfale ritorno nell’immaginario comune, tanto da far parlare di una seconda rivoluzione psichedelica; le tensioni sociali si inaspriscono ogni giorno di più, nel tentativo di determinate fette della popolazione di liberarsi della stretta sclerotica di un sistema economico morente e in Italia, nel giro di due anni, escono almeno due volumi che chiudono questo spettacolare esercizio in pareidolia, reintroducendo nella fantascienza lo strumento del sogno demiurgico.
Il primo è Urla sempre primavera, di Michele Vaccari (NNE, 2021) e l’altro Noi siamo campo di battaglia di Nicoletta Vallorani (Zona42, 2022).
In Urla sempre primavera (ne avevo già parlato qui) seguiamo tre generazioni dei Delfino, una linea di individui capaci di invadere, influenzare ed infine plasmare i sogni altrui. Sullo sfondo di una Genova gerontocratica, metonimia di un’Italia che si sta lentamente accompagnando al suicidio da sola, i Delfino utilizzeranno la propria capacità miracolosa per legarsi al prossimo e creare una rete rivoluzionaria che sgomini la Venerata Gerusia.
Dall’altro lato, Noi siamo campo di battaglia ci trasporta in una Milano allo sbando, massacrata da ondate su ondate di disastri pandemici e ambientali e gestita da una fosca amministrazione che si sta lentamente accompagnando al suicidio da sola. In questa cornice alcuni studenti creano attorno a una loro ex professoressa una comune clandestina che evolve in una specie di superorganismo attraverso una pratica di trance collettiva, dove la comune accede a versioni parallele di come il mondo potrebbe essere.
Sognare la rivoluzione, affondare le braccia nella materia proteide dell’immaginazione più incontrollata e riportare quest’immagine nella nostra realtà apparentemente immobile.
Immaginare la fine del mondo è più facile che immaginare quella del Capitalismo, dice Fredric Jameson e allora perché non oltrepassare il tentativo fallace di immaginare scenari futuri attingendo direttamente a una forza ricombinatoria più profonda, quella onirica?
Entrambe le vicende seguite non sono mai quelle di un unico personaggio; il potere rimane miope, morente e disfunzionale, frutto di una nevrosi mai trattata; la vecchiaia cede in sacrificio la propria linfa alla gioventù in un succedersi da sottobosco vegetale; le forze dell’ordine sono un macchinario di repressione confusa e violenta; il genere stesso della narrazione varia a seconda delle necessità, nel poliziesco, mistery, poi formazione, individuale e collettiva.
È nella natura umana razionalizzare elementi caotici per ricavarne uno schema comprensibile e ripetitivo. La connessione tra lə due autorə, d’altra parte, è tutt’altro che infondata. Vaccari e Vallorani si presentano a vicenda almeno dal 2019 e al momento Vaccari cura la collana di novelle di Zona 42, che ha pubblicato Noi siamo campo di battaglia. L’ipotesi di un dialogo tra lə due è quasi ovvia.
Nonostante ciò, leggere le due opere da l’impressione di veder percorrere lo stesso sentiero con un passo diverso.
Nella storia di Urla sempre sono sempre le ingangreniture dellə singolə a deviare il corso delle vicende: la rivoluzione fallita di Spartaco, il canto di speranza di Zelinda, l’astio mortifero del Venerato Presidente, la rinascita onirica guidata da Egle. La collettività viene privata della propria agency sotto il peso del passo dei Grandi. La lotta di classe espressa dal romanzo nasce e si risolve nella lotta. Il tempo per costruire e crescere verrà tra le macerie poi. Lo spazio di Urla sempre è la guerra. Si respira una solitudine infinita. La folla segue la rivoluzione, il susseguirsi delle politiche è una disciplina di tai-chi dove è vittorioso chi meglio canalizza l’energia inerte della massa.
Dall’altro lato il lavoro in ottica di comunitarismo i Vallorani è talmente forte da distorcere la forma della storia in una struttura che potrebbe sembrare errata. Le prime ottanta pagine del romanzo ci presentano individualità ben delineate che non vedremo più all’interno della narrazione, il tutto per renderci complici e partecipi della Comune Compost, una creatura che non può essere definita alveare nonostante si muova con passo solo. I singoli non si dissolvono in un nuovo agente terzo, ma rimangono coscienti di sé stessi, qualcosa di ancora diverso dalla sintesi hegeliana che permea il modo in cui ci rapportiamo alle cose in occidente. Tanto che una volta che ci sono stati dati gli strumenti per capire la Comune, essa scompare e diventa il punto di vista del romanzo, l’occhio frattale che osserva coloro che sono rimasti indietro. La rivoluzione di Vallorani è fatta di superorganismi comunitari che esistono nelle proprie differenze.
Dove Vaccari è saldo in un ideale più novecentesco, Vallorani si nutre di tutta una teoria transfemminista della molteplicità e questo dona una ricchezza differente alle opere. La lotta di Vaccari è sanguigna, fatta di tessuti divelti e sangue che schizza. Vallorani ci mostra una rivoluzione che si infiltra nelle fessure lasciate indietro dall’autoritarismo, che nella sua rigidità non può che infrangersi di fronte all’infinita mutevolezza del reale.
Nonostante però pongano i propri elementi di poetica saldamente nella materia (Vaccari nei fluidi e nella tensione muscolare, Vallorani nella crescita lenta e inesorabile del suolo), in entrambe le narrazioni la realtà in senso stretto sembra aver esaurito la propria forza creatrice. Non sta necessariamente morendo il mondo, ma sta morendo il nostro.
Vaccari pone l’orizzonte degli eventi in un’eutanasia programmata dalla Venerata Gerusia, mentre Vallorani ci pone di fronte a un ritorno della biologia ottocentesca, con i suoi miasmi mortiferi che risalgono da una madre terra che quindi va cementificata. La simbologia di entrambi rimanda a un fallimento della razionalità illuminista, il primo nella sua deriva realpolitik economica dove i giovani in quanto improduttivi vanno fatti sparire e l’altra in una disistima della scienza medica convenzionale, come espressione di interessi sommersi e miopi.
Entrambi, quindi, fallita la razionalità, di fronte a un reale reso sterile da un’azione incapace di programmi di lungo periodo, si rivolgono al sogno. Sono passati 50 anni dal Lathe di Le Guin. Nel 2020 non ci sono grandi sogni da un po’. Una crisi dopo l’altra siamo stati guidati in pascoli perennemente emergenziali dove immaginare è una perdita di tempo. Il sistema scolastico ricodifica le humanities solo in termini di competenze lavorative, mentre le discipline tecniche prendono il sopravvento per la propria diretta spendibilità. Il tentativo di costruire qualcosa con un respiro che vada oltre il qui e ora è declassato a ozioso idealismo. Il cambiamento radicale non può essere un’opzione.
Al Capitale non interessano più i sogni che non può vendere adesso.
L’immaginario di fantascienza ricomincia quindi dai terreni non occupati, come una volta erano lo spazio, le stelle, il tempo o gli universi paralleli. In questo caso i sogni e la gioventù.
I giovani ricoprono un ruolo fondamentale in entrambi i romanzi: riformare le generazioni passate è una speranza vana. L’abitudine può più del pericolo di morte. I pochi “vecchi” disposti ad andare avanti potranno solo essere testimoni del nuovo che avanza, ma non parteciparvi. In Urla sempre Spartaco e Zelinda affidano il proprio lascito a Egle, mentre il commissario della terza parte del romanzo rimane a marcire chiedendosi come sarebbe stata la sua vita se non si fosse lasciato mangiare dal sistema. In Il nostro corpo i giovani della Comune attraversano la Breccia che li porterà al sicuro nel maelstrom dei mondi possibili, mentre gli adulti rimangono indietro a mostrare la via ai profughi del collasso. Persino la professoressa che aveva ritrovato la vita nella Comune Compost decide di fare da guardia di porta tra il mondo che muore e il nuovo che nasce.
Allo stesso modo le opere ritraggono un potere inconsistente e vizzo, a cui non è possibile riconoscere nemmeno il valore di un avversario. Il Venerato Presidente (e la Gherusia tutta) esistono solo perché troppo grandi per morire, mentre lə unicə due dirigenti che vediamo nel romanzo di Vallorani sono uno schizofrenico, l’altra affetta da frequenti amnesie. Tutti rimangono completamente ininfluenti per le rispettive trame e questo a suo modo è comunque eloquente.
Il vecchio mondo sta morendo da sé, la lotta del vecchio contro il nuovo è una contingenza figlia dell’incomprensione.
Valutare entrambi i romanzi in termini convenzionali di conflitto e risoluzione (nel caso di Vaccari me ne accorgo tardi, scusa Michè) è un errore, sia interno all’immaginario veicolato dalle due narrative sia nel modo in cui ci ostiniamo a voler strutturare i romanzi.
L’idea dietro a Urla sempre e Il nostro corpo è quella di una guerra monca, dove il punto della rivoluzione non è più tanto piantare una baionetta nel petto dell’avversario, quanto creare un nuovo spazio vivibile, mentre l’avversario, la baionetta, se la pianta più che egregiamente da solo.
La sfida di questo tipo di fantascienza, che è quella del futuro e quindi del nostro presente, è di ricodifica. Sul campo di battaglia non vengono lasciati cadaveri, ma vecchi topoi ingombranti, il peso di una razionalità rigida e disfunzionale che non ci aiuta più. E questo vale per tutto: per come leggiamo le storie, la realtà, per come costruiamo il possibile.
Movimenti femministi di ogni sorta sono almeno trent’anni che fanno un lavoro infame di riappropriazione. Prendono insulti, immagini e narrative e le rendono di nuovo fertili, inutilizzabili da quello stesso sistema che le impiegava per limitare la vita altrui. Vaccari e Vallorani (e sono sicuro molti altri) hanno lavorato per riappropriarsi dalla disillusione del Lathe di Le Guin della forza mitopoietica del sogno, quel territorio fertile da cui storicamente l’umanità ha generato le strutture immaginifiche più forti.
Sarebbe interessante, vista l’evidente sintonia (e dissonanza), vederli lavorare a quattro mani sul tema, creare un grande romanzo sulla rivoluzione del sogno e sogno della rivoluzione, capace di incorporare la fisicità solitaria e muscolare di Vaccari e quella germinante e collettivista di Vallorani, ma convincere gli scrittori a fare le cose è complicato e sicuramente non sarà un articolo a fargli cambiare programmi per i prossimi due anni.
Fortunatamente, nel frattempo, un uomo può sognare.
(Foto)
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

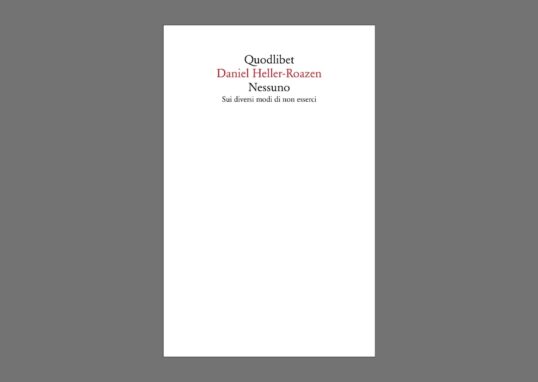





A me il romanzo di Vaccari fa cagare. Presuntuoso come pochi. Puoi lanciare un messaggio importante come nel suo caso, ma devi tenere desta l’attenzione del lettore medio, quello che legge Carofiglio o la Ferrante. Se non lo fai ma ti trinceri dietro lo scrittore onanista che si compiace di svelarsi a pochi eletti, che risultato ottieni? Non vendi una mazza, ti capisce solo il buon Lorenzo Vargas (lui sì, leggibile in ogni suo intervento) e bruci idee interessanti.
La forma è sostanza, almeno in letteratura, caro Matteo. Vaccari si difende bene da solo, ma io invece ne ho i coglioni pieni di chi pensa che bisogna inseguire la mediocrità. C’è già tutto un mondo di banalità letterarie di facile consumo, lasciate che chi ha le capacità si esprima come gli pare e per chi gli pare. Essere presuntuoso è una delle migliori qualità di Michele, perché gli permette di alzare sempre l’asticella, di confrontarsi soprattutto con se stesso. Scrivere bene è la cosa che conta; scrivere bene e in modo largamente accessibile è un previlegio di pochi, acquisito con anni di lunga e estenuante pratica. Vaccari ci arriverà, perché scrive da vent’anni e ne ha poco più di quaranta. Ma il pubblico deve imparare di nuovo a masticare parole, invece di ingurgitare i frullati di luogocomunismo letterario che piacciono tanto al mercato.
Premetto che quanto scrivo è opinione di un lettore duro (4/5 romanzi al mese) e non ha alcuna pretesa di essere scienza esatta. Parto però da alcuni fatti.
– La gente legge poco perché é faticoso
– La gente legge poco perché non ha tempo
– La gente legge poco perché leggere è un’attività da fare da soli e ne ha le palle piene di stare da sola dopo l’isolamento forzato della pandemia
ergo
– I lettori sono pochi
– I lettori che cercano qualcosa che non sia pura evasione pochissimi
– I lettori che non cercano pura evasione e devono stare dietro ai periodi contorti (che non c’entrano con l’imparare a masticare parole e, aggiungo, a usare sintassi corretta) di autori onanisti convinti di essere il verbo della letteratura del ventunesimo secolo sono ancora meno. Andate in libreria, parlate con i librai e su questo punto confermeranno tutti.
Può piacere o non piacere.
Da qui in poi le mie opinioni. Io di fenomeni in giro in Italia non ne vedo.
Parto da una semplice constatazione: si può essere profondi anche nella leggerezza. Si può lanciare un messaggio alto non guardando al solo consumo anche in modo (udite! udite!) da farlo capire a più di tre persone, il numero che temo abbia letto per intero l’ultimo libro di Vaccari, a mio avviso un passo indietro rispetto al discreto “Un marito” (io ho mollato a metà della storia di Spartaco, non so se più annoiato o irritato).
Perché delle tre l’una:
– lo scrittore scrive per se stesso, con citazioni che capisce solo lui (a volte Vaccari è in questa categoria) e allora è meglio che non pubblichi affatto ma tenga il suo manoscritto nel cassetto come si fa con un diario;
– lo scrittore scrive cose difficili con uno stile criptico, involuto, prolisso, inventando punteggiatura e sintassi: verrà letto e idolatrato da quattro gatti e va benissimo a patto che lo stesso scrittore non inveisca contro il lettore bue e perfino contro i suoi colleghi perché non ha i riconoscimenti (anche monetari) che pensa di meritare;
– lo scrittore scrive cose difficili nello stile più comprensibile possibile senza essere sciatto, scegliendo la strada della semplicità per tenersi lontano dall’autoreferenzialità. Sembrerà banale, ma credo che questa sia il modo per trasferire idee al maggior numero di persone possibili, non ci. vedo solo maggior introiti commerciale ma rispetto per il lettore, a cui lo scrittore chiede uno sforzo, non un sacrificio sovrumano.
Le mie sono solo opinioni e ci sta che siano minoritarie o del tutto errate.