Questo testo è l’estratto di un intervento presentato a Trento lo scorso 11 novembre in occasione del Simposio Internazionale Pro e contro la trama e pubblicato nel numero 8 di Alfabeta 2.
La Repubblica.it è un animale con due colonne vertebrali.
La prima, quella che scorre leggermente scoliotica sul lato sinistro dello schermo, si propone come logica, consequenziale e gerarchica. Il mondo e l’Italia prendono forma in una spina dorsale di eventi che procede dall’alto verso il basso in un preciso ordine di gravità e di urgenza. A destra, più regolare nella grafica – un’infilata a piombo di francobolli che ospitano un’immagine – ma priva all’apparenza di un’organizzazione gerarchica evidente, c’è la seconda colonna vertebrale: lo stupidario, la bizzarria, il fatto senza la notizia, lo svuotamento del contesto, il geroglifico ironico-delirante.
Ogni francobollo fa accedere a un breve filmato o a una sequenza fotografica. A dominare è il sensazionalismo: tra i partecipanti alla maratona di New York c’era anche Edison Pena, uno dei minatori cileni rimasti intrappolati nella cava di San Josè; Baby Rasta si calma solo con il reggae; nel Regno Unito la regina Elisabetta è su facebook; Lory Del Santo ha dichiarato: «Mi piacerebbe diventare la first lady di Berlusconi».
Contro gli stupidari non ho nulla, credo anzi che contengano in sé – se accuratamente decontestualizzati e costretti a un detournement – uno straordinario potenziale eversivo e che possano funzionare come una miniera dalla quale ricavare suggestioni. Solo, mi incuriosisce la complicità tra le due macrocategorie informative presenti sulla home di La Repubblica.it. Soprattutto mi interessa riflettere sul bisogno di erotizzazione del mondo, parzialmente soddisfatto attraverso la sua riduzione a notizia, al quale anche Repubblica.it aderisce. Al difetto di erotismo che connota lo sgranarsi di eventi sulla colonna di sinistra risponde la sessualizzazione – esplicita o cifrata, anarchica e dionisiaca – portata dalla colonna di destra. L’attenzione e il pensiero, costretti a sinistra a una specie di disinfezione erotica, recuperano a destra una dimensione felicemente libertina. È evidente che la fusione, la con-fusione, in atto in Italia tra il politico “disinfettato” – il vecchio modello democristiano che faceva coincidere corpo politico e offertorio – e il politico “erotico” o meglio “pornografico” (un clamoroso ritorno del rimosso) porta ulteriormente avanti questo processo. Ed è altrettanto evidente che in tutto ciò il corpo di Berlusconi è la figura del collasso, il punto di fusione. Berlusconi è la temperatura alla quale l’Italia – il solido amorfo nel quale viviamo, il paese di vetro – fonde.
Queste due colonne vertebrali, che nella grafica della home page di La Repubblica.it si allungano separate e parallele, a un livello sostanziale, al livello cioè della struttura simbolica e politica di questo sito, sono intrecciate, profondamente avvinte, elicoidali: il codice genetico di un’idea di comunicazione e al contempo la descrizione nuda e spietata dell’identità di una parte consistente della sinistra italiana.
La Repubblica.it non idealizza i propri utenti. Semmai li fidelizza. Ha dunque scelto di conoscerli, di metterli a fuoco, e si è resa conto che proporre esclusivamente un’informazione regolata su un codice giornalistico di tradizione anglosassone non è funzionale; se accanto a una colonna di sinistra informativa non si prevede anche la presenza del joker, del fool che ghigna e irride, il discorso risulta insufficiente e l’attenzione – ma ancor più la fidelizzazione – declina. La Repubblica.it sa che il suo utente – ma forse più esatto sarebbe parlare di spettatore – desidera informazione ma al contempo ha bisogno di dipendenza, e sa che gli spot emotivi sintetizzati nei francobolli della colonna divertissement – di fatto vere e proprie percezioni del vuoto, legami erotici inconseguenti, inabissamenti scherzosi in un amnios senza forma e senza fine – sono in grado di generare dipendenza. Soprattutto, questi spot-francobolli sono funzionali a una continua strategica interferenza.
Buona parte della trama del presente si fonda su meccanismi che se a una prima analisi possono apparire aberranti si rivelano poi, a uno sguardo più attento, paradossalmente adeguati all’adattamento a un ecosistema mutato. Il nostro corpo, la nostra storia, si muove su uno sfondo organizzato nella forma del brusio. Per muoverci da A a B, fisicamente o psicologicamente, dobbiamo appunto attraversare il cosiddetto “rumore di fondo”. Quando il nostro movimento si confronta con la rete è come se, cronenberghianamente, immergessimo le nostre teste nell’oceano al contempo superficiale e profondissimo dei pixel, nel nido di vespe dal quale si leva un ronzio semiassordante.
Il combattimento continuo con il rumore di fondo – il tentativo di andare avanti verso la propria meta, di restarne consapevoli, di mantenerne in vita la percezione e il senso, seppure transitorio – è la cifra di quello che ci accade. Ma il rumore di fondo è centripeto, esigente, pretende di attrarre tutto a sé, vuole assorbire la figura e trasformarla in materia dello sfondo. Dunque, sapendo di poter contare sulla nostra complicità, ci costringe a un dialogo fitto e reiterato con una moltiplicazione di nodi tanto fosforescenti nel momento in cui ci attraggono quanto evanescenti quando, esaurita la loro funzione, ci ritroviamo dentro una pagina internet senza ricordarci come ci siamo arrivati e senza ricordarci che cosa, in origine, eravamo andati a cercare.
Se la colonna di sinistra di La Repubblica.it, per quella che è la sua natura statutaria, presume di descrivere il mondo, quella di destra corrisponde al modo in cui il mondo ha bisogno di sabotarsi. Di invalidarsi. La distrazione – il procrastinare, il vagare, l’introiezione del nido di vespe che dall’esterno slitta al nostro interno e coincide con il contenuto della nostra testa – serve a dare concretezza a un inconsapevole progetto di dismissione della nostra memoria a breve termine e alla sua sostituzione con un morbidissimo buco nero. Gli spot microemozionali della colonna di destra di La Repubblica.it sono, come detto, percezioni del vuoto; il nostro sguardo si nutre di vuoto, di smaterializzazione: minuti ore e secoli dopo (non sappiamo più dopo che cosa) ci ritroviamo a osservare il monitor e tutto lo spazio intorno semiconsapevoli di essere immersi in un transito di senso.
Ma mentre tutto ciò che è spam è in azione, la colonna di sinistra non smette di funzionare e, anche tramite l’induzione di un senso di colpa, ci domanda attenzione. A quel punto si definisce la nostra naturale schizofrenia. Perché mentre il nostro sguardo – questo fierissimo Ulisse della conoscenza – muove verso sinistra in cerca della notizia, le sirene conficcate nei quadratini alla nostra destra lo irretiscono cantando se non addirittura strepitando per farsi ascoltare; ne discende un tragicomico strabismo divergente nel quale si concentra una piccola apocalisse, la rivelazione della nostra attuale consistenza: la partecipazione – anche nella sua manifestazione preliminare di ricerca di informazione – è una prassi ibridata e contraddittoria. Ed è inesorabilmente consumo.
La Repubblica.it ha compreso che il suo spettatore deve consumare mondo, deve consumare Italia: il suo spettatore è un piccolo cannibale che seduto mite davanti al proprio computer trascorre il tempo rosicchiando Berlusconi, Bossi, Bersani e Ruby Rubacuori, Lele Mora e Rosy Bindi. Ma la dieta ideale prevede anche l’assunzione di nuclei ipercalorici: Franco Califano chiede la legge Bacchelli: «Adesso sono povero»; Kirsten Dunst si arrende: anche per lei ciak in topless.
Al perfezionamento ultimo di questa dieta politico-alimentare sta provvedendo la metamorfosi in atto rendendo indistinguibili – in termini di forma e contenuto – lo specifico nutrizionale delle due colonne. La soglia che formalmente le separava è quasi del tutto cancellata e imperversa un crossing-over prepotente di strutture e sostanze, un’emulsione che polverizza differenze e gerarchie. Al di là dei nomi propri ci sembra del tutto naturale trovare quanto riguarda Fabrizio Corona nella colonna di sinistra e quanto riguarda Silvio Berlusconi nella colonna di destra (sapendo che già adesso, e da tempo, una biografia contiene in filigrana l’altra).
E qui ritornerebbe quanto detto a proposito di Berlusconi come punto di con-fusione: Berlusconi è la trama elicoidale del nostro presente, la sintesi delle contraddizioni, il luogo della coesistenza degli opposti, non l’attore in scena bensì il teatro intero, la più potente estroflessione del bisogno pubblico – ormai famelico – di un privato “tramato”.
Nel momento in cui il confine formale tra le due colonne si dissolve ci ritroviamo nelle condizioni di Psiche che nel racconto di Apuleio deve confrontarsi con un enorme mucchio di granaglie nel quale sono mescolati semi di miglio frumento orzo papaveri ceci e lenticchie. Ogni grano va distinto dall’altro e i semi vanno radunati in mucchi omogenei. Diversamente da Psiche, costretta suo malgrado a discernere per passare dal caos al cosmo, noi affrontiamo il caos come strutturale e fisiologico; talmente naturale che nessun trauma viene a visitarci: il mucchio delle granaglie – un altro modo nel quale il mondo ci domanda di essere, insieme a lui, rumore di fondo – tutt’altro che generare una sfida ha la capacità di assolverci. Di fronte a un’azione impossibile, un’azione diabolicamente adulta, veniamo confortati nel nostro bisogno di essere eternamente – ed estremisticamente – figli. E del resto, mentre osserviamo il magma di semi – semi che invertono il proprio connotato elettivo e si fanno forma della sterilità – sappiamo che nessuna formica, diversamente da quanto accade a Psiche, verrà in nostro soccorso. Meglio allora restare fermi e aspettare, contemplare questo oceano di pixel vegetali, ma mai e poi mai cominciare.
La home page di La Repubblica.it mi propone un racconto del mondo direttamente connesso all’idea di cambiamento. Fino a quando l’unico strumento in grado di informarci erano i giornali cartacei, il mondo cambiava una sola volta al giorno (quando leggendo i giornali – durante l’hegeliana mattutina preghiera dell’uomo moderno – prendevamo atto dei mutamenti); radio e televisione hanno modificato la frequenza di “approvigionamento” di informazioni permettendoci di ascoltare e guardare notizie con una cadenza ben precisa e regolata (tanto che le rare edizioni straordinarie facevano irruzione come eccezione, dunque come trauma, aritmia, un’accelerazione violenta nell’ordinata tramatura del tempo); l’avvento della rete, nel consentirci una cronaca in diretta del mondo, ci ha indotto a pensare che il mondo sia una cosa in continuo aggiornamento, una ragnatela di eventi dalla quale ricaviamo un’illusione di densità. Il fatto poi che in rete io non debba limitarmi ad aspettare un aggiornamento esterno ma possa intervenire attivamente stimolando una zona sensibile del monitor in grado di mostrarmi, di riflesso, un mutamento, genera quella perfetta allucinazione a partire dalla quale, persuasi di essere in grado di convocare il mondo, riteniamo di riguadagnare un fantasma di soggettività storica.
E dunque: sto sulla home page di La Repubblica.it, clicco su aggiorna, sulla colonna di sinistra compare una notizia che un istante prima non c’era o evolve una notizia già presente e io sento il mondo respirare, ne intercetto il battito cardiaco, mi installo tra sistole e diastole: di fatto vedo il tempo mutare; dunque penso di essere nel divenire che modifica le cose, dentro quella particolarissima eccitazione: la mia soggettività – storica e politica – si incunea nel mondo, dà del tu al mondo e dal mondo è ricambiata.
Se però faccio tre passi indietro e sollevo lo sguardo riconosco di colpo il mondo minerale e immoto, il tempo duro e inscalfibile, indifferente, e mi rendo conto che è solo il vago pulviscolo di pixel che lo circonda – questa cenere bianca elettrica in sospensione che poco a poco si deposita – a darmi la sensazione che esista un movimento.
Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente (Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera (2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia. Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival, nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet 2016).






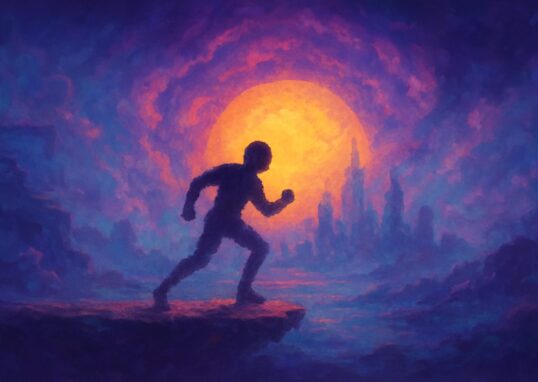

Giorgio Vasta è un genio.
E io sono felice di abitare nel suo Paese e nella sua epoca storica.
Tutto qui.
Concordo con Antonio. Dipendo da Giorgio Vasta come dalla colonna di destra di repubblica.it nella quale oggi mi son perso a causa del matrimonio william&kate. Giorgio, convincili tu gli italiani che tutti, e non solo quelli di destra, siamo patologici (ecco, magari evitando giusto giusto l’avverbio cronenberghianamente)
Molto bello, ottimo finale sul tema del mutamento e chiusa zenoniano-parmenidea eccellente
Una cruda visione della nuova babele mediatica .dove coesistono senza più profonde contraddizioni ,il nostro ,vedere ed essere visti,informare e
essere informati ,in un gioco nuovo per di più interattivo ,in un mondo liquefatto e ibrido e amorale,orfano di una conoscenza , che dispone di un’informazione che si è liberata dal vincolo di eticità ,in attesa di una nuova rilettura.
Ciò che non dovrebbe comunque mai mancare è il buon gusto.
il testo é scritto cosí bene che é un vero piacere leggerlo. ma non é una novitá!
Tuttavia non sono d´accordo completamente. Tenteró di esprimermi con le mie modeste possibilitá. La questione della colonna di destra é la questione meno grave in relazione al mondo dell´informazione. Ci sono altre questioni ben piú spinose e complesse. Non sono, comunque, la persona competente per parlare di questo. Tornando alla colonna di destra. Siamo noi quella colonna. un giornale o una rivista pubblicano informazioni simili perché noi le leggiamo. la scelta di fregarsene e non leggerle é molto piú importante di quanto si possa pensare. bisognerebbe cominciare a prendere decisioni simili. é necessario scegliere. scegliere sapendo che un click fa “ascolto”, ovunque, non solo in Italia. Di “colonne di destra”, o chi per loro, é pieno il mondo, come sappiamo. Se una redazione decide di dare spazio ad un servizio sul döner invece che ad un servizio sulla musica turca é perché sa che pochi seguirebbero quello sulla musica. Quei tanti o pochi siamo noi. possiamo decidere cosa vogliamo fare del mondo dell´informazione e della cultura. Credo che sia tempo di cominciare a scegliere.
Bravo… se tutti gli articoli che leggo fossero di questo livello…
è così rassicurante leggere questi articoli, è come avere un fratello maggiore che metabolizza il mondo.
Grazie a vasta. sono 3 anni che leggo repubblica on line e penso esattamente le stesse cose senza saperle scrivere come lui ovviamente. una cos aaggiungerei però staccandomi dalla semiotica e tornando alla storia e all’economia. non conosco il funzionemento delle redazioni on line ma so che si fa ricorso sia nella carta stammpata che on line ai service e che l’automazione in rete delle attività di news mastering mettono lo zampino tecnologico in questa omologazione. la colonna destra del corriere.it è infatti q
pressocchè speculare a quella di repubblica.it