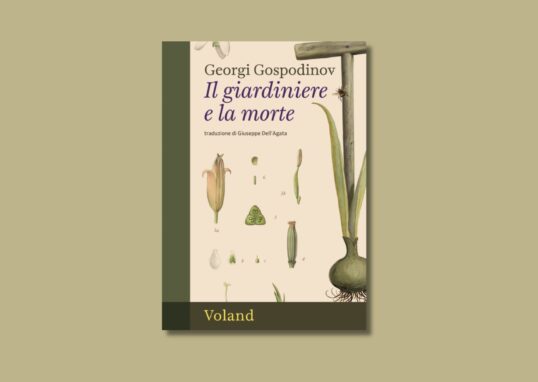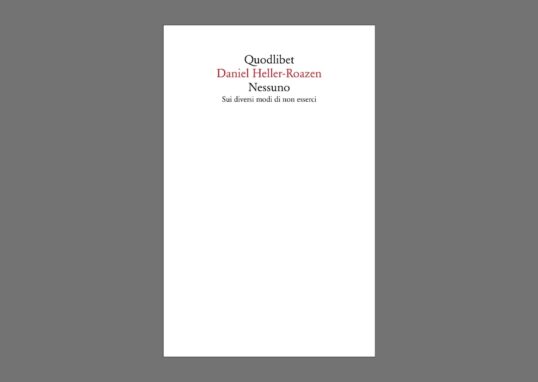In un editoriale che il Corriere della Sera ha ritenuto di pubblicare in prima pagina, Ernesto Galli della Loggia alcuni giorni fa, preoccupato dai consueti allarmanti dati annuali sulla percentuale degli italiani che leggono, proponeva “un vero e proprio Piano Nazionale per la Lettura”. “Il principale obiettivo dovrebbe essere”, suggeriva, “quello di togliere i libri dall’arca santa delle librerie”; lo stato dovrebbe piuttosto acquistare volumi in grandi quantità e metterli gratuitamente a disposizione della popolazione, “sistemandone qualche decina qua e là nei luoghi più diversi”.
Se l’efficacia di una siffatta iniziativa sembra piuttosto dubbia per quanto riguarda il raggiungimento del suo obiettivo, vale a dire avvicinare alla lettura più italiani, appaiono sicuri e micidiali i suoi effetti collaterali: accelerare la chiusura delle poche librerie rimaste; indebolire la funzione delle biblioteche; svalutare ulteriormente il prodotto libro, che già adesso non è esattamente il più appetibile in circolazione. Appetibile va inteso qui nel senso di desiderabile, e fino al punto di dedicargli il bene più prezioso in assoluto, che come molti sanno non è il denaro, bensì il tempo. Già, perché si giocano sempre più partite di calcio e di tennis, e sono sempre di più le serie televisive prodotte da Netflix, Apple, Disney e Amazon, e sono in aumento anche i videogiochi pubblicati ogni settimana, e sono praticamente infiniti i contenuti con cui gli algoritmi di YouTube, Instagram e TikTok possono popolare i nostri feed, mentre sono sempre 24 le ore a disposizione di noi tutti, ancora meno quelle classificabili come “tempo libero”; e in questa lotta per l’attenzione, i libri perdono terreno. Resta da capirne la ragione.
Si potrebbe partire alla ricerca di una risposta dalle pagine dei quotidiani, e ancora meglio dai loro inserti e supplementi culturali: La Lettura, Robinson, Tuttolibri, Alias e compagnia. Quante volte si ricava l’impressione che chi scrive non lo faccia solamente in rappresentanza di se stesso? Mai. Si tratta d’un problema ricco di conseguenze: ad esempio, non ci sono più stroncature. Questo tema torna ciclicamente, arriva sempre qualcuno a ricordare che belle erano e quanto ci mancano, sia loro, le stroncature, sia i bersagli, da Bassani a Montale a Svevo, per non parlar poi dei tiratori. D’altra parte, nelle condizioni in cui versa l’editoria, come potrebbe una stroncatura non essere scambiata oggi per maleducazione, per mancanza di tatto? Conseguenza ben più grave: quante volte chi scrive è non solo perfettamente in grado di padroneggiare la materia, di inquadrare i temi e i problemi e il contesto, ma appare pure coinvolto? Ancora una volta: mai. Così anche l’altra faccia della stroncatura, e cioè una lode che abbia l’aria di sorgere da un reale entusiasmo, e non d’essere soltanto parte di un generale placido consenso concesso a qualsiasi proposta editoriale, viene meno. La causa di tutto ciò è una sola: chi critica non lo fa più sulle basi dell’adesione a una scuola, a una corrente, a una filosofia, a un’estetica, a un gruppo, a un’avanguardia.
Leggere oggi “Teoria della prosa” di Viktor Šklovskij, recentemente riproposto in libreria da Quodlibet nella storica traduzione a cura di Cesare de Michelis e Renzo Oliva, fa un certo effetto. Trascurando del tutto la sua qualità, perché un saggio di critica letteraria apparso per la prima volta cent’anni fa, nel 1925, non si ristampa se non è un classico, vale la pena, e l’autore in quanto formalista sicuramente avrebbe apprezzato, concentrarsi sulla maniera in cui è scritto. Un’idea di rapporto col pubblico: “Tirerò adesso un po’ di somme, anche se non amo farlo, perché dev’essere il lettore a trarre le sue conclusioni” (nel capitolo dedicato al Don Chisciotte, a pagina 141 di questa edizione). Un meraviglioso esempio di sincerità, di falsa autocensura e di cedimento al filo dei propri pensieri: “Ma è fuori luogo scrivere di Dostoevskij in un’annotazione in margine ad un saggio su Conan Doyle” (nel capitolo sulla novella dei misteri, pagina 185). Una prescrizione per gli scrittori del proprio paese: “Chiunque intenda cimentarsi nella creazione di una letteratura russa d’intreccio deve prestare attenzione all’uso che Conan Doyle fa degli accenni” (in conclusione dello stesso capitolo, pagina 194). Sulle condizioni materiali del proprio lavoro: “Io potrei mostrare meglio questa situazione trascrivendo una ventina di pagine del romanzo. Ma mi trattiene il costo della carta” (nel capitolo sul romanzo dei misteri, pagina 210). Un approccio simile, che suona più fresco e più attuale rispetto a tanta critica odierna, è lo specchio e l’effetto di un ambiente letterario vivo, in cui è noto, per così dire, chi si ha di fronte, chi accanto e chi alle spalle.
Di questi tempi, invece, non sembrano esserci tanti critici disposti a esaltare o distruggere un’opera in maniera finalmente partigiana, sanamente pregiudiziale, sulle basi cioè di una visione del mondo e della letteratura che ritengono di condividere o di dover rigettare; né sembrano esserci tanti scrittori intenzionati ad associarsi intorno a uno stile, a dargli un nome, magari anche un manifesto, e poi a svilupparlo e difenderlo in punta di penna. Del resto l’apparizione di un nuovo (e spesso impercettibile) movimento è in pratica un evento generazionale: il cannibalismo (1996), il new italian epic (2008) e il novo sconcertante italico (2023) sono venuti alla luce in un ecosistema inospitale e desolato. È già tanto che si siano presi la briga di esistere, figuriamoci entrare in collisione, fare scintille, movimentare la scena. L’italiano che non legge per dovere, perché non si beve nessuna melensa retorica tipo quella del nutrimento per l’anima, e non legge neanche per piacere, perché non ha ancora sentito il desiderio e l’urgenza di dedicare il proprio tempo a questa attività, a cosa dovrebbe appassionarsi? Quali dibattiti o polemiche o discorsi relativi al mondo letterario possono intercettare la sua attenzione e fargli venire voglia d’interessarsi, di farsi un’idea, di prendere parte? Nella totale piattezza del panorama attuale le case editrici son costrette a vivacchiare in attesa del premio o del caso letterario, ma è rassicurante sapere se non altro che il problema è in teoria di facile soluzione, perché riguarda il loro pane quotidiano: ciò che manca all’editoria oggi è una narrazione.
Gilles Nicoli è nato a Roma sette giorni prima che Julio Cortázar morisse a Parigi. Scrive soprattutto di libri, cinema e videogiochi.