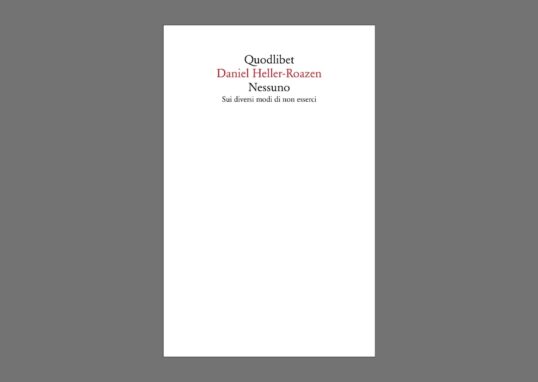In bilico sul filo della storia, in balia delle sue vette splendenti e dei suoi oscuri pendii, camminando a piedi nudi sulla grandezza per centinaia di metri. Il volume di immagini e memorie, pubblicato di recente da Ets per la Società Italiana dei Viaggiatori, raccoglie I primi vent’anni del Festival del Viaggio e palesa in copertina il funambolo Andrea Loreni in marsina, sospeso a quarantadue metri d’altezza sopra Piazza della Signoria. La fotografia scattata da Walter Moretti è stata la locandina della quinta edizione della manifestazione toscana, la prima a Firenze, nel 2010. Lordi usciva da Palazzo Uguccioni, affidandosi soltanto a un cavo senza reti protettive, alla clemenza dei refoli di vento e alla lieve pendenza per salire sino al terrazzo di Palazzo Vecchio. Un’attraversata inconcepibile che trattiene tutte le sfumature semantiche del viaggio in un unico scatto: la fatica fisica e mentale imposta da ogni scoperta, da ogni cambio di prospettiva, cessa oltre i limiti del singolo e trascende verso l’alto. Non a caso, l’entrata dell’acrobata temerario fu proprio a Palazzo Vecchio, il cuore del genio fiorentino che ha dato vita al Rinascimento e al magnifico mecenatismo di Lorenzo.
Primo in Italia nel suo genere, il Festival del Viaggio fu fondato a Pisa, nel 2006, per poi spostarsi in altre città, tra cui appunto Firenze, Palermo, Venezia, Viareggio e Milano. Da qualche anno il festival è tornato ad affacciarsi sul Lungarno, dentro l’antico Palazzo Blu. E per festeggiare il ventennale, il palinsesto di fine settembre è stato interamente dedicato alla musica con Sergio Caputo, Rita Marcotulli, Bobo Rondelli, Federico Maria Sardelli, Tommaso Novi, Fabio Morgera e altri, con esibizioni che hanno alternato l’ascolto intimo a esplosioni ritmiche. Una densità palpabile ha avuto il raccoglimento intorno al racconto jazz di Marcotulli e al suo pianoforte; il genere in questione scaturiva dirompente in un momento storico di rottura degli schemi per la società americana. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la volontà di protestare contro la segregazione e il razzismo subiti dalle comunità afroamericane, contro un ordine costituto che ne limitava i diritti civili basilari, sostentava quell’improvvisazione espressiva capace di abbattere lineamenti e confini, pregiudizi e sovrastrutture, così l’Alabama di John Coltrane, il free jazz e il suo emanciparsi dai toni della tradizione bianca.
Musica Mondo
«Quando un artista comincia a comporre improvvisa a monte – spiega Marcotulli – ma nel frangente in cui scrive la melodia e la fissa al pentagramma, ripete e reinterpreta una sequenza preesistente. Il processo creativo necessita costantemente di nuove derive, per quanto l’improvvisazione non si possa improvvisare, essendo indispensabile la conoscenza radicata delle strutture e degli schemi armonici. Improvvisare, inoltre, prevede un ascolto costante e reciproco tra musicisti, che si dimostra fondamentale per comunicare e condividere linguaggi diversi provenienti da culture diverse». Coltrane sarà sempre Coltrane, mentre la sua imitazione resterà sempre tale: «Nel jazz non si copia, non avrebbe senso, ma è frequente e fecondo rubare spunti dagli altri sul palco come fonte di ispirazione. D’altronde, il fine rimane trasmettere il proprio io, tra immersioni, spasmi e rinunce del proprio vissuto al di là della preparazione tecnica. D’altronde, era Monk a sostenere scettico “what’s technique?” Poiché non esiste maestria formale che possa sostituirsi alle sonorità di un’imperfezione onesta come la sua, e dunque irripetibile». Pianista eclettica e tra le interpreti più sovversive del jazz europeo, Marcotulli si è distinta anche nella composizione di colonne sonore per pellicole e progetti performativi che ha portato con sé, davanti alla platea, lo scorso venerdì 26: «Le cosiddette “tracce” audio sono sostanziali per dare il taglio del regista alle scene cinematografiche, basti pensare all’inflazionata finestra di Hitchcock: se sotto a quel fotogramma incalzasse un ritmo inquietante, dietro lo sguardo dello spettatore, dal buio dei suoi pensieri contriti nell’attesa emergerebbe qualcosa di spaventoso ancora prima che dalla finestra stessa». Sabato 27, invece, alle radici del blues, quando la chitarra di Sandro Joyeux ha incontrato il suono ancestrale delle percussioni di Inoussa Dembele, ottantesima generazione di Griot del Burkina Faso. Con loro Sergio Dileo ha arricchito il suono con fiati, basso e ritmi globali. Bambara Files è un racconto sonoro che attraversa deserti e metropoli, mescolando brani tradizionali del West Africa, composizioni originali e reinterpretazioni di classici africani rivisitati con uno stile essenziale, capace di evocare la trance dei canti Griot e la malinconia del Delta del Mississippi.
Ascoltare Vivaldi senza anacronismi
«Possano queste dita sporche d’inchiostro indicare una corretta esecuzione a chi la cerca con amore e rispetto». È l’immagine manifesto con cui Federico Maria Sardelli conclude Vivaldi secondo Vivaldi. Dentro i suoi manoscritti (Il Saggiatore, 2024), chiamato in causa ripetutamente durante le ultime giornate del Festival. Un saggio concepito per disinnescare i luoghi comuni sul Barocco e per restituire a Vivaldi il suo profilo di compositore minuzioso, non di materia malleabile per i gusti attuali. L’asse sardelliano è pragmatico: far affiorare la voce del violinista veneziano dai suoi autografi e dalle copie coeve in modo da orientare scelte agogiche, dinamiche, articolatorie e di strumentazione con il massimo grado di aderenza storica. «Questo libro è un manuale pratico indirizzato a tutti coloro che si cimentano nell’esecuzione e nello studio della musica di Vivaldi», motiva l’autore in apertura, che da subito mette in guardia il lettore contro gli estremismi opposti: dal “Vivaldi tardoromantico” dei primi del Novecento alle caricature neo-barocche iperveloci, alimentate dal penoso gioco di parole “ba-rock”. L’antidoto è ostico quanto immediato, combinando filologia dei manoscritti (autografi, copie d’officina, parti staccate), storia della prassi esecutiva e una notevole competenza paleografica. Inoltre colpisce il capitolo sugli “usi scrittorî”, in cui Sardelli mette in evidenza correzioni, abrasioni, bolle di ceralacca, fogli incollati, fino ai “pasticci” frettolosi, ricostruendo il banco di lavoro del compositore. Il caso più clamoroso, però, rimane la tassonomia dell’“Allegro”: Vivaldi ne codificò ben ventisei declinazioni, da «Allegro molto più che si può» a «Allegro mà poco poco», costituendo un elenco che equivale a una scala metronomica ante litteram. E dal quale ne discende una correzione salutare di svariate abitudini moderne: i nostri Allegri “nervosi e agitati” non sono la norma, bensì il capriccio di chi esegue lo sparito ignorando il sentire vivaldiano. Infine Sardelli smonta l’idea, novecentesca, di una dinamica barocca a “blocchi” e documenta un raffinato chiaroscuro italiano – tra crescendo, diminuendo e mezze tinte – spesso dato per sottinteso dalla scrittura.
Matteo Bianchi (Ferrara, 1987) si è specializzato in Filologia moderna a Ca’ Foscari sull’opera di Corrado Govoni. In versi ha pubblicato, tra gli altri, La metà del letto (Premio Metauro, Barbera 2015), Fortissimo (Premio Maconi Giovani, Minerva 2019), Christopher (Interlinea, 2025) e la plaquette L’altro imperatore (l’Obliquo, 2024). Di critica, invece, i saggi Il lascito lirico di Corrado Govoni. Dai crepuscoli sul Po agli influssi letterari (Mimesis, 2023) e Contemporaneo. Alessandro Manzoni e la parola in controluce (Oligo, 2024). Giornalista, scrive tra le altre per “Il Sole 24 Ore” e per “Left”. Dirige il Centro Studi “Roberto Pazzi” e il semestrale “Laboratori critici” (Samuele Editore).