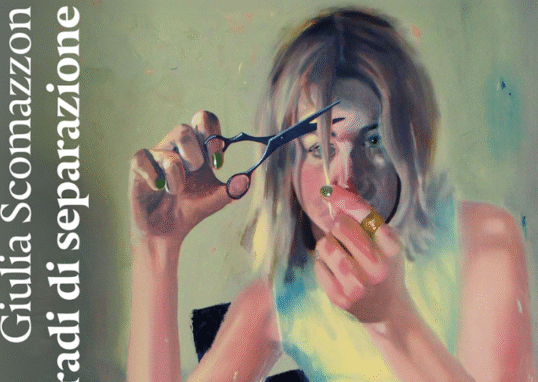Pubblichiamo la prefazione di Mauro Maraschi a “Per una vita più semplice” di Edward Carpenter, pubblicato da Piano B e a cura dello stesso Maraschi.
*
di Mauro Maraschi
Edward Carpenter è stato una figura fondamentale nel panorama culturale dell’Inghilterra tra il XIX e il XX secolo. Considerato da alcuni il “Thoreau britannico”, al pari del filosofo di Concord fu un personaggio sfaccettato quanto tenace. Conferenziere, riformatore, apertamente omosessuale e pioniere della lotta per i diritti lgbt, sostenitore del suffragio femminile e oppositore della violenza sugli animali, nonché vegetariano, per quarant’anni Carpenter non smise mai di promuovere – con i suoi scritti e dando l’esempio attraverso la gestione di una piccola fattoria – gli ideali di una vita «semplificata» e di una società più giusta, sempre in dialogo con le grandi menti dell’epoca ma anche a stretto contatto con la gente del popolo, i lavoratori manuali, che per lui erano «il cuore pulsante» e la «spina dorsale» di una nazione. Fu amico di Rabindranath Tagore e di Walt Whitman, di Henry S. Salt (autore di una fondamentale biografia di Thoreau) e dello scrittore E. M. Forster, che si ispirò alla sua longeva relazione per quello che può essere considerato il primo romanzo moderno a tema omosessuale, Maurice (1914, pubblicato postumo nel 1971). Ebbe scambi epistolari con Gandhi, Jack London e John Ruskin. Tolstoj, al quale veniva paragonato, lo definì «un degno erede di Carlyle e Ruskin». E Aldous Huxley ne consigliò il pamphlet Civilization: Its Cause and Cure nel suo Scienza, libertà e pace. Saggio sulla grazia.
Riconosciuto per decenni come un pensatore coraggioso e persuasivo, al termine della sua lunga esistenza Carpenter era ormai più che famoso. Eppure, subito dopo la morte, la sua eterogenea produzione intellettuale fu presto accantonata e, nonostante il recupero negli anni Settanta, oggi in pochi lo conoscono, sia in Italia che altrove. Si può sostenere con forza che questo oblio non sia legato alla qualità e all’importanza della sua produzione (o di una parte di essa), qualità e importanza di per sé evidenti e rintracciabili da chiunque. Ma allora com’è possibile che a un autore acclamato spetti un tale destino? La risposta è complessa e stratificata, e per comprenderla, come sempre in questi casi, può rivelarsi proficuo un excursus sulla sua parabola personale e intellettuale.
Edward Carpenter nacque a Brighton il 29 agosto 1844 in una famiglia benestante, terzo figlio di Charles e Sophia. Fin da subito incline alla musica, a dieci anni dimostrò una notevole predisposizione per il pianoforte. Già ai tempi dell’università prese atto della propria omosessualità grazie all’amicizia con Edward Anthony Beck, poi troncata con non poca afflizione. Terminati gli studi, nel 1868, prese i voti «più per convenzione che per convinzione». Nel 1871 rifiutò l’invito a diventare il tutore del principe George Frederick (in seguito re Giorgio V). Nei tre anni successivi provò una crescente insofferenza nei confronti della propria vita e dell’ipocrisia della società vittoriana, finché nel 1874 non appese al chiodo l’abito talare, rinunciò ai privilegi di estrazione e si trasferì a Leeds, dove si mantenne tenendo conferenze e insegnando astronomia, storia e musica all’università. Quest’ultima esperienza fu una delusione: Carpenter sperava di poter istruire i giovani delle classi lavoratrici, e invece si rese conto che i suoi alunni, oltre a dimostrare scarso interesse per i suoi argomenti, provenivano tutti da famiglie facoltose. Insoddisfatto su tutti i versanti, trovava conforto soltanto nella lettura di Walt Whitman, da cui trasse l’energia per un «profondo cambiamento», a tal punto che nel 1877 decise di recarsi a Camden, nel New Jersey, per far visita al poeta americano. Al suo ritorno in Inghilterra iniziò anch’egli a dedicarsi alla poesia. Trasferitosi a Sheffield, prese l’abitudine di interagire con braccianti, manovali e, in generale, con chiunque si sporcasse le mani per lavorare. Nel 1883 pubblicò la prima parte di Verso la democrazia, saggio in versi, ispirato a Foglie d’erba e animato dal Bhagavad Gita, nel quale argomentava l’ideale di una società più libera e giusta.
La sua vita subì una svolta alla morte del padre, nel 1882, quando, grazie a un’eredità di oltre 6.000 sterline, Carpenter poté interrompere l’attività di conferenziere, acquistare una fattoria a Millthorpe, nel Derbyshire, e concentrarsi sulla scrittura. Fu soltanto allora, a trentotto anni, che cominciò a vivere più apertamente la propria omosessualità, prima in una relazione con il fabbro George Hukin e poi insieme al riformista Cecil Reddie, affiancando quest’ultimo nella sua scuola progressista. Influenzato da Henry Hyndman, discepolo di Engels, divenne di idee sempre più radicali e prese parte alla neonata Socialist League. Affascinato dalla cultura induista, nel 1890 visitò l’India e l’isola di Sri Lanka (ai tempi Ceylon) e, dopo l’incontro con il guru Gnani Ramaswamy, si convinse che il socialismo avrebbe potuto rivoluzionare la coscienza collettiva ma anche l’impianto economico di una nazione.
Fu al ritorno da questi viaggi, nel 1891, che Carpenter conobbe l’uomo che gli sarebbe stato al fianco fino alla fine dei suoi giorni, e quindi per quasi quarant’anni. George Merrill era indigente e ineducato: figlio di un macchinista, era cresciuto nei sobborghi di Sheffield e della vita conosceva soltanto le competenze operaie. La distanza anagrafica era significativa: quarantasette anni Carpenter, venticinque Merrill. Eppure, a due anni dal loro incontro, Merrill smise di essere uno dei tanti frequentatori di Carpenter e ne divenne il partner fisso, anche se si trasferì a Millthorpe soltanto nel 1898. Sulle prime la loro relazione destò clamore: due uomini di classi sociali distanti che coabitavano in quanto coppia dichiarata – tutto ciò era qualcosa di inaudito per i tempi. Scriverà Carpenter ne Il sesso intermedio (1908): «Eros è un grande livellatore. Probabilmente la democrazia si trova, molto più saldamente che in qualsiasi altro luogo, in un sentimento che facilmente supera i limiti di classe e di casta e unisce negli affetti più stretti i livelli più distanti della società». Per almeno vent’anni i due vissero in armonia e nella natura, circondati da amici e corroborati dall’attività intellettuale di Carpenter. Quindi, nel 1922, si trasferirono a Guildford, nel Surrey, dove la propensione di Merrill per l’alcol si trasformò presto in una dipendenza, fino a causargli una morte quasi improvvisa nel gennaio di sei anni dopo. Carpenter, ormai ottantenne, ne fu devastato. Vendette la loro casa e per un po’ soggiornò in affitto, per poi stabilirsi in un bungalow noto come «Inglenook». A maggio dello stesso anno ebbe un infarto invalidante e tredici mesi dopo, il 28 giugno del 1929, morì all’età di ottantaquattro anni. Fu seppellito nella stessa tomba di Merrill, nel cimitero di Guildford, sulla cui lapide fu inciso un epitaffio scritto da lui stesso.
Per tutta la vita Carpenter fu considerato un pensatore brillante, innovatore e sopraffino, degno della stima di tanti tra politicanti e autori. Eppure dopo la morte venne rapidamente accantonato, e con lui i suoi libri, che smisero di essere ristampati. Come già detto, questa sorte non può essere addebitata alla sua opera, che, per quanto controversa nel suo insieme, contiene troppi tasselli preziosi per essere ignorata. Più verosimilmente, Carpenter ha scontato la colpa di aver vissuto liberamente e di aver anteposto, nella seconda fase del suo percorso, alcune cause ad altre, sempre più concentrato sull’amore omoerotico e sulla spiritualità a sfavore di quel socialismo per il quale si era fatto apprezzare, fin dai suoi esordi, con Verso la democrazia (1883). Ma soprattutto, a partire dal trasferimento a Millthorpe insieme a Merrill, e nell’arco dei successivi trent’anni – nei quali avrebbe vissuto della terra, prodotto sandali, elogiato il nudismo e ingaggiato battaglie precorritrici contro l’inquinamento e la vivisezione – complice la sua natura ossimorica di uomo «carismatico e modesto», Carpenter si trasformò suo malgrado in un guru per i tanti giovani che, ogni anno più numerosi, giungevano a fargli visita in una sorta di pellegrinaggio. Con il passare del tempo, assunse pose dandy e new age e, nello stesso periodo in cui Oscar Wilde scontava in carcere la propria condotta, sebbene mai altrettanto ostracizzato dalle autorità, Carpenter cominciò a essere malvisto da quei compagni di partito che ne trovavano sconveniente il personaggio pubblico.
Va chiarito che stili di vita alternativi ed esperimenti comunitari, spesso ispirati dalla fascinazione per la cultura orientale, erano già abbastanza frequenti, nella seconda metà dell’Ottocento, quantomeno tra gli appartenenti a determinate élite culturali: si pensi alla Fruitland di Amos Bronson Alcott, fondata nel 1843 e alla quale Thoreau si rifiutò di aderire, oppure all’esperienza del Monte Verità, che a partire dal 1899 ospitò, tra gli altri, Jung, Hermann Hesse e Kafka. Resta il fatto che lo status di hippy ante litteram procurò a Carpenter anche le antipatie di alcuni intellettuali, una su tutte quella di George Orwell, che non perse mai occasione di screditarlo, e con sorprendente acrimonia, nelle proprie opere e corrispondenze. Orwell però non fu né il primo nell’ultimo: George Bernard Shaw biasimò l’insinuazione di una superiorità delle relazioni omosessuali, mentre lo stesso E.M. Forster, che pure gli era stato amico, definì contraddittorio il misticismo di chi, come lui, voleva «fondersi con il cosmo e mantenere l’identità», riferendosi a certi atteggiamenti bohemien tenuti al cospetto dei suoi ospiti. E così, nel corso di un secolo, nonostante il recupero negli anni Settanta da parte di storici come Jeffrey Weeks e Sheila Rowbotham, la ristampa a opera del «Gay Men’s Press» e la benedizione da parte delle comunità lgbt, Carpenter è sempre rimasto sul crinale di un’ingiusta svalutazione. Il risultato è che oggi viene ricordato “soltanto” come uno dei primi attivisti per i diritti degli omosessuali, una reductio ad iconam che non gli rende giustizia. Dotato di un’ammaliante ars oratoria e di una cultura profonda, Carpenter è stato in grado di infondere un brio orale anche alle argomentazioni su carta. I suoi moniti sono quelli del socialismo utopico, precursore di quello “scientifico”, a differenza del quale confida nel riformismo, piuttosto che nella rivoluzione, come strumento per costruire una società epurata dalle classi sociali e animata dalla fratellanza. Certo, una parte dei suoi ragionamenti può risultare idealista fino alla provocazione (lo era già ai tempi), ma se molti altri passaggi, e in particolare quelli più thoreauviani, sono di un’universalità a tratti disarmante, in generale si ha sempre l’impressione di trovarsi davanti a un autore completo, brillante e originale.
Eppure, come ha osservato la sua biografa Sheila Rowbotham, Carpenter sembra condannato a essere recuperato e rinnegato all’infinito, e sempre mediante le stesse argomentazioni capziose. Forse, se non avesse vissuto così a lungo e il suo percorso si fosse interrotto prematuramente come quello di Thoreau, lasciando ai posteri soltanto la prima parte della sua produzione, Carpenter avrebbe avuto un destino diverso. E questo non perché gli scritti incentrati sull’omoerotismo e sulla cultura orientale possano considerarsi inferiori ai precedenti, ma perché richiedono un’analisi molto più complessa e storicizzata rispetto alla prima produzione. Se infatti circoscriviamo il discorso agli scritti compresi tra il 1883 e il 1889, e in particolare a Per una vita più semplice, che ne è l’apice, ci ritroviamo di fronte a un autore stimolante e sempre accogliente, nella cui prosa e nel cui idealismo i lettori di Thoreau non potranno che sentirsi a casa: lo stile di Carpenter è più semplice, svincolato dalla celebrazione olistica della natura, dalle similitudini criptiche e dall’ascetismo di Thoreau; Carpenter è (o finge di essere), più umile, meno apodittico, per certi versi più pratico; ma proprio per tutti questi motivi leggerlo è un’esperienza vicina a un dialogo vivace e ben ripartito.
Per una vita più semplice, da lui stesso collazionato, raccoglie nove scritti compresi tra il 1883 e il 1887, un periodo nel quale Carpenter era nel pieno della propria esperienza di “ritorno alla terra”. Non era ancora stato in India e non aveva ancora conosciuto quella che sarebbe stata “la persona della sua vita”, per cui il lettore troverà qui un Carpenter non ancora mistico, né oltranzista della causa omosessuale come in The Intermediate Sex (1908). E sarebbe pertanto fuori luogo, in questa sede, cercare di tenere insieme una personalità e una produzione così complesse e multiformi: «Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono vasto, contengo moltitudini!» scriveva Whitman, e ancora una volta le parole del poeta si attagliano all’essenza del nostro Carpenter.
Il primo saggio di questo volume, intitolato Gli ideali di una nazione, si presta bene a manifesto per tutto il libro: dopo aver denunciato le terribili condizioni in cui versa il Paese, Carpenter insiste sull’urgenza di rendere consapevole la classe ricca del sopruso perpetrato a danno delle altre classi, senza mai evocare la lotta di classe ma – al contrario – sognando una riforma basata sulla reciproca comprensione, e chiude rivolgendo un appello alle classi lavoratrici affinché smettano di scambiare la ricchezza altrui per benessere e mirino alla cooperazione per sottrarre la Nazione al tracollo finanziario e morale. Il prestito di denaro e l’origine del profitto ci fa riflettere, con acume ed esempi ficcanti, sulla legittimità e sull’effettiva utilità (per l’investitore, per la società, per l’umanità tutta) delle speculazioni finanziarie e dell’accumulo di denaro che soggiacciono alla base di una realtà capitalistica e di una disuguaglianza quantomeno ridimensionabile; ma soprattutto, il testo ruota intorno a una domanda già cara a Marx e a tanti altri: quante ore di lavoro quotidiane sarebbero davvero necessarie a un individuo per condurre una vita sana e dignitosa se non fosse costretto a regalare parte della propria fatica al capitalista? Progresso sociale e impegno individuale, attraverso due similitudini eccellenti, relativizza l’idea stessa di Progresso e ci insegna che «non cambiare è morire», poiché «una sola forma non è sufficiente a esprimere il segreto della vita»; «L’obiettivo di ogni governo è di rendere accessorio il governo», ci dice Carpenter attraverso Fichte, e le leggi sono nate per servire gli uomini, non viceversa; e ancora: «chiunque senta dentro di sé che può esistere uno standard di vita migliore di quello dominato dalla frenesia del mercato, nonché un equilibrio più ragionevole tra gli stipendi, e una condizione per la quale le cose non meritano d’essere fatte soltanto se rendono bene – egli coltiva, dentro di sé, i semi di un nuovo ordine sociale». Ville da sogno è un intermezzo satirico sugli svantaggi dell’opulenza e sull’ideale ormai desueto della “signorilità”, intesa come eccessivo riguardo per lo status sociale a danno del benessere esistenziale, della comunità e dello spirito di fratellanza. Per una vita più semplice, il pezzo che dà il titolo alla raccolta, è un omaggio esplicito al Walden di Thoreau, la testimonianza dello stesso Carpenter, numeri alla mano, relativa alla sua attività agricola; ma è anche un elenco di ipotesi pratiche (oggi più o meno attuabili, e a tratti provocatorie) per ridurre al minimo i beni materiali e migliorarsi così l’esistenza. Anche Ne vale la pena? prende piede dall’esperienza dell’autore per dimostrare che una condotta migliore è possibile, uno stile di vita che non sia determinato dalla sudditanza agli imperativi dell’economia. Commercio è un altro ottimo esercizio di relativismo: qui Carpenter ci racconta com’è cambiato il suo punto di vista sul mercato dal momento in cui si è ritrovato dall’altra parte del banco, pretesto schietto ed efficace che si fa esemplare di una società corrotta da un interesse economico a dir poco ossessivo. Proprietà privata è una riflessione su cosa significhi davvero possedere qualcosa: «E penso che un cappotto sia proprietà, per un tempo limitato, soltanto di chi lo indossa con purezza di spirito ed è sempre pronto a cederlo a chi ne ha più bisogno». Chiude il volume Il boschetto incantato, un conciso appello ai benestanti affinché prendano atto dei propri errori e optino per un nuovo modello di vita fatto di condivisione, umanità e fratellanza.
A Carpenter si può rimproverare di tutto: un idealismo sfrontato, il desiderio di parlare tanto alle masse quanto ai privilegiati, un piglio bonariamente messianico, o ancora: di essere stato un individuo poco inquadrabile, libero fino al midollo e determinato a spingere il pensiero ai suoi limiti, forse non abbastanza attivo in politica ma talmente coerente a se stesso da apparire, nelle parole della sua biografa, «complicato, confuso e contraddittorio, per quanto coraggioso». Di certo in lui coesistono un amore viscerale per l’umanità e un alto livello di attenzione per se stesso, due afflati che, combinati tra loro e a un’esistenza longeva, hanno generato una produzione scrittoria vastissima e, per forza di cose, non inquadrabile in un’unica corrente. Ma, al di là della difficoltà di antologizzarlo, Carpenter non è soltanto una fonte inesauribile di spunti, ma si candida a diventare un nuovo prezioso amico, così come lo sono da tempo, per migliaia di lettori, un Montaigne o un Thoreau. Ben ritrovato, dunque, Edward Carpenter, con l’augurio che questo sia il primo passo per una definitiva consacrazione.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente