
di Rossella Farnese
Tra le pagine meno note della produzione letteraria di Rainer Maria Rilke (Praga, 4 dicembre 1875 – Montreux, 29 dicembre 1926) vi sono intense riflessioni, stese in forma di appunti, tra il 1898 e il 1919, edite in Italia dall’editore Passigli nella collana Le Occasioni (2006, pp. 85, € 8,50) a cura di Sabrina Mori Carmignani e intitolate Appunti sulla melodia delle cose (Notizen zur Melodie derDinge). Si tratta di una serie di pensieri progressivamente numerati che, nell’indagare le modalità espressive della moderna scena teatrale, danno forma al desiderio di communitas del poeta di Muzot.
In una lettera a Ilse Jahr del dicembre 1922 Rilke affermava: «Il mio mondo comincia con le cose». Ben lungi dalle “cose” che danno il titolo al primo e celebre romanzo (1965) di Georges Perec, le “cose” evocate da Rilke si negano al possesso, sono fuori dal tempo, non hanno voce, sono effimere, vivono sulla vastità dello sfondo, partecipi di un’unica e potente melodia, «quell’unisono festivo e lontano» che i più ‒ «come alberi che hanno dimenticato di avere radici e credono ormai che il frusciare dei rami sia la loro vita […] poveri senza-patria che hanno perduto il senso dell’esistenza […] e suonano sempre lo stesso monotono motivo perduto» ‒ non percepiscono e che solo i grandi solitari di ogni tempo sono in grado di cogliere in istanti di pienezza.
Frammenti che stanno sulla soglia che separa e unisce il visibile e l’invisibile, il silenzio e il suono, in una continua reversibilità tra elemento visivo ed elemento acustico, gli Appunti sulla melodia delle cose ricompongo sulla labile traccia del confine tra pensiero, linguaggio e nuda esistenza, l’antitesi tra primo piano e sfondo, interno ed esterno, rami e radici, individuo e comunità, morte e vita.
Nei suoi Appunti, che si collocano come uno squarcio, come un “la”, «come prima di ogni cosa. Con/ mille e un sogno dietro di noi e /senza azione», come «la prima parola dietro/un punto di sospensione/ lungo interi secoli», Rilke rifiuta la scena materiale del teatro moderno paragonata, con una similitudine tratta dal mondo pittorico, al fondo dorato dei primitivi del Trecento che contrasta con il paesaggio dei maestri rinascimentali. Si legge infatti nelle prime pagine: «Per riconoscere gli uomini fu necessario isolarli. Ma dopo averne fatto lunga esperienza è giusto porre ogni singola contemplazione di nuovo in rapporto con le altre e accompagnare con sguardo ormai maturo i loro più ampi gesti. Confronta per una volta un quadro del Trecento su fondo d’oro con una delle innumerevoli composizioni successive dei primi maestri italiani […] Il fondo d’oro isola ciascuna di loro, il paesaggio invece, splende dietro, come un’unica anima dalla quale essi traggono il sorriso e l’amore». Alla base di questa concezione dell’arte c’è un bisogno di essere comunità, di appartenere a una più vasta dimensione ontologica, di percepire e condividere il canto sommesso che attraversa le cose, lo spazio interiore del mondo (Weltinnenraum), la «melodia della vita intessuta di mille voci» che attraversa i solitari e gli amanti, custodi di quel canto e dei suoi silenzi, per il loro stesso desiderio di «quieta intimità».
Spiega infatti il poeta – con un’immagine quanto mai attuale in tempi di pandemia e distanziamento sociale – che ciascuno di noi vive su un’isola diversa che tuttavia non è abbastanza lontana dalle altre per poter restare in tranquilla solitudine: «uno può disturbare l’altro, terrorizzarlo, perseguitarlo […] nessuno però può aiutare nessuno. Da un’isola all’altra resta solo una possibilità: affrontare il pericolo di un salto in cui si mette a rischio molto più che le gambe. Un perenne ridicolo saltellare avanti e indietro affidato al caso; e accade che due, con un balzo spiccato nello stesso istante, si incontrino a mezz’aria e dopo tanta fatica ricadano, l’uno dall’altro di nuovo lontani». Nell’appunto XXXVII Rilke continua affermando che tutti gli errori e i dissidi degli uomini derivano dal fatto che essi cercano «in se stessi l’unanime concordanza e mai nelle cose che stanno dietro di loro, nella luce, nel paesaggio, nel principio e nella fine. Così facendo perdono se stessi e non ottengono nulla. Si mescolano perché non sono capaci di unirsi»: i ponti non sono infatti «in noi ma dietro di noi […] La nostra pienezza si compie lontano, nello splendore degli sfondi. […] Noi siamo là, mentre qui, in primo piano muoviamo avanti e indietro».
Le annotazioni di Rilke sono quindi da leggere su due piani, quello artistico-teatrale e quello ontologico-esistenziale. È necessario recuperare il «rumore del palcoscenico», inteso come il brusio di una lampada che illumina il sogno di due bambini chini sui loro libi, il ticchettio di un orologio, il gemito dei mobili, la tempesta che imperversa attorno alla casa, un’onda che si infrange, perché soltanto lasciando risuonare la potente melodia dello sfondo, «partecipe delle cose e dei profumi, di sensazioni presenti e ricordanze passare, di tramonti e nostalgie» si entra in relazione ed è questo «canto della vita» che deve trovare spazio sulla scena e, secondo Rilke, lo può trovare solo «introducendo un coro che quieto si dispiega dietro il tremulo scintillare dei dialoghi […] delle parole in primo piano» e attraverso una «rigorosa stilizzazione» perché ha un carattere universale e perché «suonare la melodia dell’infinito sugli stessi tasti su cui posano le dita dell’azione scenica, significa accordare le parole all’immenso e all’assenza stessa di parola».
Negli Appunti sulla melodia delle cose Rilke applica in ambito teatrale le riflessioni sull’arte pittorica, elaborate in un saggio, steso nel medesimo 1898 in occasione di un viaggio a Firenze (che lo porterà a scrivere anche il Diario fiorentino), Sul paesaggio: quel paesaggio che faceva da sfondo negli antichi dipinti unendo le figure entro una medesima atmosfera assume la medesima funzione che la musica e il coro assolvono in Nietzsche, di cui due anni dopo postillerà La nascita della tragedia. In questo saggio Rilke traccia un percorso del rapporto che le epoche successive hanno instaurato con il paesaggio: nella pittura vascolare l’ambiente è appena accennato, un tempo l’oggetto dello sguardo era il corpo, l’uomo stava di fronte al paesaggio e lo nascondeva, in primo piano vi era l’uomo e la natura, cui non si era ancora in grado di guardare come a un tutto, lo adornava. Se nella Monna Lisa il paesaggio è qualcosa di estraneo e di remoto, nei ritratti e negli autoritratti di Böcklin o nella Stampa dei cento fiorini di Rembrandt il paesaggio diventa quello che Frédéric Amiel definisce un «état d’âme», l’uomo perde la sua importanza e la luce diventa amalgama tra le cose: si delinea così quella categoria di corpi-paesaggio centrale in uno scritto dell’estate del medesimo 1898, Intérieurs, dove il poeta legge l’universo teatrale attraverso le categorie di paesaggio e comunanza. La scena è per Rilke un paesaggio con figure e i corpi sono presenze talmente intrise di un’aria comune da fondersi con gli elementi paesaggistici.
Lettore di Kleist e sensibile al teatro simbolista di Maeterlink, Rilke compone inoltre, tra l’autunno 1897 e il febbraio 1902, gli Scritti sul teatro, rimasti a lungo inediti in italiano – hanno infatti visto la luce per la prima volta nel 1995 ad opera di Cristina Grazioli e Umberto Artioli. Sulla linea Kleist-Hoffmann-Maeterlinck-Fuchs, Rilke prospetta un teatro mentale, al di sopra della carne, all’insegna della marionetta, metafora, con la sua grazia, del superamento dell’aspetto più naturalistico e mimetico del teatro, che per Rilke deve essere uno scrigno di essenze, un reticolo di silenzi, luci, suoni-rumori. Se nel teatro moderno le dramatis personae sono monadi atomizzate, chiuse in se stesse e definite da gesti e parole, se cioè il palcoscenico, cerchio unitivo, riproduce al contrario la frammentazione che devasta la vita, secondo Rilke occorre che la scena diventi il luogo della riconciliazione con il tutto, il ponte tra insensatezza del fenomenico e silenziosa presenza del divino. Il teatro è per il poeta vertigine sacrificale: l’attore non può quindi essere appariscente e recitare con una spettacolarità fine a se stessa, ma deve farsi umile (demutig) e recitare a volto coperto, disincarnandosi, abbattendo così le barriere individuali e creando uno spazio comune dove tornare a comunicare, dove si situano le radici dell’essere.
Centrale infine negli scritti di Rilke, amico di Paul Klee a partire dal 1915, il silenzio, la rinuncia alla parola in favore del movimento e dell’elemento visivo, il silenzio inteso come espressione dell’indicibile, come la scomparsa del sujet, in seguito alla quale elemento visivo e acustico diventano sujet l’uno dell’altro. Oltre questo grado zero dell’arte, oltre la vertigine della pagina bianca di Mallarmé, resta solo la possibilità di creare una lingua nuova che superi se stessa, celebrando la presenza delle cose nell’istante della loro definitiva scomparsa, ospitandone, finalmente, la potente melodia.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente





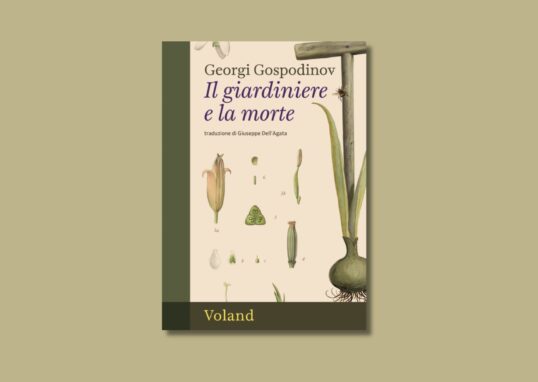
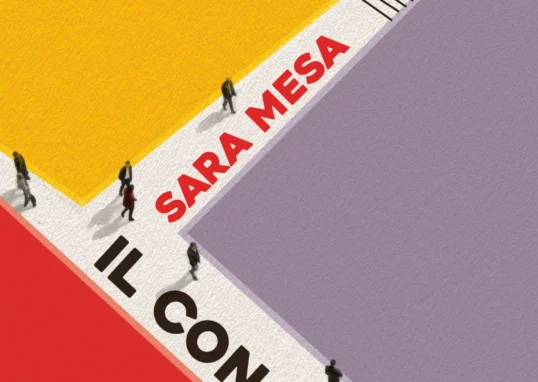
Con il Diario fiorentino Rilke dà inizio a quell’opera dello sguardo, così congeniale alla giovanile velleità di critico d’arte, opera che lo accompagna fino alla crucialità della Wendung, della svolta. Un fiume di immagini fluite nel sarcofago della Pantera per poi sublimarsi nello Herzwerk e generare una nuova coscienza di esistere grazie al “wirklicher Bezug”, alla relazione pura (“Sonetti a Orfeo” 1/12: centenario!). L’epistolario rilkiano può essere visto come una terrena variante di tale esigenza di rovesciamento dei contatti umani in un ordine superiore?
Grazie per il Suo saggio e per l’invito a ripensare.