
Christopher e Jennifer si sono conosciuti a una festa. Hanno iniziato a chiacchierare e si sono appartati in una camera da letto, tra i cappotti e le sciarpe degli invitati. Ci troviamo in «Consolazione», il terzo racconto della raccolta di Donald Antrim, La luce smeraldo nell’aria. Jennifer sta raccontando a Christopher la sua vita e a un certo punto gli rivela che in quel periodo sta frequentando solo persone che si sono trasferite a New York da posti lontani, persone che «a casa loro non avevano una casa».
Questa definizione potrebbe applicarsi tranquillamente a molti dei personaggi del libro; a cominciare dallo stesso Cristopher, che, come dichiara a un certo punto, non riusciva a farsi prendere sul serio dalla sua famiglia: «La mia famiglia mi rideva in faccia», afferma amaramente. «Potevo parlare di qualunque cosa. E loro giù a ridere! Tanto che alla fine avevo paura di parlare». Questo tipo particolare di disagio è caratteristico dei personaggi di Antrim: uomini e donne che non trovano una collocazione nel mondo. Sentono su di loro la disapprovazione di chi li circonda, e, come riflesso, il proprio stesso biasimo; perché se mancano di abilità e destrezza non gli fa certo difetto la lucidità. Ogni volta che compiono un gesto, un qualsiasi gesto, anche banale, rischiano di scompaginare un ordine perennemente in bilico, di mandare all’aria quel faticoso equilibrio che fa sì che le cose siano come sono.
Christopher e Jennifer trascorrono i fine settimana a scopare negli appartamenti dei loro amici. A casa non hanno un posto tutto loro in cui poter stare, e perciò escono dalla propria intimità per vivere in quella degli altri. Alcune abitazioni sono più confortevoli e altre meno accoglienti, ma per vivere una confidenza profonda, i due hanno bisogno di trapiantarsi ogni volta in un posto diverso. Il distacco dalle coordinate note sembra un passo necessario ai personaggi di Antrim per trovare una propria identità, lasciandosi alle spalle ogni tipo di retaggio familiare, estetico e culturale. Non si tratta solamente di abiurare a delle tradizioni note, ma di costruirne di nuove: tradizioni fluide, certamente, precarie, ma che rendano l’idea della robustezza e della durevolezza. Si tratta – naturalmente – di un inganno. Ma un inganno convincente, che lascia credere alla solidità e alla bellezza che sottende.
In «Ancora Manhattan» Jim, Kate, Susan e Elliot devono andare a cena fuori. Jim, come molti personaggi di Antrim soffre di disturbi psichici. Entra e esce dall’ospedale. Sta assumendo il litio, e la moglie vorrebbe che prendesse anche l’olanzapina. Lungo il percorso verso il ristorante si ferma a comprare un mazzo di fiori per Kate, ma – senza sapere come – la cosa gli sfugge di mano e finisce per comprare una composizione floreale da più di trecento dollari. I personaggi di Antrim non sono sempre consapevoli delle proprie azioni. Le cose accadono al di là della loro volontà. La carta di credito di Jim per qualche motivo non funziona, e – in preda a una crisi di panico – l’uomo chiama in soccorso sua moglie per toglierlo dai guai. Una volta che Kate ha sistemato le cose per telefono, Jim si avvia verso il ristorante dove lo stanno aspettando. L’uomo, che attraversa Manhattan portando sul petto un enorme vaso pieno di fiori colorati che lo privano della visuale, attraversando gli incroci senza guardare e ferendosi il volto con i rami e con le spine, è un simbolo dell’adulto contemporaneo che si muove attraverso la storia senza rendersi conto di dove stia andando, inconsapevole del proprio destino, in balia di sentimenti che lo sovrastano, incurante dei pericoli e desideroso della fine.
In «Lui sapeva» anche Stephen e Alice soffrono di disturbi psichici ed entrambi assumono psicofarmaci. I due sono andati a fare shopping e a un certo punto si fermano in un locale. Stephen si accinge a dare ad Alice la sua dose di antidepressivi, sparpagliando le pillole sul tavolo: «aveva versato un po’ troppe pillole e alcune erano rotolate verso i condimenti, il ketchup, lo zucchero, la saliera, la pepiera e così via e aveva perso… cosa aveva perso? Aveva la dose di Alice sotto controllo. E c’erano i suoi antipsicotici rosa e gialli. Dove erano finiti i betabloccanti?». Tra la malattia e la cura si pone la babele cognitiva cui i personaggi antrimiani sono irrimediabilmente soggetti. Il disordine dei farmaci sparsi sopra il tavolo è un segno inequivocabile di tale confusione. Dispersi tra il ketchup e la saliera, tra lo zucchero e il pepe, i farmaci subiscono un processo di desemantizzazione in cui sembrano rivestire una determinata valenza più per la forma e il colore che non per il loro principio farmaceutico. L’essenza delle cose cessa di essere un riferimento cognitivo e si tramuta in un accidente inutile. Privato di un solido contesto ontologico, l’universo di Antrim assume una conformazione liquida in cui le cose cambiano continuamente fisionomia, e assumono sembianze diverse a seconda del luogo e del momento in cui si manifestano.
Anche la narrazione segue schemi fluidi, con un ritmo paratattico che procede per accumulazione, come se la storia fosse stata colpita da una tempesta violentissima e ne fosse uscita fuori ridotta in frammenti minimi, ma più semplici da rappresentare: «Le sganciò il reggiseno e prese anche quello. L’aiutò a stendersi. Le tirò su le coperte e poi si spogliò, spense l’abat-jour e andò in salotto senza niente addosso, si sedette sul divano, toccandosi la fede al dito, tormentandola sovrappensiero. Dopo un po’ si alzò, spense la luce in salotto e tornò da lei al buio, senza fare rumore. Sollevò le coperte ed entrò nel letto, l’attirò a sé e l’abbracciò a cucchiaio, per prenderle i seni tra le mani e sentirla tutta quanta addosso». Anche i toni più tragici si stemperano in questa sconcertante semplicità. Niente è come appare, ma tutto sembra ammantato di una confortante normalità.
L’importanza delle cose consiste esattamente nel loro accadere, indipendentemente dalle conseguenze che potranno portare, che spesso sono tragiche. Antrim le descrive con un tono solo apparentemente distaccato, ma in realtà partecipe della loro essenza più preziosa, della loro intima poeticità. Come nello splendido finale di «Da quando», che ritrae una coppia all’uscita da una festa. Durante la serata i due si sono corteggiati, hanno discusso, hanno bevuto, hanno fumato erba, hanno flirtato con altri invitati, e alla fine lui – oramai ubriaco – ha chiesto alla donna di sposarlo. Ora escono dal palazzo e si incamminano verso casa: «Si tolse la giacca e se la buttò sulla spalla, si sbottonò i polsini della camicia, prima il sinistro, poi il destro, e si arrotolò le maniche fino ai gomiti. La luna brillava e il cielo era senza stelle. I palazzi svettavano sopra di loro». Di tutto il carosello di emozioni, lacrime, disperazione e gelosie che si sono succedute fino alla scena precedente, è rimasta solamente la luna, loro stessi e la città. È sorprendente il divario che si percepisce tra il subbuglio della realtà interiore e la sobrietà di quella esterna. Raramente tra le due dimensioni si stabilisce un qualche tipo di osmosi.
Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, «La luce smeraldo nell’aria», Billy vuole disfarsi dei disegni di Julia, la sua ex, ma non è certo che sia una buona idea: «I dipinti, pensò Billy, mentre sedeva dentro l’auto appollaiata sulla scarpata, non erano potenti come i disegni, che invece, pur essendo studi più o meno accurati dei loro omologhi a olio, tutte scene rurali della Virginia – alberi in un campo, un laghetto inaridito, una casa diroccata in una valle di montagna –, avevano, con le loro cancellature decise, le macchie e le linee a matita ricalcate, qualcosa di astratto e, in confronto ai dipinti lavorati e rilavorati, una complessità tridimensionale». La scrittura di Antrim può paragonarsi a questi disegni. È aspra e al tempo stesso poetica. Sia nelle descrizioni dei personaggi che in quelle paesaggistiche c’è sempre una profondità di campo che si protende superbamente verso l’infinito; come nei dipinti del Tiepolo che, un po’ di tempo prima, Billy aveva potuto ammirare a Venezia insieme a Julia: «Tutto è fuori posto in Tiepolo. I rapporti spaziali non sono coerenti. Non è solo perché la gente vola per aria con gli angeli. Quale mondo stiamo guardando? Lo sguardo viene sempre orientato verso l’infinito».
Se è vero che Antrim ha contribuito a portare la letteratura americana al di fuori del postmodernismo, è vero anche che del postmodernismo conserva lo sguardo relativista sulle cose. I suoi personaggi vengono da famiglie distrutte, assumono psicofarmaci, fanno uso di stupefacenti, sono emotivamente fragili in modo disastroso. Ma lo sguardo dello scrittore non indulge mai troppo sulla loro debolezza. Il fuoco della sua narrativa è in cielo, dove l’incanto della luce ci fa rimanere a guardarli con gli occhi rivolti verso l’alto; i suoi personaggi, come quelli del Tiepolo, volano in aria con gli angeli.
Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Letteratura Italiana. Nel 2025 ha pubblicato per Il Convivio la raccolta poetica Sono il poeta. Nel 2023 ha tradotto e curato per Interno Poesia un’ampia antologia delle poesie di John Keats, intitolata Mio cuore. Nel 2021 ha pubblicato, ancora per Interno Poesia, la raccolta poetica Cento sonetti indie. Nel 2018 è uscita per Castelvecchi la sua raccolta di saggi Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter. Nel 1998 ha pubblicato con Bulzoni una monografia sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza.

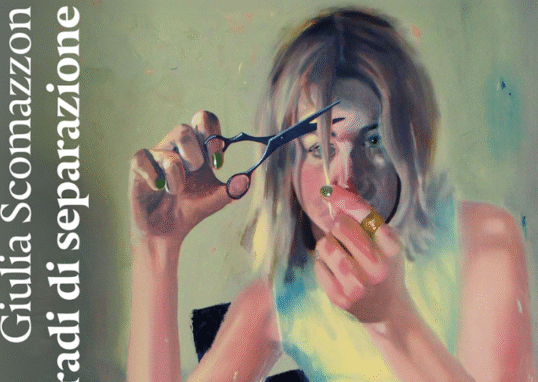





1 commento