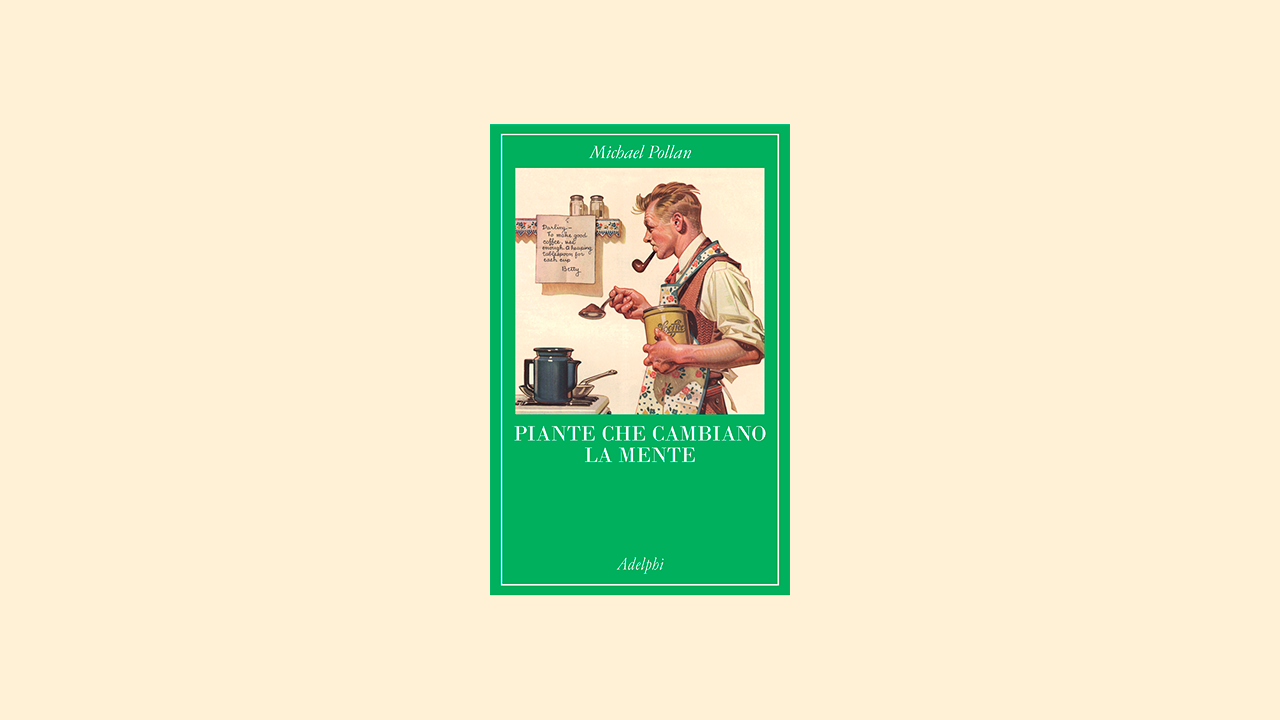
Se dovessi identificare qualcosa, tra l’infinità di aspetti che riguardano la natura, di cui l’uomo come specie conosce tanto e come individuo quasi niente, quel qualcosa sarebbero senza dubbio le piante. Sapreste definirla, con parole semplici, una pianta? Certo ci sono caratteristiche comuni a tutte – o quasi – le piante, che le rendono ai nostri occhi semplici, quasi banali o scontate, un elemento d’arredo o un ingrediente da cucina. Eppure, le piante sono organismi uni o pluricellulari estremamente vari e complessi, da esse dipende in modo inscindibile la nostra vita, quella degli animali e del pianeta stesso, e mentre scrivo questo articolo il genere umano ne ha catalogate ben 386654 specie diverse.
Tutto questo per dire che le piante sono un argomento che riesce da sempre ad affascinarmi e di cui, ne sono consapevole, non saprò mai abbastanza. Qualcosa in più però l’ho imparata di recente leggendo il nuovo Piante che cambiano la mente di Michael Pollan, pubblicato da Adelphi nella traduzione di Milena Zemira Ciccimarra. Il nome di Pollan, newyorkese classe 1955, potrebbe dirvi qualcosa se avete letto Come cambiare la tua mente (Adelphi, 2018) in cui analizzava le scoperte scientifiche più recenti circa le sostanze psichedeliche. Qui si concentra invece sugli effetti di oppio, caffeina e mescalina sulla mente umana, in tre macro-capitoli dove racconta la propria esperienza personale con queste sostanze, rendendo il tutto immediatamente più interessante.
Partiamo dalla riflessione con cui si apre il libro, e cioè che nella nostra società non pensiamo alla caffeina come a una droga, o al consumo quotidiano che ne facciamo come a una tossicodipendenza, ma solo perché tè e caffè sono legali e la nostra dipendenza da essi è socialmente accettabile. Ma allora – si/ci chiede Pollan – cos’è esattamente una droga? Perché preparare un tè con le foglie di Camellia sinensis non ha nulla di controverso, mentre fare la stessa cosa con le teste di Papaver somniferum costituisce un reato federale? Una definizione convincente non la trova nemmeno lui, se non che una sostanza è illecita quando è la legge a stabilirlo.
Ma le leggi cambiano nello spazio e nel tempo, tant’è che persino il caffè è stato dichiarato illegale in passato in Europa e nel mondo arabo, in quanto le persone che si riunivano per berlo erano considerate politicamente pericolose. Oggi invece la caffeina non corre rischi, avendo ampiamente dimostrato il proprio valore per il capitalismo rendendoci lavoratori più svegli ed efficienti. Mentre gli psichedelici – scrive Pollan – che non sono più tossici della caffeina e danno anche meno dipendenza, sono considerati, almeno in Occidente a partire dalla metà degli anni ’60, una minaccia alle norme e alle istituzioni sociali.
La prima parte del libro è in realtà la versione integrale del saggio “L’oppio facile” che Pollan scrisse nel 1997 per Harper’s Magazine, dove racconta i suoi tentativi di coltivare e consumare l’oppio dei fiori di papavero piantati nel suo giardino in Connecticut. A spingerlo è la domanda già vista sopra, ovvero quando e se quell’attività risulta illegale, ma il periodo in cui scrive vedeva gli Stati Uniti coinvolti in una vera e propria guerra alla droga, tanto da costringerlo ad autocensurare il testo omettendo passaggi che avrebbero potuto causargli rogne. La vera forza di questa parte si trova quindi nelle aggiunte al testo originale e in un epilogo dove Pollan riflette sulla guerra americana alle droghe.
La seconda parte è invece dedicata alla caffeina, e inizia con un altro esperimento personale, questa volta però di privazione: Pollan ha smesso di bere caffè per verificare se, nonostante l’astinenza, avrebbe avuto l’energia intellettuale necessaria per finire il saggio. La riflessione che ne scaturisce è forse la più interessante del saggio, e non è un caso che si trovi nella parte centrale. Pollan ci mostra qui come la stessa pianta e la sua sostanza chimica – note a tutti i potenziali lettori – possano essere utilizzate per ottenere effetti molto diversi a seconda del contesto.
La parte finale invece racconta l’esperienza di Pollan con il peyote, particolare tipo di cactus in cui si trova la mescalina, durante la pandemia (che causa una deviazione rispetto all’idea originale dell’autore). Pollan ci porta quindi a sbirciare nelle cerimonie che sono state alla base delle culture dei nativi americani per almeno 6000 anni, in una chiusa che costituisce un interessante spaccato anche dell’America di ieri e di oggi, risultando però la parte più ostica da comprendere dell’intero saggio. Ma come spesso accade per esplorazioni così personali, i risultati degli esperimenti di Pollan aprono tante domande pubbliche quante rivelazioni private, e rappresentano uno splendido approfondimento per tutti i curiosi di questo territorio profondamente controverso.
Francesco Ventrella è nato a Modugno nel 1991, è cresciuto a Ravenna e attualmente vive e lavora a Milano. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna e ha conseguito il Master in Arti del racconto alla IULM. Giornalista e videomaker, scrive per Esquire e lavora come visual editor per Hearst Italia. Su Medium: https://francesco-vntr.medium.com/






