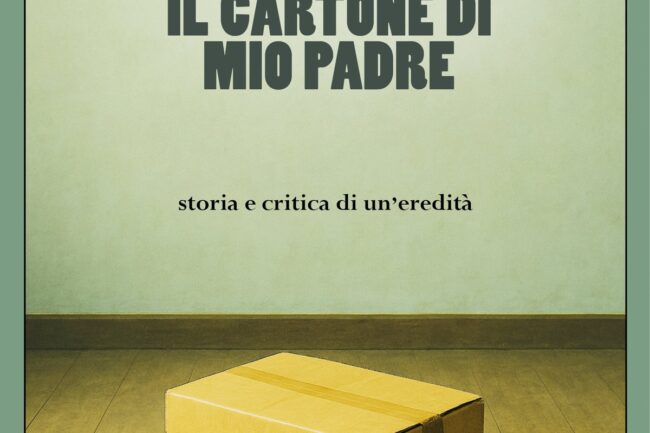
“Non sopportavo più la presenza muta del cartone, ci sentivo dentro il silenzio di mio padre. E non volevo che un giorno quel silenzio si trasmettesse ai miei figli. Era mia responsabilità trovargli un posto, in cassaforte, in un cassetto segreto o nella spazzatura. Con l’eredità mi succedeva lo stesso che a tutti: prima o poi si era costretti a occuparsene”.
Così Lukas Bärfuss, nelle prime pagine de Il cartone di mio padre. Storia e critica di un’eredità, appena pubblicato da L’orma, spiega le ragioni che l’hanno spinto a scoperchiare quel “banalissimo”, eppure “maledetto” cartone di banane della Del Monte, “l’unica testimonianza di un uomo del quale si diceva fosse stato mio padre”. I documenti che vi erano conservati, solo in apparenza innocui – lettere del tribunale fallimentare, avvisi di pignoramento, dissequestri, indennità di disoccupazione – ricordano dolorosamente allo scrittore non solo le difficoltà e le sofferenze che hanno attraversato la vita del padre, ma anche la propria: “Mi sono guadagnato un nome scrivendo, ho preteso il diritto esclusivo di interpretare la mia vita e ho incontrato persone che ho eletto come affini. Mi reputavo fortunato perché con la letteratura avevo trovato qualcosa che non avrei mai esaurito, era una sfida e mi entusiasmava, e alla fine mi dava addirittura da vivere. Ma ora quelle origini mi stavano di nuovo davanti in forma di un orribile cartone, uno scatolone pieno di povertà. E una parte di me ci abitava ancora dentro.”
Il cartone obbliga Bärfuss a fare i conti con le proprie origini: si può sfuggirne? O addirittura negarle? Se le origini culturali sono una scelta, come affermerà più avanti nel libro, quelle biologiche no, sono un’imposizione. Come nel precedente Koala, in cui il suicidio del fratello smuove un’interessantissima riflessione sulla violenza della società in cui viviamo, anche ne Il cartone di mio padre il memoir è solo un punto di partenza per una raffinata indagine che prova a mettere in discussione i concetti di famiglia e di origine, a partire dalla Bibbia e dal saggio di Charles Darwin su L’origine delle specie, nonché a evidenziare come tutte le origini, familiari, culturali, nazionali, determinino quei privilegi che spietatamente sorreggono le nostre società.
Nelle pagine particolarmente dense dedicate coraggiosamente a Darwin, Bärfuss insiste sul criterio che avrebbe guidato lo scienziato mentre intraprendeva una delle più sorprendenti teorie della storia della scienza; ne rileva però dei difetti, come ad esempio l’assenza di quella che chiama “scienza della collaborazione”, in quanto Darwin avrebbe sì visto dei “nessi” tra le specie e gli individui, ma “non era in grado di descriverli” narrativamente perché di fatto ricostruiti solo in termini dinastici: “Ma la Natura non ha un sovrano, – protesta Bärfuss – non è un regno e nessuno vi domina, nemmeno l’uomo, anche se questa credenza è difficile da estirpare”. Il rivoluzionario Darwin, invece, avrebbe comunque trasferito il “dominio cristiano” in quello biologico dell’evoluzione.
Insomma, per lo scrittore la domanda relativa all’origine dell’uomo resta ancora tutta da indagare. Bärfuss sembra darcene una risposta quando, poco prima di ricevere la notizia della morte del padre, mentre si trovava in Camerun, lui “piccolo uomo europeo che aveva deciso di diventare scrittore senza un’idea di come arrivarci” vive un “attimo di spaesamento” in cui si sente finalmente libero dal peso delle costrizioni biologiche e sociali, eppure connesso con l’universo, “le cui singole parti, le stelle, la Terra, gli esseri umani, gli animali erano perduti” tanto quanto lui. Ed è forse ripensando a questa sensazione che non gli pesa più che l’urna del padre ad un certo punto sparisca: nell’incertezza dell’origine è custodita una preziosa forma di felicità.
Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.






