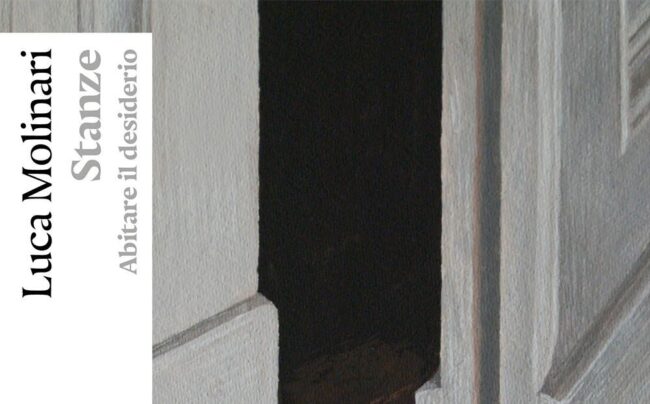
“La casa, ancora più del paesaggio, è uno stato d’animo”
Gaston Bachelard, La poetica dello spazio (Edizioni Dedalo 1975)
Leggendo Bene immobile, l’ultimo libro di Deborah Levy appena pubblicato da NN, e lasciandosi trasportare dalla corrente dei suoi sogni immobiliari, ci accorgiamo quanto quel bene immobile chiamato casa sia in definitiva più mobile che mai: soggetto alle fluttuazioni dei nostri desideri più intimi o dei nostri sogni più reconditi, oltre che ai cambiamenti sociali, culturali, tecnologici. Privato e insieme sociale il modello delle case in cui abitiamo, o che semplicemente vagheggiamo, non è mai assoluto, né tantomeno immobile. Come ha osservato Gaston Bachelard nella sua intramontabile Poetica dello spazio “La casa è un corpus di immagini che forniscono all’uomo ragioni o illusioni di stabilità: distinguere tutte queste immagini, dal momento che incessantemente si reimmagina la propria realtà, vorrebbe dire svelare l’anima della casa, sviluppare una vera e propria psicologia della casa”.
Distinguere e reimmaginare è un po’ quello che ha cercato di fare Luca Molinari in due libri pubblicati entrambi dalla casa editrice Nottempo: Le case che siamo (2020) e ora Stanze. Abitare il desiderio, dove l’autore si muove con un’attenzione che va dalla psicologia alla storia, e alla sociologia. Da una parte, infatti, lavorare sulle case e sulle stanze che le compongono significa sondare uno spazio privato, intimo e onirico che ci mette di fronte ai nostri desideri, ma dall’altra parte significa anche affrontare “uno spazio pubblico in costante metamorfosi in cui prendono forma le nevrosi e le contraddizioni del nostro tempo”, e la casa diventa altresì “uno spazio politico tra generi e generazioni contrapposte”.
Nel De rerum natura Lucrezio racconta che nello spazio della capanna, accanto al fuoco, l’uomo e la donna hanno finalmente il tempo di guardarsi: è dentro allo spazio protetto della casa che l’amore e l’affetto possono finalmente manifestarsi. La casa è prima di tutto lo spazio del desiderio. “Mi piace immaginare”, scrive Molinari nell’Intro. La casa e le stanze, “che le prime pareti interne di queste abitazioni nomadi e temporanee fossero composte di canapa intrecciata, facile da arrotolare e trasportare, oppure di tessuto, alcune volte di una fibra pesante e resistente, altre di peso leggero, semitrasparente”. Pur senza compromettere la fluidità del luogo, l’inserimento di questi filtri favorisce la possibilità di definire ambiti più riservati e protetti: che siano di canapa o in muratura, si tratta pur sempre di pareti che definiscono le stanze di una casa, a meno che la casa non sia stata concepita come un open space, scelta che a sua volta rivela un modo diverso di intendere lo spazio e le relazioni che lo attraversano.
Pareti, porte, finestre mettono in moto una dialettica tra interno ed esterno capace di rivelare lo spirito del tempo; per non parlare dei balconi, dei giardini, delle terrazze: “si potrebbe elaborare uno studio di antropologia urbana già solo osservando questi fazzoletti, che ciascuno concede in base ai regolamenti edilizi e al calcolo spietato di alcuni metri quadri utilizzabili. A questi sottili baluardi esterni è sempre stata demandata la mediazione tra quello che siamo guardando fuori e quello che proteggiamo, ovvero ciò che siamo noi all’interno.”
Vengono in mente i versi con cui si apre Il balcone di Montale: “Pareva facile giuoco/ mutare in nulla lo spazio/ che m’era aperto, in un tedio/ malcerto il certo tuo fuoco.”
La lettura del saggio di Molinari assomiglia a una caleidoscopica visita immobiliare, durante la quale un coltissimo e raffinato agente immobiliare (l’autore stesso) ci guida nell’esplorazione della casa e delle sue stanze, in un rimando continuo alle case e alle stanze realizzate, o solo immaginate, nell’architettura, nell’arte, nel cinema, nella letteratura, comprese le case della nostra infanzia che ancora fanno capolino nei nostri sogni. A ogni capitolo una stanza. Ogni capitolo come una stanza.
Prima però bisogna aprire la porta: “La Porta! La porta, è tutto un cosmo del Socchiuso”, scrive Bachelard. Ed è da una porta che entriamo nel vivo del saggio di Molinari “Ogni porta è una soglia, e introduce a ciò che si nasconde dietro quel filtro necessario. Ogni porta è uno spessore da attraversare per accedere a un mondo segreto che attende una chiave di ingresso.” In questo primo capitolo, dal titolo appunto Porta d’ingresso, corridoio e finestre, Molinari spazia da una porta all’altra, dalle grandi due porte contrapposte che s’incontrano una volta varcato l’atrio del palazzo milanese progettato da Piero Portaluppi a quella monumentale e pesantissima aperta da Aladino con la nota formula “Apriti sesamo”, fino ad arrivare alla porta in cui si fronteggiano i corpi nudi di Marina Abramovic e Ulay durante la celebre performance Imponderabilia, a quelle disegnate con il gessetto nella planimetria di Dogville nell’omonimo film di Lars von Trier. La forza del saggio di Molinari infatti sta proprio nella capacità dell’autore di descrivere spazi evocandone nel contempo altri.
Così di stanza in stanza, di capitolo in capitolo, si passano in rassegna tutti i luoghi della casa: il soggiorno e tinello, la cucina, lo studiolo-biblioteca, il bagno, il boudoir, lo spogliatoio e la cabina armadio, fino a entrare nella camera da letto, “l’ultima stanza in cui ci muoviamo e la prima che salutiamo al risveglio, ogni giorno della nostra vita”, la stanza in cui, a ben pensarci, trascorriamo più tempo. Per questa stanza Molinari sceglie di descrivere, come immagine conclusiva del capitolo, il letto delle case tradizionali olandesi realizzato in legno e a forma di barca al fine di consentire a chi giace nel letto di essere trasportato senza nessun rischio sull’acqua, in caso di un’improvvisa inondazione: “una metafora perfetta di quello che ancora oggi sono le nostre camere da letto: cabine spaziali che, nelle ore in cui smettiamo di sentire noi e il mondo, nelle ore in cui possiamo essere solo corpo ed emozioni, ci offrono la forma più profonda di libertà”.
Nell’elenco delle stanze, infine, non possono mancare le cantine, luoghi del sottosuolo che hanno “il potere simbolico di liberare i nostri demoni”, e le soffitte, in fin dei conti “cantine che guardano al cielo”, luoghi di memorie e segreti inattesi. La stanza più importante di tutte rimane, però, La stanza vuota per il futuro, titolo del capitolo con cui si chiude questo saggio denso eppure piacevole a leggersi, e pieno di suggestioni: “una stanza in attesa”, tutta in divenire, in cui “possiamo finalmente immaginare scenari, possibilità, spazi che vadano oltre lo schema abitativo radicato nella nostra mente, abitudini per liberare energie e potenziali che costruiscano paesaggi nuovi”.
Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.






