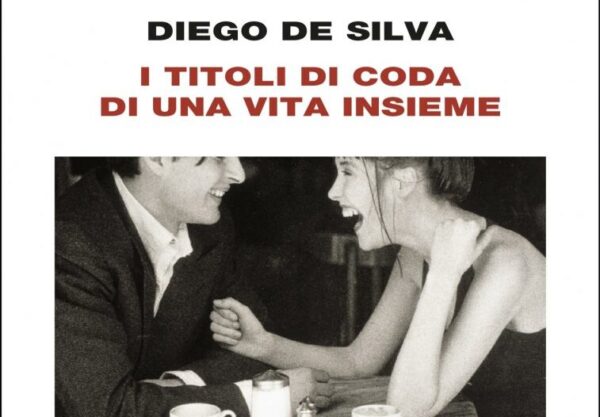
di Francesca Romana Cicolella
“Questa è la meraviglia della letteratura: che è inutile. La letteratura non rende migliori, non nobilita, però io credo che chi ama la letteratura sa quanto è importante esprimersi, quanto le parole possano essere fondative di relazioni importanti e quanto possano essere distruttive se sono usate male”. Diego De Silva ha scoperto tardi la letteratura. Ha cominciato a scrivere racconti che inviava in buste gialle imbottite quando internet non c’era e lui, da avvocato, frequentava solo grigie aule di tribunale.
In questa intervista, molti anni e libri pubblicati più tardi, reduce dal successo della serie televisiva sull’avvocato Malinconico, parla de “I titoli di coda di una vita insieme”, il suo ultimo romanzo edito Einaudi, ma anche del potere incredibile delle parole, di come si utilizzano per parlare di amore, separazione e vita vissuta.
Una coppia che si sta separando è protagonista de I titoli di coda di una vita insieme. Fosco e Alice, sposati da anni, condividono un figlio oramai maggiorenne, una casa, infiniti ricordi e tanta vita vissuta fianco a fianco. Ma qualcosa si rompe, allora l’amore lascia spazio a una scelta complicata e dolorosa. L’amore è un tema presente in molti tuoi libri. Qui, però, c’è la separazione, che sembra dire dell’amore molto più delle storie in cui due stanno insieme felicemente. Tu, durante una presentazione, hai detto che ritieni questo sia il tuo libro più importante. Perché? C’entra l’amore?
Questo è un libro molto importante perché ho cercato di oggettivare dal punto di vista linguistico quella che io ho definito “la sintassi dell’addio”, cioè il linguaggio – che si trasforma- tra due persone che si sono amate e che si stanno lasciando. Parlo di quanto è difficile trovare le parole degne, dignitose e anche letterarie per potersi raccontare in uno dei momenti più difficili, dolorosi e complicati della vita. E poi è molto importante per me perché ho fatto i conti con un altro tema che mi stava molto a cuore che è il tradimento dell’infanzia: un senso di colpa che mi sono portato a lungo dietro e credo di aver risolto con questo libro. Io credo di aver tradito la mia infanzia e di essere venuto meno a delle cose importanti e a un certo punto di averlo fatto colpevolmente. E questa cosa mi ha fatto soffrire per molto tempo, però sono riuscito a risolverla con il mio lavoro.
Già con i libri della serie dell’avvocato Malinconico i tuoi lettori si sono abituati a non leggere più un racconto in terza persona ma in prima persona. La prima persona consente, senza dubbio, di mettere su carta l’interiorità del personaggio, fa sentire il lettore più vicino alla storia. Ne I titoli di coda di una vita insieme le voci diventano addirittura due. A capitoli alterni Fosco e Alice raccontano la loro versione della storia, le loro sensazioni e la loro capacità, o incapacità, di fare i conti con questa fine. Mi sono chiesta, però, se per chi scrive non sia più difficile diventare il suo personaggio e scrivere con la sua voce rispetto a rimanere narratore esterno.
Bhe però scrivi in prima persona se sei spinto da un’esigenza di autenticità. Questa cosa, anche se è più violenta dal punto di vista psicologico, ti mette in contatto con ciò che intimamente senti e pensi. La cosa difficile è sempre dare parole ai sentimenti e alle esperienze. È molto difficile scegliere le parole per poter raccontare degnamente qualcosa che ci coinvolge nell’intimo. La prima persona sicuramente permette una maggiore immedesimazione e un rapporto riscontrabile con le parole, poi anche in terza si può fare la stessa cosa, però in questo caso siccome, come riportato dalla fascetta del libro, “l’amore non è una storia ma due”, io volevo proprio che questa storia fosse raccontata dalle voci in prima persona di Fosco e di Alice.
Sebbene in questo romanzo la separazione sia il tema centrale, nelle altre tue storie ci sono sempre state coppie che, sposati, amanti o fidanzati, smettono di stare insieme. Un elemento è però comune a tutti quelli che si separano: riescono sempre a mantenere un bel rapporto, a volersi bene anche dopo. Non è una cosa comune, anzi. Oggi, fuori e dentro i tribunali, gli ex tendono a scontrarsi, a parlare male gli uni degli altri e a cancellare brutalmente quello che c’è stato. Cosa ti spinge a raccontare solo di coppie che si lasciano bene?
Perché il conflitto, soprattutto il conflitto tra persone che si sono amate veramente, che hanno scelto di fare un tratto del cammino della vita insieme e magari si sono illusi che sarebbe durato per sempre, – per il sempre della loro vita si intende – lo trovo volgare, una cafonata. E noi ci lasciamo spesso andare, anche io non sono immune da questo, anche io sicuramente nella mia vita sentimentale ho avuto momenti di volgarità e di cafonaggine però credo che sia un rischio di bassezze a cui possiamo prepararci, possiamo anche pensare che si possono evitare. Perché poi col tempo le cose di cattivo gusto ti fanno vergognare e non le ripeteresti, se sei una persona sensibile ovviamente. Se poi sei un cretino che se la lega al dito e vive di rancori – e ce ne sono di persone così – allora vuol dire che ti sta bene così e allora peggio per te. Però sono sicuro che quella gente lì non viva bene, non credo che chi vive di rancore, chi continua a fare stupide questioni di principio negli anni, poi sia una persona a cui quella vita piace, anzi credo che faccia una vita di merda.
C’è un momento in cui Alice dice che “Fosco è un sabotatore di emozioni, che poi è il lavoro della letteratura”. In questo tuo romanzo la letteratura ha un ruolo ancor più centrale e non solo perché Fosco è uno scrittore. Il protagonista sfrutta infatti la letteratura per parlare del suo passato, che poi è anche un po’ il tuo, per dare spessore alla sterile giurisprudenza e persino per dialogare con il figlio e dirgli della separazione. Ho l’impressione che ne I titoli di coda di una vita insieme la letteratura non sia solo mediatrice tra libro e lettore, ma anche tra i personaggi del libro. Come si fa a utilizzare la letteratura all’interno di una storia? Non è complicato, per uno scrittore, far capire a tutti quanto sia importante la letteratura?
Per me la letteratura è stata importantissima. Io, tra l’altro, l’ho scoperta anche abbastanza tardi, però per me è stata fondamentale. Il rapporto con la parola, con la misteriosità della parola, con l’inspiegabilità delle emozioni, con la complessità e incomprensibilità della vita. Tutte queste consapevolezze inutili. Questa è la meraviglia della letteratura: che è inutile. La mentalità utilitaristica per cui si fa una cosa per uno scopo, per poterne fare uso, l’idea che le cose devono servire, che poi è una concezione che molto spesso si trasferisce sulle persone, strumentalizzandole per servirsene, è una cosa davvero cafona. La letteratura è l’opposto, la letteratura non rende migliori, non nobilita, però io credo che chi ama la letteratura sa quanto è importante esprimersi, sa quanto le parole possano essere fondative di relazioni importanti e quanto possano essere distruttive se sono usate male, se non ti aiutano per esempio a capire quanto sono importanti i silenzi in una relazione interpersonale. La comunicazione vera tra persona è fatta anche di silenzi, però scegliere il momento in cui stare zitto è difficile. È una questione di gusto e questo, per esempio, la letteratura te lo dice. La letteratura vera eh, quella che questa roba qua te la dimostra e che ti insegna quanto sia importante lavorare sulla complessità del rapporto con la parola, cioè non parlare a vanvera e non limitarsi solo a usare dei linguaggi indicativi per cui la realtà è solo un fatto oggettuale o oggettivabile, c’è altro. La realtà oggettiva non è soltanto l’oggetto, negli oggetti c’è qualcosa che rimanda ad altro, al tempo che è passato. Pensa a cosa c’è in una casa, a quanto possa parlare un divano, un letto, una credenza, un servizio di piatti. Se tu li sai guardare senti che c’è una vita che c’è passata sopra, persone che hanno mangiato in quei piatti per decenni. Uno se ne può anche fottere e dire “vabè, è un piatto e ci mangio”. Però uno che ama la letteratura anche solo in quel piatto ci vede altro.
Non solo gli oggetti, anche i luoghi della letteratura sono importanti. Sul tuo ultimo romanzo, per esempio, ci sarebbe moltissimo da dire sulla casa di Cavaliere, il paesino in cui Fosco ha passato le estati in infanzia e in cui decide di tornare con Alice proprio mentre si stanno separando. Qui riaffiorano ricordi ed emozioni ed è netta la sensazione che ogni luogo in cui le cose accadono, dentro e fuori i romanzi, abbia un’enorme importanza.
Ecco, quella è la parte più importante del romanzo. Quello è il tradimento della mia infanzia. Anche perché scrivendo mi sono accorto che il tradimento dell’infanzia e la separazione di Fosco e Alice diventavano la stessa cosa. Fosco accetta la perdita dell’infanzia e il senso di colpa allo stesso modo in cui accetta la separazione, la fine del suo matrimonio, e sa che queste due mancanze faranno sempre parte di lui, sono la stessa cosa.
E soprattutto sono necessarie.
Per lui, cioè per me sicuramente. Io, ad esempio, ho perso mio fratello da poco e mi rendo conto che se questa mancanza non fa parte di me, non mi costituisce intimamente, io non potrò superare la perdita.
Le parole della letteratura, allora, sono anche quelle giuste per raccontare il dolore. Anche, ad esempio, quello di una malattia.
Il racconto della malattia, altra esperienza che ti appartiene personalmente, è presente nei romanzi di Malinconico. Ne I titoli di coda di una vita insieme, invece, Fosco dice al figlio della separazione con sua madre utilizzando le stesse parole che tu, nella realtà, hai utilizzato con tua figlia per dirle della tua malattia. Ma è difficilissimo trovare le parole giuste per dire del dolore, molto più complesso che raccontare di felicità. Come si scelgono, quindi, le parole giuste per raccontare qualcosa che fa male?
Le parole sono fondamentali. È quello che sottolineo anche quando parlo della incapacità del linguaggio giuridico di raccontare la separazione. Tu in quel momento ti affidi alla legge perché è quella l’istituzione deputata, ti devi riconoscere all’interno di uno stato che è lì a certificare un’unione, il che è già ridicolo se ci pensi. Perché è lo stato che deve dirmi che sto facendo bene e devo regimentarmi alle sue regole per il rapporto d’amore con la donna che sto sposando? È folle e da imbecilli. Non solo, la stessa cosa succede nella fine. Devo sottopormi per la seconda volta alla parola di uno stato che deve dirmi come mi devo comportare, che cosa devo fare o non fare, dove devo vivere, a chi vengono affidati i figli ecc. Una follia. E poi sono anche cose inevitabili, se sei nel patto sociale devi rispettare questa roba qua ma è una cosa che se uno ci pensa razionalmente è insopportabile e osceno. Il linguaggio che la legge utilizza in queste occasioni, a proposito di scelta delle parole, a chi pratica la legge non interessa, vieni trattato come una pratica.
Quello di cui invece in certi momenti abbiamo bisogno è proprio la letteratura, la scelta delle parole. Perché nessun vero scrittore butta le parole così. Un vero scrittore ha paura delle parole, si lascia aggredire dalle parole, da quelle che tradiscono, che tirano fuori le emozioni. È tutto lì, nei momenti più importanti noi abbiamo bisogno di questo, non di diritto, di tribunali, di faldoni, di uffici grigi e schifosi.
Pensando all’azione salvifica della letteratura è facile rifarsi ad un’altra caratteristica fondante della tua letteratura: l’umorismo. In ogni tuo scritto c’è una cifra umoristica che contraddistingue i personaggi e che rende le storie, anche le più complesse, godibili e comprensibili fino in fondo. Con l’umorismo arrivi al fondo delle cose e anche a tutti. Eppure, in Italia ma forse accade anche altrove, la scrittura di stampo umoristico viene spesso declassata come solamente leggera. Quanto è importante, invece, saper dire le cose utilizzando l’umorismo?
La letteratura umoristica non lo comprendono gli ignoranti, i cretini. Non lo comprendono quelli che non sanno cosa sia la letteratura. Basterebbe leggere Martin Amis, Mark Fisher, Woody Allen per capire che è impossibile pensare che una cosa che fa ridere sia solo stupida. Anche perchè non stiamo parlando di cinepanettoni ma di letteratura. “Il giovane Holden”, per esempio, ti fa ridere dalla prima all’ultima pagina, qualcuno vuol mettere in discussione l’importanza letteraria di questa opera superlativa?
Allora Malinconico? Non è forse letteratura? Io lì dentro ci ho messo anni e tutta la mia esperienza, la mia sensazione di disagio, di imbarazzo e fallimento in quel mondo e non sanno cosa dicono quelli che credono quella non sia letteratura. Se, altro esempio, vedi Manhattan di Woody Allen ci trovi amore, tradimento, senso di colpa, il rimorso, la rimozione, l’amicizia. Ti pare poco?
E poi, azzeccala una frase che fa ridere: è difficilissimo. Ed è una cosa vera in tutti i campi. L’attore più bravo è quello che sa far ridere. Far ridere è molto più difficile che far piangere. Il registro drammatico è molto più semplice di quello comico. Un vero comedian è molto più bravo di un attore esclusivamente drammatico. Ridere di qualcosa significa trovarla vera. Facci caso, se leggi una cosa che ti fa ridere istintivamente dici “è vero!”. Allora la verità è ridicola?
Vorrei chiedere a chi sminuisce umorismo e comicità di far ridere. Ma non lo sanno fare, allora si incazzano con chi fa ridere la gente. È una forma di pettegolezzo paraletterario.
Hai detto molte volte che c’è una persona che ha contribuito moltissimo al tuo percorso nel campo della letteratura ed è Giuseppe Pontiggia, che tra l’altro ha per primo scoperto il tuo talento. Quanto conta, in questo campo ma non solo, trovare e avere qualcuno che abbia la capacità di dirti cosa sai e puoi fare e cosa no?
Per me il riscontro intellettuale è stato importantissimo. Soprattutto quando inizi e in quei momenti ti senti solo. Tu pensa che quando ho cominciato a scrivere non c’era neanche internet, scrivevo i miei raccontini e li mettevo nelle buste imbottite. Vengo da un mondo sorpassato.
Per me il riferimento, lo scambio culturale, il confronto sono fondamentali. Da sempre la letteratura è fatta di questo. Anche di confronto tra ciò che tu fai e ciò che fa un collega. Lo scambio intellettuale per me è stato fondamentale.
Quali sono gli scrittori che pensi abbiano influenzato di più il tuo modo di scrivere o che, in generale, sono i tuoi preferiti?
Javier Marìas, Agota Kristof, Bret Easton Ellis. Ci metterei anche Salinger. Poi ho amato tantissimo Moravia, la Morante, Parise, Calvino. Altro scrittore che amo pazzamente è John Maxwell Coetzee. Un libro in particolare è un capolavoro assoluto e si chiama Vergogna, libro di una bellezza inspiegabile.
Lasciamo per un attimo i libri e accendiamo la televisione. La serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, tratta dai tuoi romanzi che raccontano le avventure e la vita dell’avvocato Malinconico, ha avuto, a ragion veduta, enorme successo. Senza contare che siamo riusciti a dare un volto a Vincenzo Malinconico grazie all’interpretazione di Massimiliano Gallo.
Anche io! Non sapevo come era.
Quando è stato deciso di trasformare la vita di Vincenzo Malinconico in una fiction Rai hai avuto paura che la tv potesse sminuire il libro?
Assolutamente no, anche perché io le ho scritte tutte le serie, sono stato coordinatore del gruppo di sceneggiatura. Poi ho avuto la gran fortuna di beccare un attore perfetto. Siccome io non faccio mai le descrizioni dei miei personaggi, non sapevo come fosse fisicamente Vincenzo Malinconico. Quando ho incontrato Massimiliano Gallo, che teneva tantissimo a questo ruolo e lo ha voluto fortemente, ho pensato “ci siamo!”. E quando ci siamo messi a lavoro lui ha talmente fagocitato il personaggio da farlo diventare una parte di sé. Sono realmente soddisfatto del risultato.
Lo sei anche dei risultati cinematografici degli altri tuoi libri?
Si, sono stato abbastanza fortunato. Ho avuto sempre trasposizioni quantomeno dignitose.
“Certi bambini” rimane ancora oggi un prodotto bellissimo.
Recentemente poi Stefano Incerti ha fatto un altro film tratto da un mio libro, che si chiama “Voglio guardare” ed è venuto benissimo. L’ho visto poco fa, è pronto da poco e sarà al cinema, spero con una distribuzione il più ampia possibile.
Quali sono i prossimi progetti in cantiere?
Portiamo Malinconico a teatro. Stiamo preparando lo spettacolo, che è prodotto dal Teatro Diana di Napoli. Poi, portato a termine il tour di presentazione dell’ultimo romanzo, lavorerò anche al prossimo romanzo, un altro Malinconico.
Malinconico a teatro sarà sempre Massimiliano Gallo?
Assolutissimamente si, chi altro vuoi che ci sia? Sarà uno spettacolo molto concentrato su di lui.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

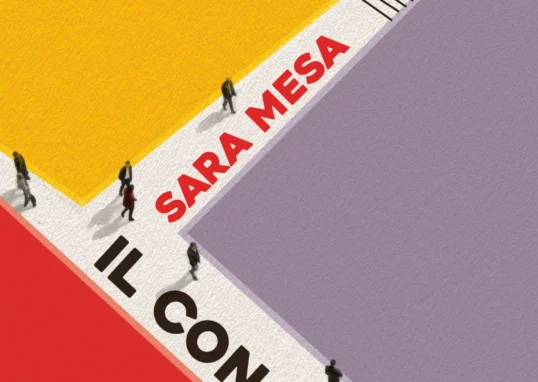




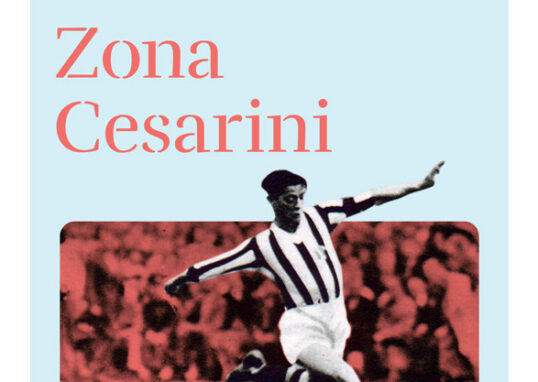
intervista fluente in cui viene fuori la vera anima dello scrittore De Silva.
scorrevole e piacevole