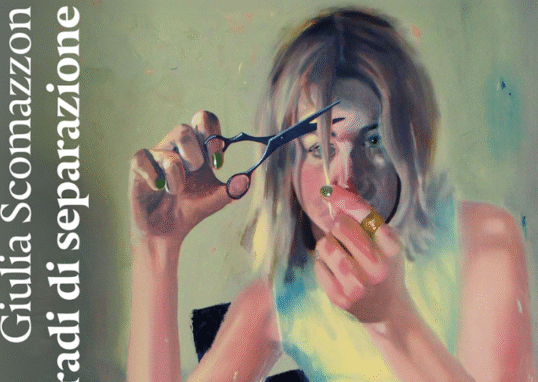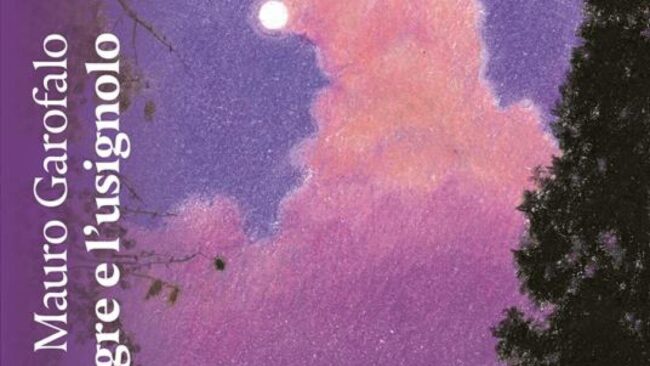
«Venne maggio e Alberto infilò la testa nel cappio e s’impiccò».
Si apre così La tigre e l’usignolo (Nottetempo, 2025) di Mauro Garofalo: una frase, una sentenza, che non è solo uno schianto, secco, ma il racconto di una trasfigurazione in atto, di qualcosa che era e non è più, di un cambiamento – il cambiamento. La morte di Alberto non è un semplice addio, è un passaggio, un ciclo che si compie. Perché nulla finisce davvero: la vita si smembra e si ricompone, la voce dell’assenza si mescola al respiro della foresta, e queste pagine servono a descriverci come tutto continua.
Garofalo, giornalista ambientale e narratore della natura, costruisce un romanzo che non è la storia di un suicidio, ma il racconto di una – molte – metamorfosi, metamorfosi che appartengono anche a noi. E proprio la natura, in questo romanzo, non è ambientazione, non è sfondo, ma organismo pulsante, voce narrante, respiro che avvolge i vivi e i morti, noi. Il bosco non è solo il luogo della fine, è un testimone, una creatura che accoglie e converte: «L’usignolo, che era stato l’ultimo a guardare gli occhi di Alberto spegnersi, cantava adesso da sopra il ramo», quasi riecheggiando il Flauto Magico (1791) mozartiano e il suo eterno dialogo tra luce e oscurità.
Ma la natura come specchio dell’interiorità dei personaggi e la loro perdita sembra anche accostarsi, sul versante cinematografico, all’immaginario di Terrence Malick (Stati Uniti, 1943), soprattutto in The Tree of Life (2011). Nel film, infatti, la natura non è solo un elemento di scenografia, ma una forza primordiale che accompagna il dolore umano, un’entità che osserva e risponde, inscrivendo il destino dei protagonisti in un disegno più grande. Così come Malick alterna immagini cosmiche e visioni naturalistiche alla tragedia familiare, anche Garofalo intreccia la dimensione intima della sofferenza con l’immensità del mondo naturale. Il bosco diventa così testimone e partecipe della vicenda di Alberto, proprio come le onde, gli alberi e la luce mutevole del cielo in The Tree of Life sono specchio di lutto e memoria. Entrambe le opere suggeriscono che, nonostante morte e dolore, la natura continua, riceve e tramuta, offrendo una prospettiva che va oltre l’individuo e si espande nell’eterno ciclo della vita.
Ne La tigre e l’usignolo, è, infatti, la natura a essere protagonista. La foresta non sono alberi, ma una coscienza diffusa, un’entità che accoglie, registra e risponde. L’aria porta parole, i rami si tendono come arti, la luce filtra tra le foglie e si fa racconto. L’idea che tutto sia connesso, che la vita si rigeneri anche nel dolore, ricorda le riflessioni che appaiono in Il sussurro del mondo (R. Powers, La Nave di Teseo, 2019) vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2019, dove gli alberi comunicano, resistono, tramandano storie. E, ancora, il bosco, così come le nuvole ne Il mago dell’aria (M. Garofalo, Mondadori, 2024) diventano elemento vivo che custodisce le tracce di chi lo attraversa. Se nel romanzo precedente il protagonista si perde, appunto, nell’aria per riscoprire se stesso, qui, gli alberi assorbono Alberto e lo restituiscono alla terra in una nuova forma. La natura non giudica, non punisce: ospita, cambia, immortala.
Ma se la foresta ascolta, il nostro mondo, quello degli uomini, quello dove le orecchie si vedono, no. La storia di Alberto è anche quella di un’epoca che ha preferito cancellare la fragilità, dove è meglio non lasciare spazio all’errore. Il protagonista incarna il senso di inadeguatezza di una generazione soffocata dalle aspettative, dall’ossessione della prestazione: «Non si resiste. Fingi. Ti dai obiettivi. E non succede niente. Non vali mai niente». Viviamo in una società che ci impone di performare, di esibirci nei nostri successi, di dimostrare il nostro valore attraverso risultati tangibili. Chi fallisce viene dimenticato, chi si ferma viene superato. Garofalo non edulcora questa realtà, la incide con parole nette, brutali.
Il suo stile non concede pietà: è essenziale, tagliente, senza retorica e, in questo, il romanzo sembra avvicinarsi a Stoner (J. Williams, Fazi editore, 2012), dove il fallimento non è eroico ma ordinario, e alla freddezza esistenziale de Lo straniero (Bompiani, 1947) di Camus. La differenza è che, in Garofalo, i protagonisti non sono soli, non vengono abbandonati: la natura li circonda, li raccoglie, è pronta a restituirgli una vita anche dopo la morte.
Uno degli aspetti più affascinanti del romanzo è la sua struttura corale. La storia non appartiene solo ad Alberto, il protagonista: il tempo si espande, si frammenta, si fa molteplice. Parlano i vivi, parlano i morti, parla il bosco. Questa polifonia richiama Lincoln nel Bardo (G. Saunders, Feltrinelli, 2017), con voci che si sovrappongono, creando una narrazione stratificata in cui il confine tra vita e morte si dissolve. Garofalo, qui, ci ricorda che l’esistenza non è lineare, che la memoria non segue un ordine cronologico. La storia di Alberto – così come la nostra – non si conclude con l’ultimo respiro, si riverbera nei ricordi, nelle parole di chi lo ha conosciuto, nell’eco della natura che lo avvolge.
Viene, allora, da chiedersi: ma alla fine, cosa resta? Il corpo di Alberto è ormai parte degli alberi, il vento che porta via le sue ultime parole. Eppure, Garofalo non ci lascia con un senso di vuoto assoluto. Non c’è redenzione, ma nemmeno una totale disperazione. La trasformazione continua. La morte non è solo assenza, ma passaggio. C’è un qualcosa, un qualcuno che resta, un bosco, la natura che continuano a sussurrare, a raccontare le loro e le nostre storie.
La tigre e l’usignolo è un romanzo che lascia un segno profondo, non solo per la sua forza emotiva, ma per la sua capacità di guardare oltre la tragedia individuale e inserirla in un disegno più grande. Non offre risposte facili, non consola, ma apre uno spazio di riflessione in cui il lettore non può fare a meno di domandarsi: cosa resta di noi dopo che ce ne siamo andati? Forse una voce nel vento. Il battito d’ali di un usignolo, forse. O, più semplicemente, un intreccio di silenzi e suoni, di assenze e presenze che ci ricordano che, nonostante tutto, siamo circondati da una fragile bellezza.
Ilaria Padovan nasce a Pavia nel 1990 e lavora in consulenza a Milano. Suoi racconti sono comparsi su «Topsy Kretts», «Crunched», «Risme», «Turchese», «Grado Zero», «Yanez»., «Pastrengo», «Wertheimer», «Gelo». Si è classificata terza a «8×8, si sente la voce 2024». Ha tradotto dall’inglese per «Turchese». Collabora con Treccani, Il Tascabile, The Vision e Limina.