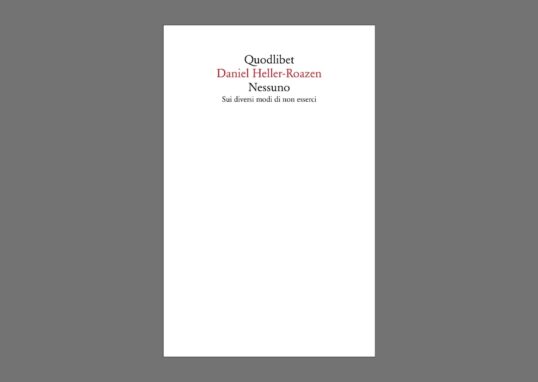Foto di Aldebaran S su Unsplash
Esistiamo in un’effimera fioritura di vita e sapere,
fugace come uno schiocco di dita, e poi basta.
Un’esplosione estiva, più bomba che germoglio.
I tempi fecondi si muovono in fretta.
(Samantha Harvey, Orbital)
«L’architettura mi è sempre
sembrata, di base, un po’ come credersi dio. Un desiderio di
costruirsi il proprio mondo. Ma guarda qui», e ha indicato
le colonne che si estendevano tutto intorno a noi. «Se c’è un
dio, qui, appartiene alla sabbia»
(Emeth North, Negli universi)
La prima cosa che salta quando si osserva l’universo è la percezione del tempo come comunemente lo si considera: “il tempo non è né un fiume né una freccia”, scrive Emet North in Negli universi, tra i migliori romanzi fantasy e fantascientifici del 2024 secondo il The New York Times, pubblicato da Mercurio nel 2025 nella traduzione di Chiara Reali. Il tempo è “una dimensione, e le nostre vite si espandono al suo interno, ciascuno di noi in una forma quadridimensionale che prende un minuscolo spazio nell’universo. Tutti i momenti esistono contemporaneamente e per sempre.” Negli universi è un romanzo che sfida la concezione lineare del tempo per esplorare tutti i mondi possibili: “Se l’universo è fatto di moltitudini che si sovrappongono all’infinito, mille milioni di ramificazioni possibili, perché facciamo esperienza della vita come di una cosa sola?” si domanda la protagonista, Raffi, astrofisica in un laboratorio di cosmologia della NASA.
“Lo spazio fa a pezzi il tempo”, nota Samantha Harvey in Orbital, romanzo vincitore del Booker Prize 2024, pubblicato da NNE nel 2025 nella traduzione di Gioia Guerzoni, e non a caso la scrittrice inglese lo paragona a una “pantera, selvatica e primordiale”. Gli astronauti e cosmonauti protagonisti del libro, se non vogliono essere inghiottiti dall’universo, devono fare attenzione a non perdere il conto dei giorni. Solo così possono contrastare la “metrica arbitraria del tempo” percepita in orbita:
Siamo in mezzo a un universo di collisioni e derive, le lunghe lente increspature del primo Big Bang mentre il cosmo si disgrega, le galassie più vicine si scontrano, quelle rimaste si disperdono finché ognuna è sola e c’è soltanto lo spazio, un’espansione che si espande in se stessa, un vuoto che dà la luce che si accende per un attimo e poi si spegne di nuovo, un unico giorno a metà dell’anno, e nulla che lo ricordi.
In entram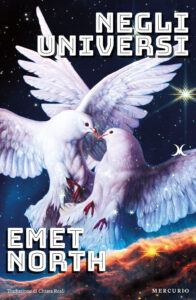 bi i romanzi l’osservazione dell’universo rappresenta un momento imprescindibile per meditare sulla nostra effimera esistenza, e sondarne il mistero. La riflessione filosofica, filtrata dalla lente della letteratura, è da subito centrale in Orbital come in Negli universi, sebbene le direzioni prese da ciascun libro siano differenti dal punto di vista “filosofico” ed estetico, diverse le visioni del mondo che i due libri veicolano e le scelte stilistiche a cui approdano: Negli universi è mosso dall’urgenza di aggiungere mentre Orbital dalla necessità di levare. Così in Negli universi North moltiplica le trame e insieme le decostruisce, in un continuo oscillare tra fare e disfare, mentre in Orbital l’unica trama che Harvey può tessere è quella suggerita dalle toccanti descrizioni del nostro pianeta visto dall’alto – tra l’altro magnificamente tradotte da Guerzoni – che spezzano i pensieri e i ricordi degli uomini e delle donne sospesi nello spazio:
bi i romanzi l’osservazione dell’universo rappresenta un momento imprescindibile per meditare sulla nostra effimera esistenza, e sondarne il mistero. La riflessione filosofica, filtrata dalla lente della letteratura, è da subito centrale in Orbital come in Negli universi, sebbene le direzioni prese da ciascun libro siano differenti dal punto di vista “filosofico” ed estetico, diverse le visioni del mondo che i due libri veicolano e le scelte stilistiche a cui approdano: Negli universi è mosso dall’urgenza di aggiungere mentre Orbital dalla necessità di levare. Così in Negli universi North moltiplica le trame e insieme le decostruisce, in un continuo oscillare tra fare e disfare, mentre in Orbital l’unica trama che Harvey può tessere è quella suggerita dalle toccanti descrizioni del nostro pianeta visto dall’alto – tra l’altro magnificamente tradotte da Guerzoni – che spezzano i pensieri e i ricordi degli uomini e delle donne sospesi nello spazio:
Sull’orlo di un continente la luce sta svanendo. Il mare è una distesa piatta e color rame di Sole riflesso e le ombre delle nuvole si allungano sull’acqua. L’Asia arriva e scompare. L’Australia è una sagoma scura e informe in quest’ultimo soffio di luce, che ora è diventata platino. Tutto si sta oscurando. L’orizzonte terrestre, spalancato di luce in un’alba così recente, sta sparendo. La linea perde nitidezza nell’oscurità, come se la Terra si stesse dissolvendo, e il pianeta diventa viola e sembra sfocato, un acquerello che perde colore.
La protagonista del romanzo di North trascorre le sue giornate in laboratorio a rimuovere stelle da immense immagini del cielo notturno alla ricerca della materia oscura: “c’è qualcosa per cui valga più la pena rendersi infelici che capire l’universo intero?” domanda Raffi all’amico Caleb che non comprende la sua ostinazione a continuare un lavoro che la fa soffrire.
Caro Caleb, forse se riuscissi a capire la materia oscura e il cielo di notte capirei anche come fare a uscire dal letto la mattina.
Ma il tentativo disperato di Raffi di stabilire un nesso tra la propria esistenza e quella dell’universo naufraga continuamente tanto da indurla ad abbandonare il lavoro di astrofisica: “Questa ricerca mi ha aiutata a capire che forse una carriera da filosofa è più adatta a me”, scrive nella mail di congedo indirizzata al suo professore.
Adesso non le resta che inseguire l’amica e artista Britt, di cui nel frattempo si è innamorata, in tutti gli universi possibili, mondi paralleli che scandiscono a mo’ di capitoli il romanzo, indipendenti e nel contempo collegati tra di loro dentro una struttura caleidoscopica.
Anche in Orbital non ci sono veri e propri e capitoli, bensì sedici orbite, quelle percorse intorno alla Terra da quattro astronauti (americano, giapponese, inglese, italiano) dentro una grande H di metallo: due donne e quattro uomini per “nove mesi a fluttuare” intorno a Madre Terra: “provano la sensazione di essere tornati piccoli, all’infanzia. Al di là del vetro la genitrice li guarda, maestosa e onnipresente.”
Se nel romanzo di Harvey è impossibile distogliere lo sguardo dal “magnetismo blu, sempre emozionante, della Terra”, in quello di North distogliere lo sguardo è un movimento necessario per le storie che si intrecciano nel libro:
Cara Britt – scrive Raffi in uno degli immaginari incipit indirizzati all’amica – un professore una volta mi ha detto che ci sono cose nell’universo che si possono trovare solo distogliendo lo sguardo. Non è una cosa bellissima da dire, bellissima e assurda?
 Il libro prende una forma diversa da quello ci saremmo aspettati dal titolo e dalla lettura delle prime pagine … L’espressione “negli universi” è usata più nella sua accezione simbolica, nonostante North abbia lavorato davvero in un laboratorio di Cosmologia osservativa con una borsa di studio della NASA. Mentre in Orbital le “storie” dei protagonisti sono immerse nella descrizione dell’universo, in Negli universi il discorso “scientifico” è solo un input: tutto ruota poi intorno all’instancabile ricerca di mondi (e di corpi) altri in cui abitare. Ecco allora che la prolificazione di storie e il surplus di immagini e parole che riempie le pagine di Negli universi, sebbene possano risultare a tratti eccessivi, restituiscono il disperato tentativo di Raffi di controllare il tempo:
Il libro prende una forma diversa da quello ci saremmo aspettati dal titolo e dalla lettura delle prime pagine … L’espressione “negli universi” è usata più nella sua accezione simbolica, nonostante North abbia lavorato davvero in un laboratorio di Cosmologia osservativa con una borsa di studio della NASA. Mentre in Orbital le “storie” dei protagonisti sono immerse nella descrizione dell’universo, in Negli universi il discorso “scientifico” è solo un input: tutto ruota poi intorno all’instancabile ricerca di mondi (e di corpi) altri in cui abitare. Ecco allora che la prolificazione di storie e il surplus di immagini e parole che riempie le pagine di Negli universi, sebbene possano risultare a tratti eccessivi, restituiscono il disperato tentativo di Raffi di controllare il tempo:
Ci piace immaginare che causa ed effetto siano lineari, che mentre il passato può influenzare il futuro, il futuro non ha il potere di cambiare il passato. Ma ho sempre creduto che questa – così come la nostra esperienza della vita come una, anziché infinita diramazione – è una questione di percezione, un limite della nostra coscienza, non un riflesso della nostra realtà.
“Chi decide cosa è possibile?” è la domanda che rimbalza nel libro fino alla fine. Con un parallelo tra scrittura e architettura che ritorna più volte nel romanzo, North afferma che “definire qualcosa come impossibile è porre limiti alla nostra immaginazione. Il lavoro di un architetto – di qualunque artista – è cercare modi per vedere al di là dei nostri limiti.” E Raffi vuole valicarli i limiti – in questa direzione si può leggere l’invito di Shannon Winnubst in esergo a “queerizzare i nostri mondi”– ; Raffi si catapulta in altri mondi per inseguire Britt (non è l’amore stesso un catapultarsi in mondi im–possibili?), per abbracciare la libertà e scoprire sé stessa, ma anche nella speranza di riuscire a elaborare tutte quelle perdite che nella vita ciascuno di noi si trova affrontare.
Cammina e pensa a com’è sopravvissuta a ogni perdita a cui aveva pensato di non sopravvivere. È sopravvissuta e la sua sopravvivenza è un miracolo e il miracolo è una crudeltà. Una crudeltà: il modo in cui un corpo è in grado di persistere, il modo in cui il cuore fa circolare il sangue e i polmoni risucchiano l’aria e l’intera macchina continua a funzionare, nonostante tutto.
Il tema della perdita attraversa anche Orbital, ma al contrario di Negli universi in cui la perdita è vissuta drammaticamente tanto da essere rifiutata da Raffi, nelle pagine di Harvey è come se fosse attutita dal dondolio della navicella e dello stesso universo: che cos’è la morte, e di nuovo che cos’è il tempo quando fluttuiamo nello spazio e mettiamo il piede su un corpo roccioso che non è la Terra? Orbital ci invita a praticare la distanza:
Probabilmente è un’idea infantile, ma forse, allontanandosi abbastanza dalla Terra, si riuscirebbe finalmente a capirla, a vederla come un oggetto, un puntino azzurro, una cosa cosmica e misteriosa. Non per capirne il mistero, ma per capire che è misteriosa.
Capire che è misteriosa significa anche accettarne il mistero, mistero della nascita e della morte, ovvero della nostra esistenza che è una delle tante forme possibili dell’esistenza, ma non l’unica.
Quando all’astronauta Chie viene comunicata la morte della madre sulla Terra, la distanza spazio– temporale le fa percepire la morte come qualcosa di irreale, impossibile:
Solo quando tornerà sua madre sarà morta; come nel gioco delle sedie, quando c’è una persona di troppo ma finché la musica va il numero di sedie è irrilevante, nessuno ha perso ancora. Mai fermarsi. Bisogna continuare a muoversi. In questa gloriosa orbita sei a prova di impatto e niente può toccarti. Quando il pianeta galoppa nello spazio e tu gli galoppi dietro nella luce e nel buio con il cervello ebbro di tempo, nulla può finire. Non ci può essere una fine, soltanto cerchi.
Leggendo Orbital Harvey ci chiede di spostare continuamente lo sguardo come accade nel quadro Las meninas di Velázquez rappresentato nella cartolina che uno degli astronauti, Shaun, si è portato con sé nella spedizione e che ora fluttua insieme a lui dentro alla navicella: “chi guarda chi?” è la domanda che ci si pone osservando il quadro, ma anche leggendo Orbital.
In questo andirivieni di sguardi è racchiuso un segreto imperscrutabile con cui dobbiamo misurarci se non vogliamo rimanere prigionieri delle nostre storie.
Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.