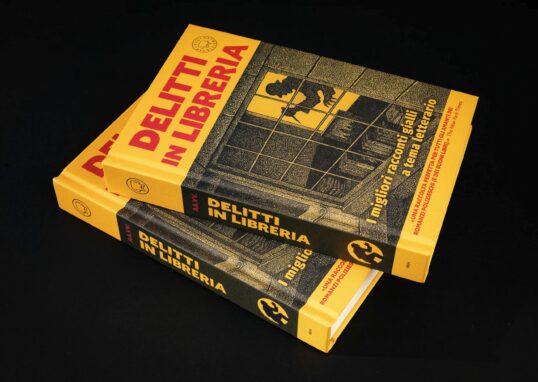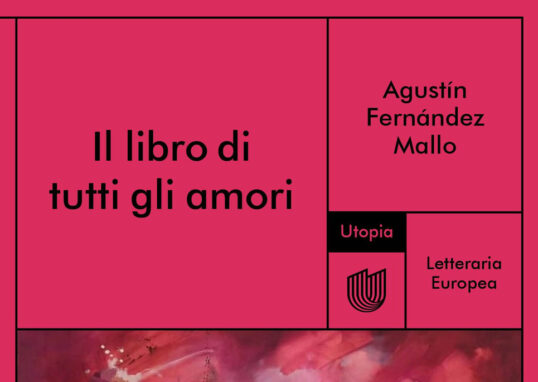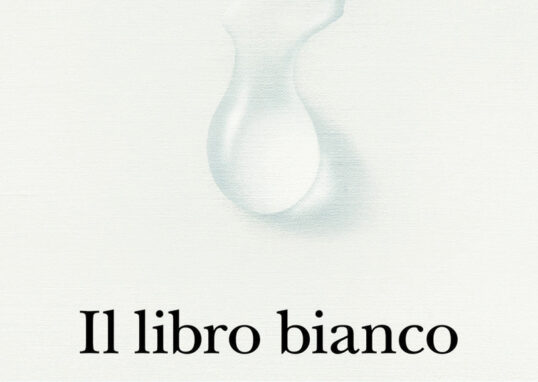di Ilaria Padovan
Un’ossessiva delicatezza può ferire per sempre. E quelle di Kate Zambreno sono carezze capaci di scavare più di un coltello. Non stupisce che il suo Eroine (Nottetempo, 2025), pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012 da Semiotext(e) non sia stato accolto con indifferenza, ma che, anzi, la sua scrittura intesa come atto di rivolta sembri aver ripetuto gli stessi cicli di accoglienza e respingimento di quella esplorata all’interno delle sue stesse pagine.
Assale, Zambreno. Si scaglia contro una tradizione che si rifiuta di riconoscere così come quella stessa tradizione ha rifiutato le compagne degli scrittori modernisti, riducendole, piuttosto, a fragili, isterici corpi, inadatti a quello ciò che possa essere considerata produzione letteraria seria. Sembra di sentire riecheggiare la Virginia Woolf (Londra 1882 – Rodmell 1941) di Una stanza tutta per sé (Il Saggiatore, 1963): l’idea che la scrittura femminile sia sempre stata ostacolata, negata, riletta attraverso una lente che ne minimizza la portata.
Se Woolf si chiedeva cosa sarebbe accaduto a una ipotetica sorella di Shakespeare, altrettanto brillante ma priva di spazio per esprimersi, Zambreno risponde con un catalogo di donne la cui voce è stata soffocata, la cui rabbia è stata patologizzata, la cui scrittura è stata considerata marginale rispetto a quella degli uomini con cui condividevano la vita. E, rinnegando quella tradizione, l’autrice sembra diventare uno degli stessi personaggi della propria opera, sospesa, ma mai sbilanciata, tra memoir e critica letteraria. Testimoniarlo ancora, ancora, e ancora, non importa in quale secolo, non importa in quale corrente letteraria è un graffio persistente che si percepisce sotto la pelle, dentro i polsi. E non è qualcosa che si scioglie. Non se ne va. Perché ridurre vite come quelle di Zelda Fitzgerald, Jane Bowles, Jean Rhys, per citarne alcune, al loro destino di muse, di fantasmi, di donne ridotte a note a piè di pagina nella storia letteraria non può, non deve lasciarci indifferenti.
Eroine si colloca dal lato opposto all’imperturbabilità grazie anche al suo stile viscerale, inizialmente descritto dalla critica della prima edizione come “troppo personale, troppo esibito, troppo emotivo”. Ma non è esattamente la stessa tipologia di critica che Zambreno stessa testimonia quando evidenzia che ad Amleto è concesso «lasciarsi travolgere dalla disperazione, per quanto eccessiva sia, perché viene intesa […] come esistenziale», mentre «Ofelia è quella che piagnucola e si lagna e affoga in un dito d’acqua […] Per Ofelia non c’è nulla di oggettivo. Ogni cosa è così tremendamente soggettiva»? Sheila Heti, autrice canadese e amica di Zambreno, commentò che il libro non aveva “la voce misurata di chi può contare di essere ascoltato, ma il lamento di chi è confinato in una baracca.” Eroine è la testimonianza contemporanea che, seppur in un’epoca contrassegnata da un gran parlare di diversity, equity, inclusion, esporre il proprio dolore senza la freddezza della critica accademica, venga ancora visto come un atto eccessivo, come qualcosa di poco serio. Ecco perché questo è e deve essere considerato un testo fondamentale per qualsiasi generazione di lettore, perché i frammenti dell’autrice sono quelli di tutti, perché le rovine di cui parla sono nostre, le nostre («Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine»).
Un aspetto tristemente affascinante di Eroine è il rapporto tra scrittura e ambiente circostante. La sua scrittura si trasforma in un atto di resistenza contro il caos quotidiano («Sto cercando di imparare a essere una scrittrice seria e scrivere libri importanti, eppure tutto quel silenzio non lo sopporto» e ancora «In genere nel silenzio mortale di tali ambienti provo un maggior senso di alienazione»). A causa dell’intera struttura dell’opera, del suo stile frammentato e appassionato – che mi ricorda da vicino quello di Maggie Nelson in Bluets (Nottetempo, 2023) – in un flusso che mescola il personale e il teorico, il dettaglio intimo e la riflessione universale, di questo scomporsi e ricomporsi del piano della realtà di Zambreno e di quello delle donne di cui parla, andiamo oltre alla tematica già affrontata anche da Woolf in Una stanza tutta per sé sulla difficoltà di conciliare vita e scrittura: ci muoviamo in un terreno desolato – e desolante – in cui Zelda Fitzgerald e Vivienne Eliot risultano più vere del compagno dell’autrice.
Il distacco da una certa tradizione, da certi ambienti, da certi autorevoli personaggi innesca l’inevitabile sovrapposizione con tempi e figure altre che veramente sono vicine, ma per le peggiori ragioni possibili. È una rabbia che non esplode quella di Zambreno al trovarsi di fronte a una verità che non è indicibile ma che non si vuole dire: si infiltra. Questa assenza di confini tra protagonisti e personaggi è la stessa presente in Wilmo, ricorda (M. Angelini, Super Tramps Club, 2024): qui, il protagonista ha un bisogno così viscerale di “essere insieme” nonostante la sua malattia, la sua scordanza, da ritrovarsi sempre e solo in compagnia dei personaggi inesistenti delle opere letterarie che più ha amato. Trovo sconsolante trovare punti di contatto tra una scrittrice e un malato di Alzheimer: una somiglianza nell’essere soli. Nell’essere lasciati al margine.
La riedizione di Eroine negli Stati Uniti e la sua traduzione italiana arrivano in un momento in cui il panorama letterario sembra più che mai diviso tra omologazione – testi che rientrano in categorie di marketing riconoscibili – e nuove spinte sperimentali – libri radicali che nascono al margine di realtà indipendenti, nei blog, nei sottoboschi della critica online – e ci obbliga a fare i conti con il modo in cui leggiamo la letteratura femminile. Ci spinge a chiederci perché debba sempre dimostrare di avere uno scopo, una morale, una funzione emancipatoria? Perché non può semplicemente esistere, nella sua contraddittorietà e nel suo caos, come fanno da sempre i romanzi maschili?
Non siamo di fronte a un’ingiustizia passata, ma un problema strutturale purtroppo ancora contemporaneo. «Al principio, penso ai finali» scrive Zambreno. Forse, quando abbandoneremo il pregiudizio di un immaginario definito di cosa significhi essere un’autrice e le sue opere riusciremo a non farlo più. A lasciare le storie essere solo storie, con la libertà di evolversi, di far evolvere noi.
Ilaria Padovan nasce a Pavia nel 1990 e lavora in consulenza a Milano. Suoi racconti sono comparsi su «Topsy Kretts», «Crunched», «Risme», «Turchese», «Grado Zero», «Yanez»., «Pastrengo», «Wertheimer», «Gelo». Si è classificata terza a «8×8, si sente la voce 2024». Ha tradotto dall’inglese per «Turchese». Collabora con Treccani, Il Tascabile, The Vision e Limina.