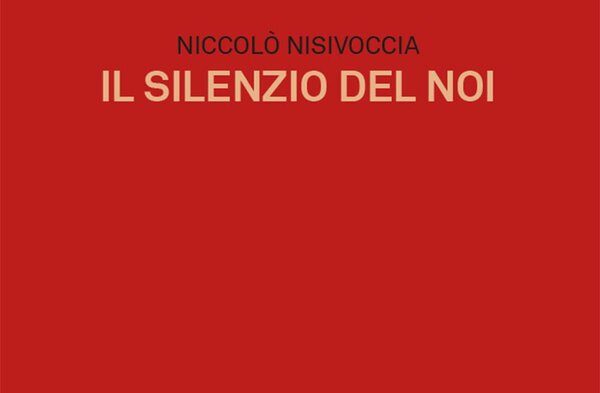
di Matteo Bianchi
«La tragedia non è essere soli, ma non poter esserlo. A volte darei tutto per non essere più legato in modo alcuno al mondo degli uomini, ma io sono parte di quel mondo e la scelta più coraggiosa è di accettarlo, e accettare contemporaneamente la tragedia». Le parole grevi quanto oneste di Camus rivelano che si può essere solitari e solidali al tempo stesso, alla maniera di Niccolò Nisivoccia nel suo nuovo pamphlet filosofico, Il silenzio del noi (Mimesis, 2023, pp. 90, euro 8), che prova a dare un senso al silenzio sconfortante da cui si sente circondato. La lectio si focalizza sul passato condiviso, ma nasce da una constatazione sul presente: il “noi” odierno è tacito, quale dimensione collettiva soppiantata da un io sempre più sconfinato. C’è poi il “noi” come oggetto, come dimensione costitutiva del silenzio, destinato a perdere la sua stessa ragione d’essere. L’autore lo vive quanto uno spazio in cui le parole altrui possano essere ricevute e trasformate in parole nuove, che gli altri possano vedersi restituite. Eliminando progressivamente la dimensione del “noi” e la consapevolezza che l’accompagna, questo valore relazionale viene meno per definizione.
Il capitolo iniziale si apre con l’immagine di un bimbo che cammina mano nella mano con un papà silente nei giorni della morte di Aldo Moro. Se tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta i padri parlavano molto meno di quanto facciano quelli di oggi coi loro figli, confronti e discussioni tra generazioni contigue erano all’ordine del giorno, e il “noi” riusciva ad avvolgere tutte le sfaccettature dei singoli “io” che lo costituivano.
La scomparsa progressiva delle ideologie ha lasciato un vuoto che la società non è stata in grado di giustificare, se non con l’esasperazione degli individualismi. La legislazione attuale, che è la materia di professione per Nisivoccia, membro del Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia, è caratterizzata dalla sovrabbondanza: vengono emanati decreti per qualsiasi cosa, poiché chiunque ambisce a una legge per sé. I diritti civili si stanno riducendo a pretese fomentate dalla presunzione di credere che il proprio io coincida con quello di tutti, che la complessità del reale possa essere ridotta alla misura del singolo.
Da qui il discorso si incrocia, almeno in parte, con le considerazioni di Tommaso Greco, che ha sostenuto con Nisivoccia allo scorso Piccolo Festival della Fiducia, a Pisa, espresse ne La legge della fiducia (Laterza, 2021), in cui il filosofo del diritto denuncia l’assenza, sempre più clamorosa, di una visione del diritto ispirata a logiche correlative. E Nisivoccia concorda con questa dimensione esclusivamente verticale della normativa, come se potesse riguardare solo i rapporti tra i cittadini e l’autorità; come se la Legge potesse solo calare dall’alto, al pari di una punizione, o meglio, di una sanzione nei confronti dei suoi destinatari; come se il diritto dovesse avere solo una natura intimidatoria, e non potesse esistere al di fuori di essa; come se alle norme si dovesse obbedire solo per timore di subire le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, e come se, davanti alla scelta tra obbedire o meno, ciascuno fosse chiamato a fare i conti solo con se stesso. Il discorso, in sostanza, resta il medesimo: ciascuno da sé e ciascuno per sé, tutti contro tutti. È come se non si riuscisse più neppure a concepire una dimensione alternativa dei rapporti: orizzontale anziché verticale, plurale anziché solipsistica e conflittuale. D’altronde, Greco è cristallino nel suo condannare un sistema fondato sulla competizione: «L’idea che sembra guidarci è che, quando abbiamo a che fare con il diritto, mettiamo (dobbiamo mettere) da parte la fiducia che nutriamo nei confronti degli altri, e, anzi, è proprio perché non ci fidiamo degli altri che ci rivolgiamo al diritto e alle sue soluzioni». E, non a caso, il filosofo propone la costruzione di un diritto votato alla “fiducia” reciproca, che non presupponga necessariamente la conflittualità, ma che al contrario sappia includere la solidarietà.
A seguire, Nisivoccia elenca i sintomi che confermano la malattia in cui versa l’individuo del ventunesimo secolo: la cura consisterebbe nel trovare un nuovo orizzonte di riferimento in cui i gesti di ognuno possano proiettarsi verso un futuro corale, divenendo insieme qualcos’altro. Il silenzio del noi esprime la necessità di un sentimento laico di fraternità esemplificato per mezzo di «tre dispositivi di resistenza possibile», definiti da Adolfo Ceretti.
Il primo è la poesia, la forma prediletta dall’autore in cui la tensione tra silenzio e parola – tra bianco e nero sia decisiva verso una conciliazione, un equilibrio tra l’individuo e la realtà, tra ciò che sta dentro l’essere umano e ciò che sta fuori. Dopo la poesia, un esempio di dispositivo relazionale che analizza l’autore è il silenzio che ha dato forma al celebre incontro avvenuto a New York, nel 2010, tra Marina Abramović e Ulay nel corso di “The artist is present”. La performance consisteva in un’attesa: l’artista trascorreva sette ore al giorno seduta su una sedia davanti a un tavolo spoglio, al quale i visitatori potevano sedersi a turno, uno alla volta, rimanendo in silenzio di fronte a lei per qualche istante. Inaspettatamente al tavolo comparve Ulay. I due avevano vissuto un’intensa storia d’amore, ma non si vedevano da oltre vent’anni: e quei pochi minuti nei quali si ritrovarono per la prima volta dopo quattro lustri, dentro le rispettive pupille, non successe alcunché, ossia tutto ciò che doveva succedere tra due persone che sentivano di colmare un’assenza incalcolabile interiormente, una mancanza infinita. Furono minuti irripetibili, nei quali «il silenzio raccoglie tutte le parole che avrebbero mai potuto essere dette, facendole proprie senza pretendere di dirle subito. È un silenzio che somiglia quasi a un patto, a una promessa», specifica Nisivoccia. Il terzo esempio combacia con la condizione che ha reso possibile l’esperienza testimoniata da Il libro dell’incontro (Il Saggiatore, 2015), proprio a cura di Ceretti, di Claudia Mazzucato e Guido Bertagna. I tre autori hanno promosso una serie di incontri tra le vittime e i responsabili della lotta armata in Italia negli anni Settanta, mettendoli le une davanti agli altri. Per la prima volta qualcuno ha sfidato qualsivoglia ritrosia o rischio di remora, concretizzando l’intenzione di offrire ai protagonisti di un brandello doloroso di storia un’occasione per provare a ricomporlo insieme, faccia a faccia, sul modello dell’operato della Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione alla fine dell’apartheid. I colloqui contenuti ne Il libro dell’incontro hanno squarciato un velo nella nostra memorialistica della militanza radicale di allora e non sarebbero stati possibili senza un silenzio che accogliesse, da ambo le parti coinvolte e contese, le posizioni dell’altro. E l’investimento sull’altro, lo slancio di un dono intangibile di il filo rosso che collega i tre “dispositivi”, abbandonando l’aspettativa di essere ricambiati; poiché l’apertura disinteressata alla relazione con il prossimo si realizza nell’incertezza di andare oltre le proprie insicurezze, i propri irrisolti.
Nisivoccia, infine, abbraccia un concetto appreso da un ragazzo senegalese, ricevuto da un bacino culturale lontano, oltremare, e con radici persino recise dal dominio coloniale dell’Occidente. Eppure si espande tra le pagine dell’autore il concetto di “teranga”: l’ospitalità nell’accezione di gioia di ospitare, a prescindere da qualunque usanza o etichetta sociale, da qualunque ansia di restituzione. Una gioia in sé, che non chiede niente in cambio per essere tale.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






