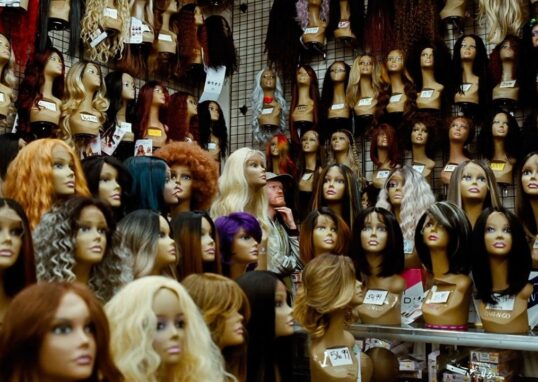Pubblichiamo un articolo uscito su Linus, che ringraziamo.
Nel cuore di una notte buia e tempestosa, in pieni anni cinquanta, un adolescente di Toronto, svegliandosi da sogni inquieti, sguscia fuori dal suo letto.
Ad attrarlo come un magnete è la televisione. Sullo schermo del nuovo totem domestico, qualche ora prima, ha assistito alla quotidiana fine delle trasmissioni. Si è subito addormentato, cullato come ogni sera dal ticchettìo della macchina da scrivere di suo padre, giornalista e scrittore, e dalle sonate della madre pianista.
Poi, nella bergmaniana ora del lupo, il risveglio improvviso, causato dall’ossessione morbosa del momento: il tubo catodico.
Avvolto dal buio del salotto, accende il televisore e preme freneticamente sui tasti, compulsando i canali più remoti. Quando i numeri arrivano a tre cifre, gli sembra di captare forme di vita, alieni provenienti da altri fusi orari, segni di mondi paralleli e lontanissimi. Dietro gli occhialoni, stringe gli occhi azzurrissimi e miopi: in quei grumi bianchi e fruscianti come neve elettronica, intravede ombre umane. Senza sonoro, forse provenienti da oscure emittenti newyorchesi: lampi muti di un’America vicinissima e remota, in cui ribolle un underground inquieto, molto distante dall’austerità canadese. Corpi che fluttuano, impegnati in azioni forse erotiche, o addirittura violente, di certo misteriose. Quasi da decifrare con gli occhi della mente.
Per David Cronenberg, così si chiama l’adolescente insonne di Toronto, è un momento seminale. In quell’oscurità notturna, silenziosa, illuminata da intermittenze criptiche, viene alla luce il presagio del suo cinema, il suo personale Videodrome, gigantesco, inesausto palinsesto, coerente nelle sue variazioni. A cui presto si aggiungerà un altro titolo: avvicinandosi agli ottant’anni, il ragazzo dell’Ontario sta rifacendo uno dei suoi primissimi film, Crimini del futuro. Girato mezzo secolo fa, il film presenta rozzezze di sapore underground, come l’assenza dell’audio in presa diretta, a causa del rumore della Bolex. Lacuna trasformata in linguaggio, con i monologhi interiori del protagonista montati con libertà godardiana su inquadrature di composizione concettuale, alla Antonioni, e spiazzamenti di senso alla Bunuel: tutti maestri divorati nei cinema di Toronto.
Ci sono già tutti i sintomi del Cronenberg a venire: precocemente vocato alla distopia, racconta di una pandemia, causata dall’uso di cosmetici, capace di sterminare tutte le donne che hanno superato la pubertà. Il corpo patologico è già strumento e oggetto di indagine, tra fobie, contagi, mutazioni e aberrazioni sessuali. Fioccano perversioni, associazioni esoteriche, guru carismatici, feticismi, incerte identità sessuali, e secrezioni organiche dense di sottintesi.
L’ironia già obitoriale affiora dai nomi patafisici dati a enti medici: Casa della pelle, Istituto delle malattie neovenere e e Gruppo Oceanico Podologico
C’è tutto il suo armamentario, per quanto ancora rozzo: quanto basta per connotarlo come un corpo estraneo, nel mondo del cinema. Il Canada, per lui, è uno stato fisico e mentale, un set che abbandonerà difficilmente, solo da maturo. Una condizione che lo colloca nel guado, sospeso tra la fiammeggiante brutalità industriale di Hollywood e l’introspettiva autorialità europea. Scava, dagli esordi, un cunicolo tutto suo, buttandosi sullo scaffale dell’horror, genere che si presta alle metafore che gli pulsano in testa. Chiare e dirette, ricreabili con budget bassi. Eversive, perché l’horror agisce sulle viscere e sull’inconscio, e permette di creare immagini forti, destinate ad incidersi nella memoria collettiva.
Lo ha dimostrato George A. Romero, con il suo personale sessantotto, aperto da cortei di morti viventi, sbucati dalle tombe con passi incerti e occhi tetri, pieni di appetiti cannibali e contagiosi. Interpretabili come l’allegoria sinistra di vite vuote e ripetitive come la morte, oppure dello scempio in corso in Vietnam. O della ferocia razzista, della fobia per i diversi e per i dannati della Terra, da appianare a colpi d’arma da fuoco. I loro corpi decomposti contengono tutto questo, senza doverlo esplicitare, facendo esplodere l’immaginario e i botteghini. Sulla scia di Romero, Wes Craven, Tobe Hooper, ma con una sua distinta specificità, Cronenberg costringerà Hollywood a rivedere le regole del genere, riponendo nei bauli i costumi degli horror tardoromantici. Degli adattamenti cormaniani dei racconti di Poe, con Vincent Price a fare il villain gigionesco, tra pozzi, pendoli e maschere della Morte Rossa. L’orrore di Cronenberg parte dal quotidiano, da una gelida, familiare contemporaneità, che svela gradualmente la sua essenza mostruosa, i suoi demoni sotto la pelle.
Io faccio un cinema apparentemente naturalistico. I miei non sono film di mostri in senso stretto, ma il mostro è il nostro corpo, la nostra esistenza
I suoi primi horror, risalenti agli anni settanta, partono da una messinscena minimale, favorita dalle ristrettezze produttive. Le tracce più profonde che hanno lasciato sono le immagini dei corpi. Ulcerati, deformati, costellati di strane escrescenze, ornati di protesi meccaniche, di orifizi verosimili quanto improbabili. Fotogrammi che feriscono, come i quadri di Francis Bacon. Il corpo è sempre inquieto, dalla forma instabile, ultimo precario appiglio di un’identità spesso indeterminata. Disorientato da una sessualità fatalmente perversa, violenta ed invasiva come una malattia. Minato da devianti energie cerebrali: lunghi stati di coma illuminano dolorosamente la mente, aprendola a squarci di futuro. Eccessi di telepatia dissaldano i crani, disperdendo la materia cerebrale. Tutto è organico, anche i manufatti umani.
In particolare gli oggetti tecnologici, dalla macchina da scrivere, alle automobili, agli apparecchi televisivi, sono corporeizzati, riprodotti come organismi viventi. La stessa ossessione del cinema, per Cronenberg, è partita dall’apparato delle sue attrezzature. I macchinari, le macchina da presa, le luci, i registratori, per lui non sono neutri: lo attirano feticisticamente, quasi più dei film in sè. Ancora giovanissimo, se ne fa spiegare minuziosamente il funzionamento. E’ in grado di smontare e rimontare tutto: è il suo modo di capirne a fondo il funzionamento dei marchingegni, di afferrarne le simmetrie e gli equilibri interni. Li studia come opere d’arte: è il suo modo di scoprire quanto esprimano, e rispecchino, la coscienza umana di chi li ha creati. Lettore bulimico, si laurea in lingua e letteratura inglese.
La magrezza e il pallore eleganti, il capello sempre ravviato, il look sobrio, contengono bene, sotto pelle, la morbosità che lo anima. A prima vista, sembra il professore universitario che avrebbe potuto essere, ma lo scintillìo degli occhi lo tradisce. Lo guardi e pensi che potrebbe trasformarsi in un Mugwump, il parto rettiliano della mente tossica di Burroughs, suo scrittore preferito. O peggio, in uno dei suoi perturbanti alter ego, protagonisti dei suoi film: quei distinti professionisti con l’inferno dentro, con la faccia di James Woods, Jeremy Irons, James Spader, colti al massimo della loro ambigua lascivia.Con la maturità, ama rispecchiarsi nella ferinità mannara di Viggo Mortensen.
Si professa rigorosamente ateo. Il suo universo, di film in film,è rimasto gelido, scuro, senza consolazioni metafisiche. Narratore costante di un apocalisse sotto zero; in tanto gelo, c’è pero un fondo comico, come un brusio costante, un’ironia che ghiaccia il sangue. Nel 1975 riesce a girare il suo primo film un contesto industriale, fuori dall’underground, imponendo una sua sceneggiatura, con tanto di Barbara Steele nel cast.La composizione e la messa inscena minimali ricordano i coevi film pornografici, ma sono i punti d’incandescenza gore quelli che tutti ricorderanno. Il titolo originale è Shivers, tremori che in Italia diventano Il demone sotto la pelle. L’ambientazione è un complesso residenziale esclusivo, ipertecnologico e autosufficiente, di quelli che all’epoca cominciavano a spuntare ai margini delle metropoli di tutto il mondo, spacciati dagli immobiliaristi dell’epoca come paradisi artificiali. Denominato L’Arca di Noè, popolato da una borghesia apparentemente appagata dalla sua condizione di dorato isolamento, ma in realtà avvelenata dal solito andazzo: languori esistenziali, ipocrisie, frustrazioni sessuali e crisi di coppia.
Uno dei residenti è un medico e scienziato dal cognome che mette in allarme, Hobbes. Decide di impiegare la sua amante tredicenne come cavia di un esperimento, mirato a riportare a galla gli istinti umani, inibiti da un eccesso di razionalità, e dalle convenzioni. Inoculato nella ragazza un parassita in forma di verme, si rende conto che ci sono delle controindicazioni: chi viene visitato dal vermone acquisisce sì una salutare frenesia sessuale, ma finisce per trasformarsi anche in uno zombi assetato di sesso e sangue.
Il dottore vorrebbe rimediare, ma la sua Lolita ha altri amanti, e ha ormai trasformato l’intero residence in un verminaio. Hobbes prende atto che, grazie alla sua grande idea, nel residence vige ormai l’auspicato stato di natura originario: i freni inibitori si sono dissolti. Constatato che Homo homini lupus, tra orge e divoramenti assortiti, il dottore fa fuori la ragazza e poi se stesso, ma ormai tutto è perduto. “L’arte è sovversiva perché fa appello all’inconscio. Non sono un freudiano, ma credo nella civiltà come repressione. Più un film è collegato con l’inconscio, più è sovversivo” è la chiosa del regista canadese, conscio di aver avviato la sua personale rivoluzione.
Segue Rabid: si rimane in ambito pandemico, ma non c’è nemmeno più la consolazione della frenesia sessuale. Eros cede definitivamente il passo a Tanatos, mentre masse umane incontrollate si abbandonano alla rabbia, ormai unico impulso vitale superstite. Torna l’archetipo dello scienziato amorale, inventore di una rivoluzionaria tecnica di chirurgia plastica: il trapianto di pelle prelevata da cadaveri. Sperimenta il suo metodo su una giovane donna, rimasta gravemente ferita in un incidente. A vestirne i succinti panni, è l’imperante regina del porno americano, Marilyn Chambers. Cronenberg, così dice, non ne aveva mai visto i film hard: l’attrice venne proposta dal produttore, perché avrebbe facilitato la distribuzione del film. Comunque siano andate le procedure d’ingaggio, Cronenberg pone al centro del suo film un’icona sessuale, un oggetto del pubblico desiderio, mettendone in scena una mostruosa metamorfosi. Al risveglio del coma, la donna si ritrova sotto l’ascella uno strano orifizio, da cui sbuca un pungiglione fallico retrattile. Le serve per nutrirsi di sangue umano, trasformando le vittime in mostri bavosi, a loro volta vampireschi.
Cronenberg cavalca profeticamente la metafora, di un contagio trasmesso per via parasessuale. E’ il 1977, i tempi sono ormai maturi per affrontare anche il tema della maternità: in Brood, la covata malefica, il deviato di Toronto conia una scienza inesistente, come la patafisica jarriana. Si tratta della psicoplasmia, disciplina scientifica inventata da un Oliver Reed nei congeniali panni dello psichiatra d’avanguardia, ieratico come un santone. Consiste nel curare i suoi pazienti telepaticamente, con la suggestione mentale. Una terapia che darà fatalmente vita ad una serie di mutazioni prodotte dall’inconscio fortemente patologico dei suoi pazienti. Il dolore si concretizza in piaghe, che si aprono sui corpi, come segni di drammi inconsci, e irrisolti. Cronenberg conferma la renitenza all’happy end, e la sua affezione ai finali circolari, in cui il male non trova fine, e non c’è nemmeno l’illusione della catarsi.
Restano, ancora, le immagini: corpi femminili deformati da sacche amniotiche esterne, simili a escrescenze tumorali, mutazioni necessarie a partorire creature assassine, incarnazione di sensi di colpa degenerati in rancore. Pronte ad obbedire ciecamente agli ordini telepatici della madre. A proposito di telepati: siamo ormai all’alba degli anni ottanta, e Cronenberg regala all’immaginario un’altra sequenza destinata alla reiterazione infinita. Un omarino calvo, giacca, cravatta e faccia catastale, ad un convegno pubblico, ingaggia un confronto telepatico con quel viscidone di Michael Ironside. Le vene del collo si gonfiano, i bulbi oculari si dilatano, e la testa finisce per esplodere, in un tripudio di frattaglie sanguinolente. Un’irruzione di splatter eccessiva ma non compiaciuta. Straniante, capace di smarginare il canone convenzionale del genere. Ad Ironside, invece, germoglierà un metaforico terzo occhio, al centro della testa. Scanners, il titolo del film, definisce esseri umani speciali, capaci di prendere possesso telepaticamente della mente altri. Con quattro milioni di budget, il film sancisce la prima collaborazione di Cronenberg con Hollywood, avviata senza snaturare se stesso.
Incombe la cuspide teorica del suo cinema: Videodrome.
Il protagonista è James Woods, forse uno degli alter ego più disturbanti, di Cronenberg. La chioma lucida, ondulata, di media lunghezza, da creativo anni ottanta. L’ambiguità morale dello sguardo, e il sorriso di chi non sa decidersi tra viltà, ferocia o definitivo cedimento alla patologia. Woods, nel film, gestisce, una sordida emittente televisiva via cavo. Per sopravvivere, la sua rete deve offrire quello che i grandi networks non possono permettersi di mandare in onda, frenati da vincoli morali e politici: sentimentalismo ricattatorio, sociologia da basso talk show, pornografia e violenza. Scandagliando i recessi dell’etere alla ricerca di succosi contenuti, da ritrasmettere illegalmente nel suo canale, incappa nel canale pirata Videodrome, programma di supplizi molto verosimili, o forse addirittura veri, inflitti in diretta in una videoarena. Ipnotizzato dalle immagini, finisce per coinvolgere la sua fidanzata in pratiche sadomaso. A interpretarla, in cortocircuito tra punk e new wave, è Debbie Harry, front woman dei Blondie.
Videodrome è in realtà una struttura progettata per creare una nuova società: le sequenze di violenza estrema servono per controllare la mente dello spettatore, trasportandolo in uno stato allucinatorio, in una dimensione parallela. E’ quello che accade a James Woods, sottoposto a mutazioni cerebrali, e genetiche: attraverso i suoi istinti primordiali diventa un mutante, una creatura ibrida fatta di nuova carne. Il tessuto organico si fonde con la plastica e i materiali elettronici, lo schermo del televisore diventa una membrana organica, irrorata di vasi sanguigni. L’apparecchio televisivo ansima, sotto le frustate di un invasato James Woods, mentre videocassette e pistole entrano ed escono dalle viscere.
E’ il trionfo di una tecnologia sterile, come l’armamentario di ginecologico dei terribili gemelli Mantle, monozigoti incarnati dal Jeremy Irons, qualche anno dopo. Innovazioni che non alleggeriscono la vita ma creano pesante addiction, dipendenza neurologica.
Quasi quarant’anni dopo, è sconcertante riscontrare come l’apocalittico canadese avesse prefigurato con precisione la nostra contemporaneità: l’era della connessione permanente, dell’illusoria interattività della tv e di internet, rifratta in miriadi di schermi eternamente accesi. Nel suo schermo di cristallo organico, Cronenberg aveva intravisto un’umanità in perenne ostaggio di flussi di immagini spesso ambigue, contrastanti. Paradossalmente indecifrabili, nella loro insistita evidenza. Una galassia infinita, costellata frammenti di pornografia estrema e di snuff movie ben catalogati, a portata di qualsiasi occhio, sia nel famigerato deep web che in quello di superficie, addirittura contenuti nei telegiornali. Un’umanità pervasa da una scopofilia compulsiva, condannata ad afferrare un piano di realtà condiviso con difficoltà sempre crescente.
Le tracce di Cronenberg non sono ancora finite. Nel pieno dell’edonismo estetizzante degli anni ottanta, l’aitante Jeff Goldblum, scienziato dalla chioma fluente e dal fisico scultoreo, viene trasformato dalla sua imprudenza in mosca ripugnante. Tutto nasce dall’imprevisto ingresso dell’insetto nel teletrasportatore molecolare da lui creato. I DNA della mosca e dell’umano si fondono, rendendo la metamorfosi irreversibile. Ibridazione che ne Il pasto nudo, omaggio all’adorato Burroughs, vedrà uno scarafaggio parlare da strani orifizi, goloso di polveri sospette. Virato in una patina fotografica di lisergica classicità, il film vede l’ex mutante Robocop Peter Weller diventa l’alter ego dello scrittore. Visioni tossiche, torrido sesso, frenesie jazz in sottofondo, viaggi fisici che sfumano in derive mentali: Cronenberg non adatta un libro infilmabile, ma condensa i sogni Beat della sua adolescenza. In comune con lo scrittore, diventato suo grande amico, Cronenberg sente di avere il comune senso del corpo, ribattezzato da Burroughs soft machine.
Condividono anche la percezione della vita come malattia foriera di cambiamenti. La droga diventa, nel film, un’altra metafora del controllo, della dipendenza imposta dall’ assuefazione. Un allettante corpo estraneo che, una volta assunto, regala un’illusoria apertura a nuove dimensioni. Per poi far ripiombare il protagonista nell’eterno ritorno dell’uguale, nell’essere, per sempre, un Guglielmo Tell tragicamente impreciso. A metà anni novanta, Cronenberg porta sullo schermo un altro suo cupo nume letterario.
Crash, tratto dal romanzo di James Ballard, è uno dei suoi film più estremi. James Spader, il protagonista, offre la più precisa incarnazione dello yuppie deteriore, e scambista di coppia, mai vista sullo schermo. Si aggrega ad un gruppo di cultori dell’incidente automobilistico, inteso come massima forma erotica, capeggiati da un efficacemente laido Elias Koteas. Idolatri dei mitihollywodiani morti sulla strada, feticisti delle protesi e delle cicatrici. Carezzare l’occasione di una morte violenta, è l’ultimo guizzo di vita rimasto. Illuminate da luci gelide come lamiere, frutto della fotografia livida di Suschitzky, le sequenze si susseguono per accumulo, senza una gerarchia narrativa, proprio come nei porno. Ricollocano l’apatia sadiana in una metropoli senza identità di fine novecento, ibridazione di New York e Toronto. Una Cosmopolis senza centro, pervasa dell’entropia, visualizzata materialmente dallo scorrere incessante delle auto, sulle sopraelevate sovrapposte.
Cronenberg chiude il ventesimo secolo con il cupo universo ludico di eXistenZ. Pieno da influenze dickiane, ruota intorno alla bioingegneria: a condurre il gioco sono pod organici, infilati in orifizi aperti chirurgicamente, ed erotizzati. Cronenberg sembra rimeditare sull’essenza stessa del cinema, sulla sua inclinazione a creare un universo parallelo, uno specchio in cui è fatale sprofondare. Il cinema come perversione primaria, gioco estremo, vizio assurdo e totalizzante che forse preserva da altre devianze. L’ossessione che lo fa vivere e continuare a catalogare sul suo vetrino-obiettivo da entomologo mancato, lo spettacolo polimorfo, nuovo e monotono, delle perversioni umane. Spingendosi anche nel teatro liberista di una Wall Street feroce e insensata. Dove la parola, disumanizzata, gira vuoto e smarrisce il senso, come nelle pieces di Beckett, già omaggiato in Spider. Le nuove star di Hollywood fanno più ribrezzo, nel loro vuoto demenziale, e incarognito, dei fan necrofili di Crash, che sognavano di morire come James Dean.
La pandemia, poi ha definitivamente cronenberghizzato il mondo: davanti al virus globale la stirpe umana ha dimenticato rapidamente l’impulso solidale, per cedere il passo alla consueta ferocia, acutizzata dalla paura. La tecnologia è in ogni mano, fornendo alla barbarie nuove forme espressive, senza farle sopire la violenza fisica. Tutto troppo esatto, Dottor Cronenberg! Ma lui non si è mai atteggiato a profeta, e sorride leggero. Ha scelto la Grecia originaria, per girare il suo nuovo esordio. Un’altra apocalisse, e non sarà l’ultima.
Giuseppe Sansonna (1977) è autore di cortometraggi e documentari, fra cui, oltre al fortunato Zemanlandia, Frammenti di Nairobi (su una bidonville kenyana), A perdifiato (su Michele Lacerenza, il trombettista dei western di Sergio Leone) e Lo sceicco di Castellaneta (sul mito di Rodolfo Valentino).