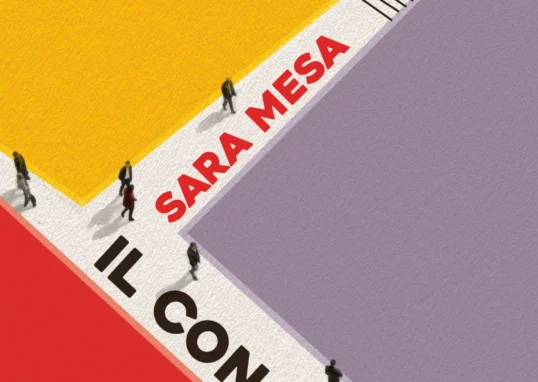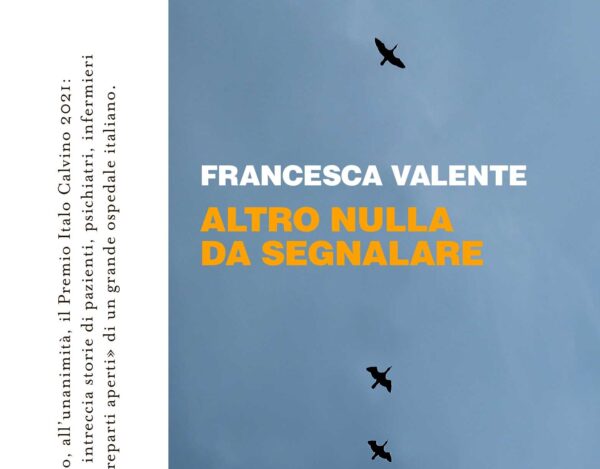
«Agosta: balla da sola».
I matti chi sono? Chi è normale è chi no? Qual è il confine, la linea di separazione, la dose di fortuna che ci vuole affinché la vita prenda una direzione invece di un’altra. Le persone le conosciamo davvero? Anche quelle a noi più vicine hanno un segreto (noto nemmeno a loro), una frattura che li ha fatti deragliare o che avrebbe potuto. Smettiamo di voler bene a chi deraglia? Siamo disposti a fare una carezza a chi ci pare tanto distante da noi? Abbiamo paura (come ci raccontiamo) o siamo solo stronzi? Siamo attenti in superficie, ma sotto sotto adoriamo farci i fatti nostri, non essere scomodati, non essere disturbati. Ci piace ancora la figura del matto di paese, ricordo della nostra infanzia, ma ci disturba quello che fa il gesto improvviso, che esce fuori dai binari, e allora commentiamo con cose come è matto, è impazzito, è fuori di testa. Che se ci riflettiamo è fuori di testa sarebbe un bel modo di dire se lo usassimo bene. O se provassimo a uscire ogni tanto dalle nostre teste e guardare il mondo – e noi stessi – da altra angolazione, ma non ne abbiamo il coraggio, meglio di dirlo di altri, meglio stare nel nostro.
Franco Basaglia quando arrivò a Gorizia, tra le prime cose, fece in modo che ogni paziente avesse accanto al letto un comodino, sul quale appoggiare dei piccoli oggetti, delle cose personali. Questa cosa me l’ha raccontata un architetto ed è una cosa cui penso ogni giorno, il comodino, le parole, una carezza, e mi è tornata in mente appena ho cominciato a leggere Altro nulla da segnalare di Francesca Valente (Einaudi 2022, Premio Calvino, Premio Campiello opera prima), perché i protagonisti delle sue storie hanno fatto in modo che il comodino restasse accanto ai letti, hanno potuto allungare la mano e trovarvi appoggiata un portafogli, un’agenda, finché si è potuto.
Povera me che il mio cuore non sa parlare con la mia bocca.
Sono i primi anni Ottanta, siamo a Torino all’Ospedale Mauriziano, Servizio psichiatrico e diagnosi. La Legge 180 – ancora oggi uno degli atti più luminosi e rivoluzionari del nostro panorama legislativo – esisteva da poco e a Torino andava in scena uno dei primi esperimenti di reparto aperto, luogo d’incontro, tentativo di comprensione, territorio di scambio d’umanità. Al Mauriziano si provava ad applicare la legge voluta da Franco Basaglia, la si capiva, la si adattava alle persone, ai bisogni, alle lune storte, alle giornate.
Altro nulla da segnalare era la formula rituale con cui si chiudevano i rapportini di chiusura di ogni turno, più di una registrazione dei fatti, un doppio tentativo, quello di comprendere le donne e gli uomini che transitavano nel reparto e quello di comunicare a chi avrebbe iniziato il turno successivo come erano andate le ore precedenti. In quei rapporti stavano uno con l’altro il dramma e la risata, il pianto e la tenerezza, l’ordinario e lo straordinario, o meglio il diversamente ordinario. I reparti aperti erano luoghi di confine senza dogane, erano frontiere attraverso le quali transitavano, a più livelli, bagliori di umanità. La vita, insomma, come altrove, come in ogni casa, posto di lavoro.
[…] Non fu più ricoverato. Nessuno sa, però, come la sua storia andò a finire. Vero è che le storie non vanno a finire, semplicemente s’interrompono.
Francesca Valente ricostruisce e inventa, mette sul palco realtà e fantasia, parte da quei rapporti e dai racconti dello psichiatra di reparto Luciano Sorrentino, un medico illuminato e coraggioso, che in quegli anni per prima cosa cercava di capire, condivideva una sigaretta con chi stava avendo una crisi, scambiava due parole con chi scoppiava in lacrime o dava in escandescenza. Sorrentino calmava con il linguaggio, insieme a chi lavorava con lui, mischiava scienza a creatività. Lavorava guardando la gente negli occhi e porgendo parole come fossero carezze, così, soltanto così, si poteva arrivare a comprendere la storia di una donna, il momento in cui un uomo aveva sbagliato binario e non era più stato capace di tornare indietro.
La sospensione del tempo raggiungeva ora, in quella processione sacra, il suo apice. Nelle onde il tempo non è scandito a seconda della grammatica delle ore ma nei modi di una luce che si irradia e di un’ombra che avanza.
Attraverso il missaggio sapiente di Valente, tra documento e narrativa pura, scopriremo le vicende della signora Agosta, dell’attore Carlo Colnaghi (insieme al regista Segre, all’infermiere Tornior e a Sorrentino unico nome vero), di Libera (una delle più commoventi), di Salvatore, il Calzolaio, Francese, Alma, Debernardi e gli indimenticabili Eugenia e Edoardo; storie che non dimenticheremo più.
Altro nulla da segnalare è un libro importante che riporta all’attenzione un tema centrale: quello della sofferenza mentale, e idee meravigliose che troppo spesso sono andate smarrite, o inapplicate, ma Francesca Valente non vuole darci nessun insegnamento, vuole solo scrivere un romanzo e quando ci si mette a scrivere si cerca qualcosa, una scintilla, uno slancio, una memoria da salvare, occhi e gambe da mettere sulla pagina. Valente si occupa dell’umano che conta più della verità, così come il verosimile è il perno sul quale ruota ogni libro che funzioni. Valente scrive e, così facendo, mette di nuovo il comodino accanto al letto di chi soffre e sopra ci appoggia una spazzola, una penna, un anello, una fotografia appena ingiallita dal tempo.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/