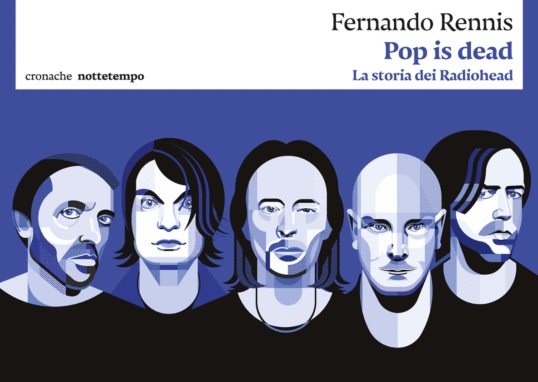Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro di Tobia Iodice Dell’amore, del Miracolo e della Morte, uscito per Carabba.
di Tobia Iodice
No, non era semplicemente bella. Era bellissima. I capelli castani, screziati di biondo, le scendevano giù dal capo fino alla schiena con dolci onde dorate, simili a quelle del mare quando si gettano pigramente sul bagnasciuga. La testa piccina, rotonda, quasi un ovale perfetto, sembrava invece una montatura disegnata da un qualche abile gioielliere per ospitare i suoi meravigliosi occhi azzurri. Erano due acquamarina quegli occhi. Chiari, quasi trasparenti, sapevano abbagliare, catturare, ipnotizzare chiunque li incontrasse. Le spalle larghe, ampie, si scioglievano poi in due braccia perfettamente tornite, che incorniciavano un seno turgido, pronunciato, eppure perfettamente armonico col ventre solido e piatto. Dal suo vitino da vespa si dipartivano infine due gambe lunghe, sode, che le regalavano un’andatura sicura, potente, eppure straordinariamente femminile. Ma più di tutto, ciò che colpiva chi la vedeva era il colore del suo incarnato. Pareva avorio o marmo di Carrara la sua pelle, e ad ammirarla troppo si aveva quasi paura a sporcarne il luminoso candore. No, non era bella. Per tutti la marchesa Alessandra Maria Antonietta Livia Starabba di Rudinì era qualcosa di più. Era bellissima.
Era nata a Napoli Dridrì (come la chiamavano in fami- glia), il 5 ottobre 1876. Ma era accaduto per caso, non per scelta. Sua madre, la contessa Maria de Barral, aveva trascorso tutta la gravidanza nella tenuta di famiglia, a Pachino, in Sicilia. Quando però aveva sentito avvicinarsi il momento del parto, aveva deciso di partire per Roma. Qui, infatti, l’a- spettava il marito, Antonio Starrabba (con due erre, perché il cognome della figlia, che ne aveva una soltanto, sarà il frutto di un errore dell’ufficiale dell’anagrafe di Napoli) marchese di Rudinì, uno degli uomini politici più influenti dell’Italia del tempo. Esponente di quella nobiltà meridionale che dopo essere stata pappa e ciccia coi Borbone li aveva abbandonati prima del crollo del loro potere, il marchese Starrabba aveva iniziato la sua carriera come prefetto di Palermo e poi, grazie ai buoni uffici del suocero presso i Savoia, nel 1869 era sta- to chiamato a Torino a ricoprire la carica di Ministro degli Interni. Divenuto successivamente Vicepresidente della Ca- mera dei Deputati, aveva seguito la famiglia reale nella Città Eterna dopo la breccia di Porta Pia, acquistando un elegante villino in via Gaeta, oggi sede di una rappresentanza diploma- tica. Ed era proprio qui che era diretta la contessa de Barral quando a largo di Napoli il mare si era agitato suggerendo all’equipaggio dell’imbarcazione che la trasportava di attraccare nel porto partenopeo e di attendere all’ombra del Vesuvio il lieto evento. Quel mare agitato, quelle onde alte che si infrangevano violente e indomabili contro lo scafo della nave dovevano però esserle entrate dentro, imprimendo un segno indelebile su quella vita che stava per nascere visto che anni dopo, stando ad alcune testimonianze, di fronte alle continue intemperanze della figlia, pare che la nobildonna usasse esclamare: «Sembra porti in sé l’irrequietezza del mare».
Perché Alessandra, oltre che bellissima, sin da piccola si era rivelata una vera e propria furia. D’estate infatti, nelle campagne dell’ampio feudo di Pachino dove tutta la famiglia si trasferiva, non faceva che correre come una forsennata per i campi, arrampicarsi sugli alberi, litigare come un maschiaccio col fratello Carlo di otto anni più grande di lei, facendo disperare così le povere governanti a cui era affidato l’ingrato compito di sorvegliarla. Nessuno pareva in grado di contenerla, di darle un minimo di educazione. Men che meno la madre, che poco tempo dopo la sua nascita aveva cominciato a manifestare i segni di una depressione che la porterà poi a essere rinchiusa in una casa di cura.
Ma dietro tanta irrequietudine, come pure dietro al “male oscuro” della contessa de Barral, si nascondeva un segreto inconfessabile, una ferita che aveva traumatizzato per sempre l’equilibrio psichico e la sfera affettiva della piccola. È il caso di ascoltarla, Alessandra, mentre a fatica racconta questo suo trauma. Lo fa sotto le spoglie letterarie dell’aspirante suicida Vana Inghirami, una delle protagoniste del Forse che sì forse che no, l’ultimo romanzo scritto da Gabriele d’Annunzio. In uno dei passaggi chiave del romanzo dice la donna:
Una cosa orribile fu svelata a me che non ero se non una creatura ignara e inoffensiva. Qualcuno m’ha afferrata per i capelli, e mi ha sbattuta, e mi ha costretta a guardare quel che non si può guardare senza perdere le palpebre, senza che gli occhi rimangano nudi per sempre.
Era accaduto che chissà come e chissà quando, ma di sicuro quand’era ancora poco più che una bambina, Alessandra aveva scoperto o era stata portata a scoprire il padre a letto con la sua concubina, la marchesa Leonita Beccaria Incisa, dalla quale il focoso uomo politico avrebbe avuto due figli maschi pressoché coetanei di quelli legittimi. Proprio questa sfacciata infedeltà avrebbe portato, come s’è detto, la contes- sa de Barral prima alla depressione e poi alla follia. La reazione di Alessandra, invece, fu completamente diversa. Quello spettacolo che non avrebbe mai dovuto vedere determinò il suo carattere ribelle, insofferente a ogni regola, ma allo stesso tempo anche il legame fortissimo con quel padre tanto seve- ro quanto manchevole ai suoi doveri di fedeltà.
Una manchevolezza che, tra l’altro, era sulla bocca di mezza Roma. C’è una pagina del diario di Domenico Farini, presidente del Senato in quegli anni, che racconta come le intemperanze amorose del marchese di Rudinì fossero oggetto di pettegolezzi pure nei palazzi del potere.
Fu proprio per sottrarre la piccola Alessandra al turbinio dei commenti maliziosi circa il padre e la sua situazione, ma soprattutto per provare finalmente a darle quell’educazione che una rampolla del suo rango doveva obbligatoriamente avere, che nel 1886 Antonio di Rudinì la iscrisse al più prestigioso Collegio dell’Urbe: quello del Sacro Cuore, a Trinità dei Monti. Una scuola severa, rigida, che aveva formato il fior fiore delle giovani nobili dello Stato pontificio prima e di quello sabaudo poi. Una vera istituzione a Roma, al cui pensiero tutte le bambine tremavano. Tutte, tranne Alessandra.
Appena entrata in Collegio infatti, la vivacità e la mancanza di disciplina di Dridrì se è possibile aumentarono ancora di più. Continui atti di insofferenza e di insubordinazione alle regole, bizzarrie di ogni tipo fecero dei due anni trascorsi tra le mura antiche del Sacro Cuore un susseguirsi di gesti clamorosi, tanto più eclatanti perché compiuti da una bambina di scarsi 12 anni. Non a caso le compagne la ribattezzarono Centodiavoli, visto che si nascondeva frequentemente sugli alberi del giardino della scuola facendo andar di matto le suore che la cercavano, o si travestiva di notte da fantasma spaventando a morte tutte le altre collegiali e le sorveglianti, che pensarono davvero a una possessione demoniaca della piccola di Rudinì. Fu però solo quando versò l’inchiostro rosso del suo calamaio nell’acquasantiera della chiesa della scuola gridando al miracolo della transustanziazione che le suore del Sacro Cuore decisero che quella piccola peste lì proprio non poteva più starci, e convocarono il padre affinché la portasse via. Che umiliazione per il già Presidente del Consiglio sentirsi dire di avere una figlia intelligente, dotata, ma impossibile da educare!
Convinte a fatica le monache a tenerla nella loro scuola almeno fino alla fine delle lezioni, onde evitarle la macchia dell’espulsione, ai primi di maggio del 1889 la bambina venne trasferita dal padre in un nuovo prestigioso educandato: il Collegio della Santissima Annunziata di Poggio Imperiale, a Firenze. Si trattava di uno degli istituti scolastici femminili più esclusivi dell’Italia umbertina, riservato alla nobiltà di più alto lignaggio e solo di recente aperto anche alle figlie del- la ricca borghesia. A tal proposito, proprio qui, anni dopo, d’Annunzio avrebbe iscritto la piccola Renata, aiutato nel pagamento della retta dalle generose sovvenzioni della Duse. L’iscrizione a quella nuova scuola fu un trauma per Alessandra. Le regole e le limitazioni del Collegio erano infatti ancora più severe e stringenti di quelle del Sacro Cuore, e riguardavano anche i permessi per le visite dei familiari e per i soggiorni a casa. Non era raro il caso di ragazze che riuscivano a rivedere i parenti dopo mesi se non addirittura anni. In questo, ciò che più le pesò non fu tanto la lontananza dal padre o dal fratello, bensì quella dalla madre. Nei con- fronti di quella donna già fragile di per sé ma ancor di più ferita dalle mortificazioni di un matrimonio non felice, Alessandra aveva infatti maturato, crescendo, un atteggiamento di protezione che adesso veniva bruscamente interrotto da quell’allontanamento forzato. Una ferita che non smise mai di sanguinare in un angolo segreto del suo cuore.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente