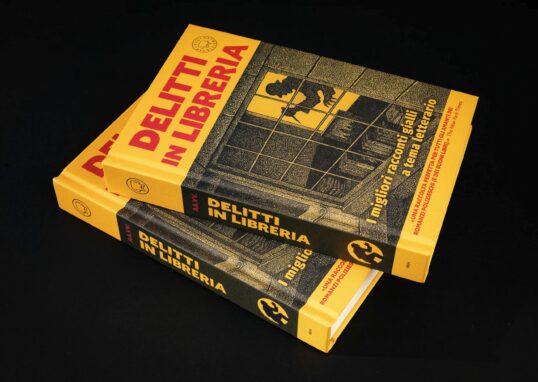di Mariachiara Rafaiani
Qualche anno fa è capitato che mi chiedessero quale libro avrei scelto se, per un’immaginaria apocalisse culturale, avessi dovuto salvarne solo uno. Risposi, senza alcuna esitazione, i Moralia di Plutarco. È un’opera che, a mio avviso, più di ogni altra accoglie la varietà dei risultati letterari e filosofici dell’epoca classica nelle sue manifestazioni più alte. Le corde profonde di pensiero su cui s’intesse, la sua natura poliedrica, la sua potenza metafisica la rendono una delle più straordinarie “opere-mondo” mai prodotte. Mentre scegliendo di salvare Alla ricerca del tempo perduto, o l’Eneide, o la Divina Commedia, o l’Iliade e l’Odissea, probabilmente qualcosa che il pensiero umano ha conquistato verrebbe perduto per sempre, credo che nei Moralia ci sia invece tutto ciò che serve per ricostruire da zero una società: per ricominciare da capo.
L’immediatezza della mia risposta era stata dettata però anche da ragioni più personali e egoistiche: sentivo, e lo sento ancora oggi, che il piacere di leggere quell’opera non si sarebbe mai esaurito. Certamente non avrei attribuito a nessuna opera “non classica” il compito di una rifondazione culturale, e questo porta ovviamente alla definizione che vorrei dare di classico: con le parole che lo stesso Plutarco utilizza per descrivere le opere poste sull’Acropoli da Pericle: “Ne sgorga come una perenne giovinezza che le conserva immuni dall’assalto del tempo, quasi fossero intrise di uno spirito che fiorisce in perpetuo e di un’anima incapace di invecchiare” (Vita di Pericle, 13.3). Non so quanto possa risultare una scelta condivisibile – ognuno ha il suo libro che gli salva la vita, e le sue relative buone ragioni – ma sicuramente pone una domanda: che idea del mondo presuppone il “classico”? È ancora plausibile credere, oggi, che la storia umana abbia avuto nella Grecia antica il punto più alto della sua parabola? Si può amare quell’immagine, quel mondo perduto, nella nozione che ne dà Rilke – quella di “un approfondimento amoroso può rendere una bellezza più intimamente vicina e più intellegibile”?
Sono domande che hanno continuato a lavorarmi dentro dopo la lettura del bellissimo pezzo di Giorgio Fontana, uscito qualche tempo fa su Doppiozero (https://www.doppiozero.com/cosa-si-e-rotto-nella-lingua-italiana-degli-scrittori). Condivido in pieno la sua posizione: esiste, senza dubbio, un problema nella lingua italiana degli scrittori, ma credo però che esso derivi invece non tanto dall’incorrere dei sempre nuovi stimoli e cambiamenti nella contemporaneità, ma piuttosto da quello che – all’interno di questi continui nuovi stimoli, delle continue ridefinizioni dei parametri del linguaggio, e delle interminabili semplificazioni di senso di ciò che ci circonda – stiamo lasciando indietro. In altre parole: non da ciò che si accoglie, ma da ciò che si trascura; non dal troppo di qualcosa ma dal poco di qualcos’altro. Mi sono chiesta se questo rimosso continuo, questo che resta sempre più indietro nella pressione storica che spinge tutto propulsivamente sempre avanti, non sia, appunto, il “classico”. I classici si leggono ancora? Sono ancora fecondi? È snobistico, moralistico, elitario porre questa questione al di fuori del monito accademico? Può essere una proposta valida quella di riscoprire le ragioni fondative dell’epoca classica, e radicarla – dopo anni di dominio del novecento perlopiù americano – nel mediterraneo di due millenni fa? Che non possa essere questo uno stimolo per salvare la letteratura dalla convenzionalità, dalla semplificazione, dall’omologazione dei codici?
Ho, com’è evidente, quasi solo domande, anche se più o meno retoriche. È una fiducia, la mia, nell’energia educativa che la letteratura classica potrebbe esercitare sulla nostra. La complessità della sintassi greca e latina esercita il pensiero con tale forza che chi la pratica si esercita a un rifiuto naturale della semplificazione. Per citare Salvatore Settis (Futuro del “classico”, Einaudi 2004), “un classico indicato non solo come radice, ma soprattutto come progetto, come meta”. Differentemente da Fontana, non sono così scettica nell’immaginare un passato aureo ormai miseramente svanito; semplicemente, quell’età d’oro delle lettere mi appare molto più lontana nel tempo di quanto appaia a lui. Forse obbedendo a una convinzione che mi fa credere che, il più delle volte, il raggiungimento di cambiamenti ragionevoli possa essere ottenuto solo partendo da posizioni estreme.
Come scrive Giuliano Pisani nella sua introduzione ai Moralia (Bombiani, 2017), “la saggezza di Plutarco è un viatico per la vita”. Nato fra il 46 e il 48 d. C. a Cheronea – città dove nel 338 a. C. la Grecia perse per sempre la sua indipendenza contro Filippo II – e formatosi nella scuola ateniese, quindi respirando e assorbendo l’eredità di Platone, si trovò a vivere a Roma sotto l’imperatore Vespasiano, dove godette dell’amicizia e dell’ammirazione dei più importanti uomini di cultura del tempo. Preferì comunque tornare nella sua Beozia: quella terra che visto realizzarsi l’ascesa al potere di Epaminonda, da Plutarco considerato l’uomo più virtuoso della storia greca. Plutarco credeva fermamente che la speculazione filosofica dovesse essere rivolta ad atti concreti, a un’azione reale all’interno della società. Così, tenendo fede ai suoi principi, rivestì incarichi pubblici a Cheronea, e anche a Delfi divenne sovrintendente degli Anfizioni. Perfino l’imperatore Traiano, secondo il lessico bizantino Suda, lo rese console e chiese ai magistrati dell’Illiria di non prendere alcuna decisione che non fosse concordata con lui. L’opera che più di ogni altra realizza questa sua visione del binomio filosofia-politica è senz’altro Vite Parallele, la raccolta di biografie dei grandi personaggi del mondo greco e romano. Di quell’opera Plutarco dice: “Ho iniziato a scrivere biografie per rendere un favore agli altri, ma poi ho continuato l’opera anche per me, servendomi della storia come di uno specchio, in modo da ornare la mia vita con le virtù descritte in quelle”.
A cogliere questa necessità di leggere Plutarco fu d’altronde anche Montaigne che, mettendolo in rapporto con Seneca, scriveva: “Plutarco ci istruisce, ci fortifica e conforta costantemente, tocca più l’intelletto: il primo rapisce la nostra mente, il secondo la conquista”. Leggere Plutarco era il conforto e la consolazione di Beethoveen. Leopardi lo prese a modello con le Operette Morali, e Giuseppe Verdi aprì così I masnadieri: “Quando io leggo Plutarco, ho noia, ho schifo, di quest’età di imbelli”. Se Curzio Malaparte nel 1936 scriveva sul Corriere della Sera che il colpo di grazia alla morale plutarchiana in Italia l’avrebbe dato Mussolini, oggi quello stesso deterioramento della morale culturale avviene, probabilmente, nella svogliatezza capitalistica che ha investito irrimediabilmente anche il mondo del libro. Non è un caso che, a fronte di una produzione sempre più abbondante di autori contemporanei, stiano pian piano scomparendo dal mercato molte opere classiche.
Mentre, come scrive Fontana, “nella lingua dei contemporanei qualcosa si è rotto”, potrebbe essere utile andare a cercare quei momenti della lingua e della storia che invece meglio di altri resistono alla disgregazione del tempo. Come scrive ancora Pisani proprio di Plutarco: “I suoi interessi, le vaste letture, lo facevano vivere in un’età senza tempo: tutto gli era contemporaneo”. È questo infatti uno dei più profondi paradossi, e allo stesso tempo una verità fondamentale, della letteratura: ciò che è classico riesce sempre ad essere contemporaneo, e ciò che è realmente contemporaneo trova spesso la forza di imporsi come classico. Il presente ha bisogno di essere interpretato, così come il futuro ha bisogno di comprendere il passato. La storia è un oggetto prismatico: l’arte deve potersi parlare attraverso le epoche. Senza questo presupposto le pagine che si sono accumulate nei secoli sarebbero indecifrabili, e quelle che continuiamo a scrivere sarebbero inutili.
La nostra situazione non è disperata né irrimediabile; ma forse i rimedi passano anche dal chiederci quali sono i nostri modelli – e se, e quanto questi modelli continuino a funzionare. Provare a combattere le borie scolastiche, i timori reverenziali, i terrori di essere schiacciati da ciò che ci viene sempre presentato come troppo alto o troppo lontano e invece è sempre qui, nelle prossimità dell’essere umano così com’è. Come scrive Rilke: “Ogni azione dovuta all’arte significa una liberazione; possedere una cultura vuol dire solo essere liberato. Così l’arte rappresenta per l’artista la via della cultura”.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente