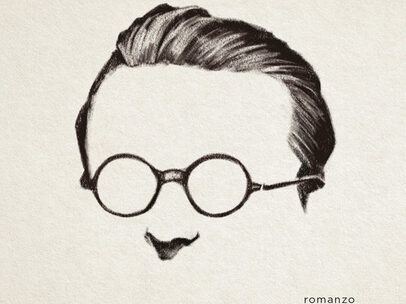
di Mario De Santis
“Il punto era il nucleo profondo del mondo in forma numerica”. Mentre leggevo il nuovo (libro? Romanzo? Bio-novel? genere indecidibile) scritto da Deborah Gambetta, “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (Ponte alle Grazie) mi è tornata in mente questa frase che Cormac McCarthy fa pensare a Bobby Western alla fine de “Il passeggero”, dopo la sua lunga avventura e fuga dalle sue ossessioni, in cui larga parte ha la matematica. Anche il libro di Gambetta contiene ossessioni e molta matematica e tuttavia resta un romanzo (parola-baule) portato oltre sé stesso.
L’incontro con Gödel (uno dei grandi geni del XX secolo, meno pop di Einstein, ma egualmente determinante per la conoscenza umana) nasce casualmente, oltre dieci anni fa, in un periodo in cui per la scrittrice (o la sua alter ego narrante) era necessario mettere ordine alla vita, dopo un amore doloroso e ossessivo. Il gancio di autofiction è soprattutto all’inizio di “Incompletezza” (parola chiave per le teorie del matematico) e poi torna ogni tanto, ma come una cornice-pretesto, raccontata quasi volendo parlarne tra amici ma bisogna andare oltre. Infatti, mentre cerca di sbrogliare i paradossi dell’amore, scopre in un libro l’accenno al fatto che il matematico ceco era stato colui che aveva “costruito un teorema partendo dalla natura autoreferenziale di un paradosso”.
Inizia così a scavare nella vita di Gödel e pian piano, nella sua teoria matematica, decidendo così di scriverne. “Perché Gödel?” chiede un’amica a Gambetta. “Per la sua vita fragile” risponde la scrittrice ma anche per intraprendere un viaggio e capirlo meglio quel perché. Per Gambetta è come un colpo di fulmine e forse un chiodo (ossessivo) che ne scaccia un altro. Tuttavia, la cosa importante che fa anche di questo libro una eccezione letteraria e editoriale degna di rilievo (complimenti a Ponte alle Grazie) è che Gambetta comprende come non basti raccontare la vita, perché l’essenza di Gödel sta nella sua mente, dunque nelle sue teorie. La biografia di Kurt era magnetica ma non avventurosa. Attraversò la grande Storia, tra gli anni ’20 e gli anni ‘40 (e per la stori della cultura occidentale, tra il Circolo di Vienna e la Princeton del dopoguerra, dove incrociò i matematici del futuro progetto Manhattan, Von Neuman e Oppenheimer su tutti.
La sua vita, tuttavia, era chiusa – e al tempo stesso espansa – nella stanza infinita della sua mente. Qua e là qualche guizzo, su tutti, il matrimonio quasi in segreto, con una donna del tutto diversa da lui, una ballerina di cabaret di Vienna, Adele Nimbursky, che rimarrà accanto a lui nella gloria e nella follia. Poi c’era il carattere difficile, la riservatezza. Insomma, non bastava il quid della persona e non bastava la scrittura per farne il romanzo di Gödel. Non bastava il bambino che i genitori chiamavano “signor perché”, che li sfiniva di domande, non bastava raccontare come fu che divenne “il più grande logico dopo Aristotele” come si disse di lui. Non scriveva un diario e anche nelle lettere accennava poco a sé stesso. Così Gambetta fa fare al romanzo un salto logico e di genere e qui sta la sua eccezionalità. Bisognava raccontare quella “beautiful mind”, più vasta e profonda di una psicologia, ma pur sempre qualcosa che appartiene a una persona. Inizia così per la scrittrice un decennio di studio e appunti, legge tutti i libri di e su Gödel, studia le sue teorie. In fondo “incompletezza”, come emerge dalla cornice, il romanzo di una scrittrice che come Achab insegue la sua Balena.
Gödel stava addirittura zitto alle riunioni del Circolo di Vienna, Però pensava. Calcolava e in quel pensiero mette tutto il mistero di sé. Il “Personaggio” stava dunque dentro i processi logici e nella matematica, nelle sue dimostrazioni. Per questo che Gambetta non solo studia matematica, ma fa entrare le teorie dentro il romanzo, in alcuni capitoli delle oltre seicento pagine, facendo di “Incompletezza” – direi proprio per questo – un libro appassionante. La gran parte, sia chiaro per il lettore, è pur sempre occupata dalla storia di una vita, dalla passione e ossessione nello studio, la fatica della ricerca, e poi invecchiando le ipocondrie, lo sfinimento di sé.
C’è il confronto con i grandi filosofi – Wittgenstein e Russell – o i fisici, tra cui la grande amicizia con Einstein, che Gambetta racconta con bellissime pagine, definendo Kurt e Albert “due strambi Chisciotte”. Gödel aveva esposto il cuore delle sue teorie a ventiquattro anni, per il resto della vita faticò per farle affermare e alla fine ebbe il riconoscimento della sua grandezza, anche grazie all’aiuto da parte degli altri matematici: von Neumann su tutti, ma anche Oppenheimer e molti altri. Nel libro però ci sono anche capitoli che sembrano un manuale di matematica: teorie dimostrazioni, assiomi, formule. Pagine che Gambetta autorizza a saltare. Invece consiglio di leggerle, sono una arrampicata che cerca lettori disposti alla vertigine, alla frustrazione, alla fatica. Sono una sfida e una promessa di avventura. Non importa capire tutto, ma anche un inetto all’algebra come il sottoscritto si è però lasciato portare dalla scrittura rigorosa e incalzante, che ripercorre i teoremi passando anche per l’esposizione delle formule e le dimostrazioni, i codici numerici, algebrici, sequenze “ordinali” e “cardinali” ecc.
Le “formule ben formate” dei matematici hanno un loro movimento narrativo e in effetti anche senza capirle, comprendiamo quello che scrive Gambetta: che “una dimostrazione è una narrazione”. Si arriva alla fine a capire che Gödel porta l’umanità oltre limiti della logica, passando alla storia per aver dimostrato l’indimostrabilità di sistemi di assiomi che tuttavia restano veri, ma non possono essere né convalidati né confutati sulla base degli stessi assiomi di partenza. Restavano “indecidibili”, insomma incomplete. Non è facile riassumere le teorie, né questo libro che però ha un suo magnetismo che arriva da questo Bartleby del XX secolo, che si nega al mondo perché ha il pensiero occupato da una sorta di “metamatematica”. Insomma – per dirla ancora con un’immagine – “Incompletezza” fa capire come il “personaggio” Kurt di questa “storia” stia costruendo il Castello di Kafka seguendo il progetto disegnato da Escher. E che, mentre tuti aspettavamo Godot, arrivò chi ci mise di fronte un altro assurdo (almeno agli occhi di noi menti limitate) ovvero la dimostrazione dell’indimostrabilità della verità.
Gödel cercò anche altre sfide, nella seconda parte della sua vita, come dimostrare l’esistenza ontologica di Dio, seguendo Leibniz. Nel frattempo, però la salute cagionevole fin da bambino, divenne ipocondria e poi paranoia (lato forse si nasconde in tutti i logici). Fino alla follia di non mangiare perché temeva lo volessero avvelenare. In questa seconda parte c’è più vita in forma di narrazione consueta, grazie a maggiori fonti. Qui sta il mistero dello sfacelo della mente più geniale del XX secolo e tra i grandi geni dell’umanità. Tuttavia, anche in questo finire, non si cancella, anzi risalta, la grandezza speculativa, che sembra stare oltre la sua stessa psiche e che forse, ultimo paradosso, proprio la follia è un segno di ciò che Gödel cercava di attraversare, spostandosi in quell’altrove che tuttavia non sta in nessuno spazio, se non quello stesso espandere la mente, sfidare l’ignoto.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

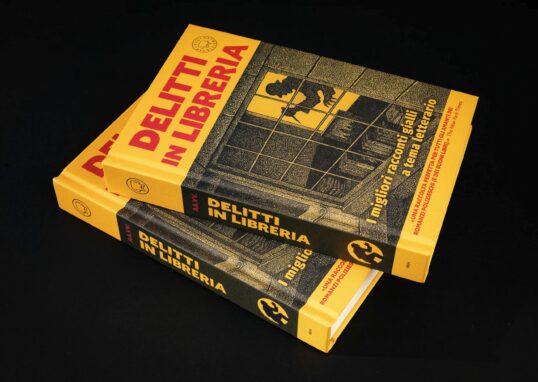
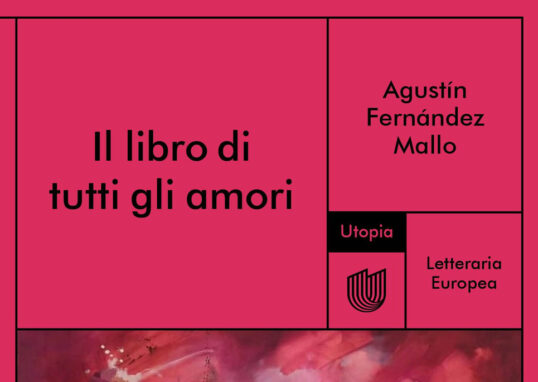
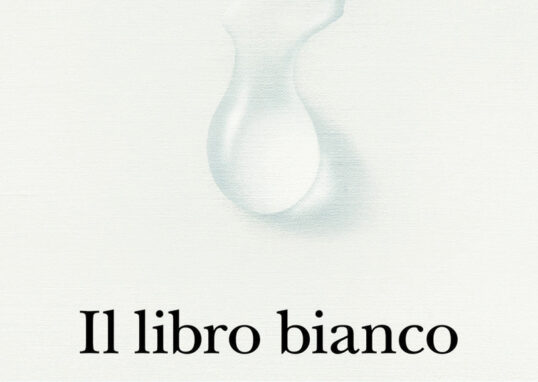



Sto leggendo il libro (up to pag 43) e mi chiedo di che genere è? Novella, romanzo, saggio, biografia? Sono curioso della materia (non esperto) Vorrei entrare in contatto con altri lettori per scambiare informazioni sull’argomento e sul libro ingenerale. Grazie