
«Noi vogliamo tutto, vogliamo anche il pallone».
Fare gol non serve a niente, appena uscito per Add editore, è un saggio molto bello di Luca Pisapia, interessante, moderno, storico, e anche divertente, perfino romantico. Prima di addentrarci nel racconto, ovvero di svelarne il contenuto, possiamo subito affermare che il titolo contiene una grossa verità, che ogni appassionato in fondo al cuore conosce, fare gol non serve a niente, e a niente mai servirà, come la poesia. Il gol è inutile, in quanto è utile in sé, è la conclusione di una serie di momenti, a volte felici, altri meno, poi la palla supera la linea di porta, e poco dopo tutto si esaurisce – gioia o delusione – e si ritorna all’attesa per il prossimo.
No, non serve a niente, ma è meraviglioso. Luca Pisapia compie un viaggio politico e sociale, attraversando la storia del calcio, spiegandoci bene come si sia sempre stata questione di soldi e questa cosa, modificatasi nel tempo, per approccio e modalità di applicazione, non è mai cambiata, mai potrà cambiare. Quindi, l’accezione del titolo del libro è che il gol non serve a niente, perché altre cose sono servite e serviranno alla gestione dei flussi economici, ai guadagni che crescono esponenzialmente, così come le perdite, più o meno nascoste, coperte, salvate in nome di non si sa bene più di cosa. Il gol non cambia davvero lo stato delle cose.
Se la macchina a vapore è stata rimpiazzata dal motore a scoppio prima e da quelli termici poi, il calcio no. È ancora tra noi, eterno ed uguale ad allora.
Il calcio ha una vicenda lunga ed è, tra le altre cose, una storia economica, Luca Pisapia la attraversa, come un esploratore d’altri tempi, che ha conservato da qualche parte la capacità di sognare senza perdere quella di cercare, di osservare, di raccontare i fatti per quello che sono stati, che sono, e, forse, che saranno. Si parte verso la fine dell’Ottocento, a Londra, in una fabbrica sul Tamigi si arriva ai nostri giorni, dietro le scrivanie del potere, europee, arabe. Gruppi di persone, società più o meno nascoste, movimenti più o meno legali, tutto quello che viene prima di un dribbling riuscito.
Era Maradona che diceva che il tifoso accetta solo l’inganno della finta che si fa in campo, ma perfino lui sapeva che lo stesso tifoso è disposto ad accettare qualunque cosa, scendere a compromessi, pur di vedere la domenica successiva di nuovo quella finta. Se fossimo degli appassionati giudiziosi non avremmo mai guardato gli ultimi Mondiali in Qatar, sapendo dei giri di denaro, dello sfruttamento dei lavoratori, trattati come schiavi e lasciati morire. Lo sapevamo, ce lo ricorda Pisapia, ma nulla ci ha impedito di mettere da parte la conoscenza al primo gol di Messi.
Il calcio cambia continuamente, e anche noi cambiamo, ci adeguiamo alle nuove regole, ai nuovi modi di guardare, ci abboniamo, protestiamo, ci abboniamo di nuovo. Mi pare che Luca Pisapia al termine del viaggio ci mostri un poco anche quello che siamo diventati. È cambiato il nostro modo di rapportarci ai calciatori e alle partite. Abbiamo scelto o dovuto scegliere nuovi modi di essere tifosi. Siamo stati popolari ora ci tocca fingere di essere ricchi per accedere a luoghi che vengono spacciati per salotti, per posti dove andare in famiglia (sì, ma che tipo di famiglia?), e così via, questo è un punto fondamentale del ragionamento di Pisapia.
Il valore di scambio fantasmatico della merce sportiva è il suo valore fascista.
La prosa dell’autore è molto bella, si scorre da quelle origini sul Tamigi, tra cantieri e battaglie, tra posti popolari, tra i ricchi che riprendono il gioco in mano, tra il dominio del fascismo e il nostro sguardo bambino che aspetta la rovesciata e chiude gli occhi sul resto. Il sistema che cambia, le tragedie, i morti, i soldi che si spostano rapidamente, e generano vuoti, buchi, che devono essere presto riempiti, le partite che aumentano di numero e perdono di intensità e di volume, ma che non possono fermarsi, bisogna giocare tutti i giorni, bisogna coprire la perdita del giorno precedente. Il primo capitolo si intitola Il pallone non è mai stato innocente, figuriamoci noi.
Il pallone è imprigionato sotto la suola dell’Italian Theory di De Zerbi. Non si muove, eppure viaggia, a velocità altissima. È fermo, eppure crea spazio. Il pallone ha imparato che nel tardo capitalismo la voragine del debito può essere riempita solo con un altro debito. E lo spettacolo delle immagini serve anche a questo.
Per raccontarci tutto questo e molto altro, Luca Pisapia, non si limita a mostrarci il flusso di denaro ma sempre lo mette in relazione al campo da calcio. Perciò, leggiamo dell’Italia che vince tutto sotto il fascismo, o, per esempio, dell’avvento del calcio totale, e cosa ha significato quell’Olanda fuori e dentro il campo. Oppure dell’Argentina della dittatura di Videla, nulla impedì alle persone presenti allo stadio di esultare, mentre in luoghi non troppo distanti da lì avvenivano torture mostruose, ragazze e ragazzi venivano lanciati nel Rio de La Plata. Sparivano. Così come spariscono i soldi per poi ricomparire, magari sotto le sembianze di Mbappé che passa dagli arabi parigini ai ricchi madrileni spostando – almeno in apparenza – una quantità di denaro che facciamo fatica a quantificare, a mettere in chiaro.
Le regole del calcio, quello che avviene in campo, sono cambiate sempre poco pochissimo, mentre fuori è cambiato tutto, quel tutto, che era prevedibile dall’inizio, fa un po’ spavento, eppure non ci ferma – non ferma né l’autore di questo pezzo, né l’autore del libro (sento di poter dire) -, continuiamo a guardare le partite, muniti di spirito critico che sparisce quando il centravanti del cuore fa l’ennesimo gol che non serve a niente. Ma cosa succederà e, forse manca poco, ci spiega Pisapia, quando, in nome del capitale in «Una dimensione immateriale dove si gioca fermando il pallone sotto la suola e non più calciandolo in porta», tutte le squadre avranno un unico padrone?
Fine del viaggio, un’esplorazione in cui i fascisti e Marx, e Cruijff e Kempes, e Videla e Pelè, e gli operai londinesi e i ricchi (milanesi, parigini, arabi, americani) ci hanno fatto vedere la loro parte di highlights. Tutto molto inquietante, tutto molto bello.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/





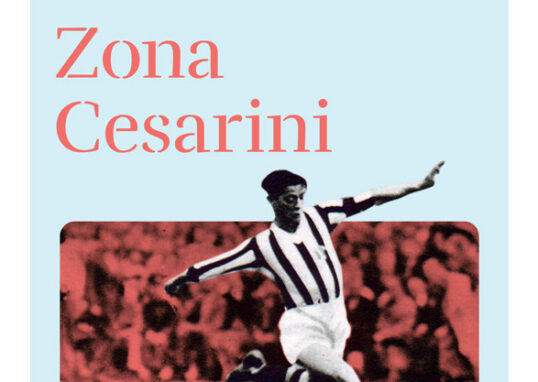

Can you provide me with a detailed explanation of your service?