
Pubblichiamo la relazione tenuta da Edoardo Rialti per la XXIV edizione de I Colloqui Fiorenti– Nihil Alienum, 27 febbraio–1 marzo 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 2300 studenti delle scuole superiori di tutta Italia e dei loro docenti. Per gentile concessione di Diesse Firenze.
Chi fui? Che senso ebbe la mia presenza/in un tempo che questo film rievoca/ormai così tristemente fuori tempo?/Non posso farlo ora, ma devo/prima o poi sviscerarlo fino in fondo,
fino a un definitivo sollievo….Questo si chiede Pasolini stesso “guardandosi guardare” un film al cinema. Debbo fare una premessa. Scusatemi se leggo, mi auguro che comunque sentiate queste parole dette a voi, in qualche modo in dialogo con voi, perché così le ho pensate e scritte. Il tutto è pensato a punti–passaggi, con una premessa. Sono felice di essere qui ma devo anche ammettere che la preparazione di questo incontro non ha lasciato in pace e tranquillo, non solo per la tensione su quanto e come sarei riuscito a dire su un autore che amo tanto e su opere– nello specifico cinematografiche– che a loro volta comprendono alcune delle cose più belle che ho visto, in cui trovo sempre cose nuove, io e non solo io – basti pensare a Robert Eggers, autore del recente e bel remake di Nosferatu che molti di voi avranno visto e che ha citato proprio Medea di Pasolini tra i film che più ammira – e tratteggiare in poco un arco così vasto multiforme e profondo senza scadere nei riassunti e giocandosela facile non è immediato, ma anche perché – e voi lo sapete bene – Pasolini non ti lascia in pace.
Man mano che si avvicinava la data di oggi avevo come un ronzio sullo sfondo degli orecchi, un lavorio, un rovello. Pasolini è uno di quegli autori e uomini di genio che non ha mai lasciato in pace il proprio inconscio, non si è limitato ad accettarlo e farlo lavorare per conto suo, non si limita a creare ma si interroga sul perché sta creando e come. Sul perché questo o quello lo colpisce. Sul perché la sua attenzione si affissa su questo, o quello. Questo coinvolge anche noi, non lascia in pace anche noi mentre lo leggiamo o sorprendiamo un pensiero, seguiamo una intuizione, ci si sorprende a chiedersi perché, con la forza e l’assillo di un pugile che ti viene addosso e ti lascia un fischio nelle orecchie, giacché come diceva Emile Cioran, “la violenza della vita interiore”– Una vita violenta, appunto – “è contagiosa”. Come ha notato Walter Siti, se il giornalismo scomodo deve fare domande a cui il potere preferirebbe non rispondere la grande arte solleva domande cui ciascuno di noi, dentro di sé, spesso non vorrebbe rispondere, ciò che spesso non sappiamo ammettere nemmeno a noi stessi.
I. Sempre lo stesso film
Intervistato all’uscita del film Medea, su quale fosse il nuovo tema che aveva voluto esplorare ed esprimere, Pasolini come di consueto spiazzò il giornalista affermando Non soltanto io non vedo differenza tra l’Edipo e Medea, ma non vedo differenza nemmeno tra Accattone e Medea, e nemmeno molta differenza tra II Vangelo e Medea. Praticamente un autore fa sempre lo stesso film, per almeno un lungo periodo della sua vita, come uno scrittore scrive sempre la stessa poesia. Si tratta di varianti, anche profonde, di uno stesso tema. Sempre lo stesso film. Ma quale. Cosa unisce il mondo dei reietti di borgata di Accattone e Mamma Roma a fiabe picaresche come Uccellacci e Uccellini, affondi nelle radici mitici e religiose dell’immaginario collettivo come Il Vangelo secondo Matteo o Edipo alla fuga in spazi tempi lontani come Il Fiore delle Mille e una Notte col loro modo così remoto e altro di vivere l’amore il sesso il cibo e liturgie funebri di violenza e morte come Porcile o Salò? Cosa li percorre tutti, davvero la medesima urgenza–ossessione? Una prima risposta viene dal titolo stesso del vostro stesso convegno, tratto dalla versione romanzo poema di quel Teorema che è anche film, il racconto del misterioso e bellissimo straniero che irrompe nella vita di una famiglia borghese e fa sesso con tutti i suoi componenti, padre madre figlio figlia e serva per poi lasciarli ciascuno a reagire diversamente a ciò egli ha suscitato in loro. È impossibile dire che razza di urlo sia il mio: è vero che è terribile — tanto da sfigurarmi i lineamenti rendendoli simili alle fauci di una bestia — ma è anche, in qualche modo, gioioso, tanto da ridurmi come un bambino.
Non possiamo certo sostituirci a Pasolini nel definire che razza di urlo sia, appunto, possiamo però ascoltarlo, e, nel caso specifico dei suoi film, persino “guardarlo”. La domanda che sorge a questo punto è però cosa vuol dire guardare. All’epoca della loro uscita in sala i film di Pasolini furono, come le sue opere letterarie le sue posizioni pubbliche la sua stessa mera persona il suo corpo uno scandalo e una provocazione immane. Fu attaccato, vilipeso, trasformato in leggenda grottesca. Ancora oggi egli vien strattonato per la giacca, spesso sminuzzato e sbandierato dagli eredi di coloro che in vita l’hanno odiato e persino aggredito. 33 processi per le sue opere, come gli anni di Cristo, persino il numero è eloquente. Pasolini sapeva rispondere da par suo. Alla prima di Mamma Roma ben oltre i soliti cori Feccia Paola Paola alcuni neofascisti cercarono di colpirli e Pasolini, offrendo a mio parere una eccellente risposta critica a simili obiezioni culturali, li prese lui a pizze in faccia.

Questa foto dal set di un film fu una delle “prove” presentate per suffragare l’accusa che Pasolini avesse rapinato un benzinaio per violentarlo, il tutto con una pistola a pallottole d’oro neanche fosse stato un cattivo di James Bond. La pistola non fu mai ritrovata ma l’accusa per spiegare la connaturata tendenza di Pasolini a delinque lo fece analizzare a distanza da un criminologo che stabilì che Pasolini essendo omosessuale non poteva che covare tendenze eversive. Quello stesso criminologo, amico dei briganti delle mafie romane e meridionali, fu trovato anni dopo con la testa tagliata. Ne Il Pollo ruspante di Gregoretti, uno degli altri episodi che compongono lo stesso Rogopag che comprende la sua Ricotta, Ugo Tognazzi torna a casa e il figlio gioca a sparargli travestito da bandito e il padre gli chiede Chi sei oggi? Mandrake? Nembo Kid? E il bambino gli risponde il più terribile di tutti: Sono Pasolini! Persino questi scherzi che alludono e magari vogliono disinnescare in parte una tensione effettiva testimoniano la medesima forza d’urto. Eppure quell’urlo e quel vortice, la violenza e l’inquietudine, commisti alla bellezza, dolcezza e all’umorismo vengono ancora prima delle tematiche trattate o della crudezza delle immagini. Nel vedere un film di Pasolini capita di chiedersi “Cosa” stiamo guardando, cosa dovremmo guardare in questa quella inquadratura, perché ci fa vedere questo.
Ci sono artisti che creano con già un pubblico al quale sanno di potersi rivolgere, è il caso dei tragici greci, Dante, Zeami in Giappone. Ci sono altri artisti che invece aprono uno spazio nel quale creare il proprio pubblico, un pubblico che ancora non c’è. Come dichiarò Pasolini medesimo Ho detto che non ho speranza di riuscire a dialogare con la massa e quindi mi rivolgo all’elite. Ma quando io ho parlato di élite, mi pare di aver detto ben chiaramente che è un’operazione apparentemente aristocratica, mentre in realtà è un atto di democrazia… ma l’elite la cerco là dove la trovo. Posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operaie avanzate… Il mio interlocutore può essere il metalmeccanico di Torino. Medea può essere percepita da questa élite? Certo. Con difficoltà, perché naturalmente io chiedo allo spettatore tanta attenzione quanta è la fatica che io ho fatto a fare il film. La questione è dunque se noi per primi siamo disposti a essere il suo pubblico a voler guardare dove guarda lui, con lui. Aprirsi a un surplus di conoscenza, come lui diceva stabilendo una differenza con l’amico Moravia quando viaggiavano in India o Africa. La differenza tra me e Moravia, diceva, è che lui a fine giornata dopo un giorno passato a leggere studiare interrogare il reale coi suoi strumenti di intellettuale, va a letto, mentre io esco di nuovo. Questo non è un imbarazzante vizio a latere, ma un vero e proprio per lui imbracciato e arduo metodo di conoscenza. Esporsi alla notte, addentrarsi nella notte, perché come diceva Marina Cvaetava ricordata da Emanuele Trevi, la casa, l’integrità della nostra esperienza si trova nella notte.
II.Volti e grida, una lunga fedeltà, una promessa di sogno condiviso
Pasolini, come tanti della sua generazione ha sempre amato il cinema, la grande esperienza artistica e immaginativa collettiva del XX secolo, la “decima musa”, l’arte nuova che– e questo è decisivo per lui– è possibile fruire e condividere con gli altri nelle sale. Negli anni citerà come modelli amati e ammirati Dryer Chaplin Ejzenstejn Mizoguchi. Sento questa mitica epicità in Dreyer, Mizoguchi e Chaplin: tutti e tre vedono le cose da un punto di vista che è assoluto, essenziale e, in un certo senso, santo, reverenziale. La comparsa di Rita Hayworth nel film Gilda è raccontata in Amado mio una delle su opere più delicate e struggenti. E poi negli anni della sua giovinezza, gli stessi della resistenza e del suo trasferimento a Roma, irrompe proprio nel panorama italiano il neorealismo, un nuovo modo di raccontare la realtà: Visconti– che in Ossessione sfidò la censura fascista raccontando una storia di adulterio, sesso e morte nello sporco assolato di una provincia italiana che pare qualche landa americana della Grande Depressione e poi ne La terra trema arriva ad adattare I Malavoglia di Verga facendo recitare solo autentici pescatori siciliani, scrivendo con loro la sceneggiatura, De Sica, Rossellini che in Roma città aperta racconta le sofferenze redentrici e condivise di un intero popolo.

Ecco dunque l’urlo di Anna Magnani, che egli vorrà poi in Mamma Roma, nella scena cardine in cui la donna e madre viene falciata da una scarica di mitragliatrice in Roma Città Aperta, così come lo ricorda anni dopo ne La Religione del mio Tempo, espressione di un dolore comune e, attraverso esso, anche di un viaggio di speranza e cambiamento vissuto insieme da un intero popolo: Ecco l’epico paesaggio neorealista…/Quasi emblema, ormai, l’urlo della Magnani/,sotto le ciocche disordinatamente assolute,/risuona nelle disperate panoramiche,/e nelle sue occhiate vive e mute/si addensa il senso della tragedia./è lì che si dissolve e si mutila/
il presente, e assorda il canto degli aedi. Non abbiamo pressoché tempo per soffermarci su tante altre sue poesie sui film che egli stesso avrebbe fatto. Quel che conta in questo passaggio è ricordare che Pasolini negli anni difficili del suo arrivo a Roma inizia a lavorare come sceneggiatore per il cinema altrui. Per i film di Mario Soldati, oppure collaborando ad alcuni elementi de La dolce vita o ai dialoghi de Le notti di Cabiria di Federico Fellini. In tutto questo monta in lui però una sorta di insofferenza duplice, sia alla resa dei suoi contributi nelle scelte artistiche altrui sia un più generale scoramento per l’involuzione del neorealismo stesso che egli arriva a definire una “crisi vitale” della cultura italiana che però non è riuscita a tradursi in altro o a durare nella sua energia effettiva originaria e in qualche modo si sgonfia. La borghesia italiana, sottoscritta dalla Chiesa cattolica, aveva chiuso un periodo culturale, l’età del neorealismo. Sono gli stessi anni dei suoi romanzi e dell’interrogativo appunto– rivolto ad esempio al poeta Carlo Betocchi– su cosa voglia dire essere realisti. Di qui il desiderio crescente di gettarsi egli stesso nel linguaggio cinematografico, senza pressoché formazione previa, con l’entusiasmo di una sua visione e uno slancio che a molti intorno a lui pare sconcertante, ingenuo. Alla domanda di un operatore per le riprese di Accattone su quale lente usare per la sequenza Pasolini serafico ribatté “Perché ne esistono più di una?” Lo stesso Federico Fellini che doveva produrre il film, visionando il girato ne fu così imbarazzato e perplesso che si tirò fuori dal progetto. Si trattava in effetti di qualcosa mai visto prima, sia per cosa mostrava che per il come lo mostrava.
III. Niente altro che realtà. Il grande codice. Montaggio e morte
Cosa cerca Pasolini nel cinema, dunque? Una possibile risposta a un suo profondo desiderio sia conoscitivo che comunicativo. Le due cose sono intrecciate, sono tutt’uno.“Non so cosa darei perché, semanticamente, la lingua italiana avesse la validità assoluta e omologante di una immagine fotografata”. Il cinema rispetto ad altre forme espressive pare intercettare questa sua voglia di vivere fisicamente sempre a livello della realtà. Il cinema non è altro che la realtà, dichiara lui stesso. Al cinema la realtà si esprime attraverso la realtà. Noi abbiamo un codice attraverso cui decodifichiamo la realtà. Ora questo codice è lo stesso che ci permette di decodificare le immagini riprodotte della realtà, cioè del cinema. Questo significa che il codice del cinema e della realtà sono sostanzialmente identici. Ecco cosa gli interessa del cinema, e ciò che Pasolini ritiene di poter vivere ed esprimere attraverso di esso. Un modo di rapporti con le cose e tradurle–trasportarle in arte che partecipa di quello che egli stesso definisce una sorta di credo di base. Ora per me, che non sono credente, devo ricorrere a una specie, diciamo così, di ontologia: la realtà è il complesso di segni attraverso cui la realtà si esprime. Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non attraverso dei simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa […] Io rappresento la realtà usando la realtà stessa. Questo mi permette, usando questo mezzo di espressione artistica, di vivere sempre al livello e nel cuore della realtà.
Ecco la differenza con altri linguaggi artistici, persino con la letteratura e la poesia che chiedono sempre all’artista di trasformare una immagine un sentimento un ricordo in parole che a sua volta il lettore deve assumere in sé e fare proprie. Quando faccio un film […] non c’è fra me e la realtà il filtro del simbolo o della convenzione, come c’è nella letteratura. Quindi in pratica il cinema è stato un’esplosione del mio amore per la realtà. Eccolo fare un esempio che sembra riecheggiare Pascoli, che egli conosceva bene, il Pascoli del “lampo e del tuono” che sarà noto anche a molti di voi studenti. Persino un’immagine sonora, diciamo un tuono che rimbomba in un cielo nuvoloso, è in qualche modo infinitamente più misteriosa di quanto anche la descrizione più poetica che uno scrittore possa darne. Uno scrittore deve trovare l’oniricità attraverso un’operazione linguistica molto raffinata, mentre il cinema è molto più vicino ai suoni fisicamente; non ha bisogno di alcuna elaborazione. Tutto ciò che serve è produrre un cielo nuvoloso con un tuono e subito sei vicino al mistero e all’ambiguità della realtà. Non una evocazione magica a posteriori, ma la realtà stessa.
Un altro esempio viene dal viso della grande attrice Silvana Mangano e Pasolini per spiegare lo scarto tra la sua rievocazione in un linguaggio poetico o narrativo e la mera forza della sua presenza sullo schermo, immagina che l’amico Moravia si provi da scrittore a descriverla Tutta la fatica di Moravia a descrivere gli occhi, le bianche guancie, le sopracciglia depilate, la commovente gola, il profumo di primule, della Mangano (e lo farebbe magnificamente) non sarebbe altro che un atto demiurgico per trasportare la sua esperienza della realtà della Mangano nell’esperienza della realtà della Mangano del lettore? Tutto questo si incarna nello strumento medesimo che consente di realizzare un film, la macchina da presa, come si dice, e Pasolini brandisce l’espressione come una dichiarazione di metodo. Ho affrontato la macchina da presa ed essa mi ha dato la stessa ebbrezza della scoperta di un linguaggio che provavo quando mi nascevano i primi versi negli anni della giovinezza. Prendere la realtà, afferrarla, questa è l’esperienza fondamentale, l’unica cosa che conta davvero. Anche per questo Pasolini parla di cinema di poesia contrapposto al cinema di prosa, un cinema dove le cose in sé hanno valore e non unicamente per il ruolo che svolgono nella storia raccontata. Ninetto Davoli avrebbe poi raccontato che in certi viaggi, colpito da una scena o un passante, Pasolini si faceva passare la cinepresa e girava anche se intorno continuavano a ripetergli che non c’era pellicola per registrare. Non importava. Il gesto era un richiamo in sé. Capite forse un po’ meglio perché Pasolini avversasse tanto la televisione e i media di massa, invece, perché anziché essere l’espressione di uno sguardo singolo individuale concreto nel dialogo col mondo, questi appiattiscono gli sguardi in una melassa anonima e omologante.
Il cinema invece consente al tempo stesso due esperienze. Esperire il mondo così come lo percepiamo sempre e di per sé– la vita è una lunga costante ripresa con gli occhi a cui si sovrappongono altre immagini, i ricordi e i sogni, e vedere quello che Pasolini stesso sta guardando, inquadrando. Per questo, egli spiega, il suo stesso modo di riprendere (gestito sempre personalmente con al telecamera a spalla, coinvolgendo in primo luogo la sua persona, il suo corpo concreto) punta su alcuni stilemi fondamentali che vogliono assecondare il nostro stesso modo di guardare il mondo mentre lo viviamo. Non ci sono piani–sequenza, non ci sono entrate e uscite di campo, non ci sono personaggi di profilo o di quinta, non ci sono attacchi diretti di montaggio sullo stesso asse. Uno degli espedienti tipici del cinema è ad esempio il campo medio con due personaggi ripresi nella medesima azione, Pasolini invece non vuole simili artifici sintetici perché non è così che un dialogo viene vissuto dalle due parti in causa. Ciascuna vede ed è vista, rivolta verso l’altra che occupa il suo campo visivo e di conseguenza il nostro. Non ho mai qualcuno che parli a distanza ravvicinata dalla telecamera; Devo farlo parlare direttamente alla telecamera, quindi non c’è mai una scena in nessuno dei miei film in cui la telecamera è da un lato ei personaggi parlano tra di loro. Sono sempre in campo contro campo, o tiro al contrario. Quindi scatto così: ogni persona dice la sua parte e basta. Non faccio mai una scena intera tutta in una ripresa. Ciò gli fa dichiarare che La soggettiva è dunque il massimo limite realistico di ogni tecnica audiovisiva. Non è concepibile «vedere e sentire» la realtà nel suo succedere se non da un solo angolo visuale: e questo angolo visuale è sempre quello di un soggetto che vede e che sente. Il suo di regista, quello del personaggio, e per sovrapposizione immediata, il nostro.
Questa soggettività, espressa ad esempio dal bellissimo momento in cui Edipo–Pasolini bambino vede in un colpo solo il cielo e gli alberi e sua madre, per Pasolini è parte decisiva del nostro rapporto col reale, il primo canale attraverso cui la realtà ci si impone e suscita un movimento di risposta. Il cinema ha qualcosa di sostanzialmente sacrale (…) ed è questo, in fondo, l’elemento stilistico che io seguo nel girare i miei film. Cerco di rappresentare questa frontalità del reale con rispetto e anche venerazione per la realtà, perché non sono uno che ha paura di avere rispetto e venerazione per qualcosa. Ricordate forse Leopardi che notava come ogni cosa susciti nel poeta una vista doppia. A Pasolini verrebbe da dire, persino tale vista doppia non basta. Meglio accecarsi come Edipo o meglio ancora ne occorre una triplice per provare ad accogliere davvero la realtà.
Tutta la sua opera in ogni forma è percorsa da questa tensione. Come vedere di più e davvero. Ossia come amare e conoscere. Addirittura nella sua ultima opera Petrolio non gli “basta” sdoppiare il protagonista Carlo in uno che vice e conosce il mondo di giorno e l’altro che lo esperisce di notte perlopiù facendo sesso di continuo, ma addirittura fa cambiare a entrambi sesso per una stagione, li fa diventare donne, proprio come il veggente Tiresia che per conseguire saggezza era diventato donna per alcuni anni. La telecamera si rivela così una sorta di terzo occhio come quello delle tradizioni mistiche orientali che si schiude per contemplare davvero, come un iniziato o uno sciamano, il mistero. L’esperienza è sempre una soggettività e al suo culmine o alla sua radice, una passività. Per questo sesso e sacro in Pasolini sono per così dire tutt’uno. Il sesso in Pasolini –nella declinazione specifica della sua tinta, della sua esperienza omosessuale– è proprio l’esperienza cardine di questa costante penetrazione del reale. Il sesso è come la manifestazione più esplicita del sigillo perenne che la realtà imprime dentro di te, in opposizione al calcolo, alla misura, al possesso che è sempre un mettere via, un capitalizzare quello che invece si può solo ricevere ancora e ancora. È fuori discussione che il Possesso è un Male, anzi, per definizione, è IL Male : quindi l’essere posseduti è ciò che è più lontano dal Male, o meglio, è l’unica esperienza possibile del Bene, come Grazia, vita allo stato puro, cosmico. L’essere posseduti è una esperienza cosmicamente opposta a quella del possedere. Da parte di chi è posseduto colui che possiede è dunque sentito come un Bene, anche se esso implica il sacrificio, il dolore, l’umiliazione, la morte.
La morte, appunto. L’altra somiglianza fondamentale tra vita e cinema è che entrambe hanno bisogno della morte per trovare senso, compimento. Un film dopo essere girato va assemblato in una serie di sequenze che vanno dall’inizio alla fine ed esprimono così una parabola. È dall’ultima scena cui segue lo schermo nero che si capisce l’inizio e il mezzo, lo svolgimento. Così è della vita, è proprio il suo limite a darle valore a farne un percorso. È dunque assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso, e il linguaggio della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi (e non più ormai modificabili da altri possibili momenti contrari o incoerenti), e li mette in successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile e incerto, e dunque linguisticamente non descrivibile, un passato chiaro, stabile, certo, e dunque linguisticamente ben descrivibile. Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci. Il montaggio opera dunque sul materiale del film (che è costituito da frammenti, lunghissimi o infinitesimali, di tanti piani–sequenza come possibili soggettive infinite) quello che la morte opera sulla vita.
IV. Rendere visibile l’invisibile ovunque. La battaglia
Hai fatto un film stupendo […] Io non conosco di persona quel mondo, dovessi frequentarlo proverei qualche ripugnanza o paura; eppure il film me lo interpreta come un mondo comprensibile, umano, fraterno” scrisse Franco Fortini a Pasolini dopo Accattone traduzione in cinema di quanton aveva già tentato con Ragazzi di vita. Era come se Pasolini nel solco del neorealismo, già lo squarciasse dall’interno, rendendo visibili luoghi, persone, un certo modo di essere al mondo– quello delle borgate romane– che era stato invisibile ai radar culturali e ideologici persino del neorealismo stesso. Nessun popolo che si rimbocca le mani per migliorarsi, nessuna lotta verso un domani migliore in nome della lotta di classe. Le usuali e condivise categorie morali e ideologiche non contano qui. La citazione d’apertura è altrettanto sconcertante. Per una lagrimetta che ‘l mi toglie. È una battuta del demonio che nella Commedia di dante si vede strappare da un angelo un peccatore che muore con un solo istante di struggimento verso Dio. Questo per raccontare la vita di un pappone di prostitute che ha abbandonato suo figlio e vive di furtarelli? Dov’è la lacrimetta di Accattone? È la sua vita stessa, che per Pasolini resta comunque più in contato col mistero profondo della vita di tante altre geometrie di senso che cercano di spiegare raddrizzare la vita medesima. Accattone ha il volto di Franco Citti, fratello di Sergio, da poco scoperto Come Accattone, anche i suoi amici sono attori non professionisti.
Pasolini inaugura col primo film una pratica nella scelta degli attori alla quale si atterrà anche in seguito come a un invariante principio regolativo. Li sceglie essenzialmente per ciò che sono come persone, preesistenti a ogni richiesta recitativa, non per la loro capacità di simulazione. Per il loro essere, non per quanto sanno fingere di essere. Con un pendolo che tocca due estremi. Sottoproletari e attori. Innocenza e estrema autoconsapevolezza culturale. Attori del neorealismo come il Girotti di Visconti, la Magnani di Rossellini, persino registi come Orson Wells (che fu pensato anche come voce di Darth Vader, per gli appassionati qui di Star Wars), la Maria Callas che Pasolini vorrà per Medea non tanto quale sublime cantante lirica, tanto che non la fa mai cantare nel film, ma proprio per il suo viso e la sua storia di donna greca trapiantata nel jet set internazionale. Intorno a questa sua Cerca si coagulano i volti e gli interlocutori di tutto il suo viaggio. Sergio Citti come sceneggiatore e suo fratello Franco, una sorta di Virgilio guida in quel mondo altro in cui Pasolini si addentra e che per lui sarà Accattone, Edipo, Ser Ciappelletto, un cannibale, il demone de Le Mille e una Notte. Laura Betti (che darà pure la voce al demonio de L’Esorcista, per interessati all’horror), Ninetto Davoli che – laddove Citti era Virgilio o Hermes – sarà invece la Beatrice che egli non si stanca mai di contemplare, al tempo stesso Musa, discepolo, figlio, grande fondamentale amore della vita, sogno di una innocenza edenica.
I film che seguono Accattone sono come il diario di bordo intrecciato agli altri linguaggi di Pasolini, dalla poesia alla saggistica al teatro, di una medesima traversata conoscitiva, un addentrarsi in quell’invisibile da rendere visibile, fatta di approfondimenti, scossoni, ripensamenti, scandita da un perenne rovello, da una inquietudine che spinge Pasolini continuamente a reinventare i propri linguaggi e scelte, a non accontentarsi mai, persino a rinnegare i propri tentativi precedenti. Questo perché il potere intorno e la sua violenza cambia rapidamente, troppo rapidamente faccia e metodo. Pure il socialismo è, nelle parole di Pasolini, divenuto spesso un nuovo cattolicesimo, dogmatico, moralista. Già in Uccellacci e uccellini il crudo realismo si trasferisce verso la fiaba e l’immensamente umano delle fiabe incarnato dal viso e dai gesti di Totò per provare a raccontare –per così dire– la morte stessa del neorealismo perché il nuovo modello d’uomo ha infettato persino quelle riserve indiane che erano le borgate.
Come nelle sue poesie e interventi Pasolini tenta anche opere aperte come i documentari o gli appunti sui film che poi non avrebbe girato, come se l’incompiutezza fosse un altro radicale modo per esporsi al contributo di una realtà esterna più ampia ancora del suo sforzo creativo medesimo, un lavoro che non si risolva in solitudine come ebbe a scrivere nella poesia sulla ricerca dell’attore che avrebbe interpretato Gesù nel suo film sul Vangelo. Penso allo straordinario lavoro che fece per l’Onu sulla città di Saana insidiata dalla distruzione capitalistica. Tutto questo si accompagna all’esigenza di leggere il presente attingendo però alle radici del nostro alfabeto immaginativo, alla religione o al mito, che hanno espresso in modi diversi lo stesso dialogo tra la vita del singolo e la pressione di un mistero che solo pare conferirgli la sua piena e oscura identità rispetto all’omologazione del potere. Ecco dunque quasi a staffetta il Vangelo, Edipo, Medea, tutti film operati con collassi prodigiosi e geniali che sono in grado di trovare, vedere la Palestina nel meridione d’Italia, o la Grecia in Marocco, e che sono in grado di scegliere come colonne sonore canti tradizionali ungheresi, i blues degli schiavi neri in America senza soluzione di continuità con la musica classica di Mozart o Bach.
Perché tutto punta nella medesima direzione, i paesi poveri della Basilicata non sono una metafora della Palestina di Gesù, sono i luoghi dove ancora si svolge la vita di quegli ultimi e reietti e sconosciuti cui Gesù si rivolgeva e dichiarava Beati, rendendoli visibili nel suo predicare come figli del Padre celeste. Ma pure questo sembra non bastare ed ecco allora che Pasolini decide di parlare alla modernità consumistica rinnegandola in toto, muovendosi fuori di questo tempo e spazio, in una dimensione dove le moderne categorie e contrapposizioni non esistevano e basta, nel passato medievale d’Italia o in geografie e culture diverse e altre come lo Yemen. È la Trilogia della Vita, che fu derubricata e attaccata come pornografica o decadente e invece è composta di film straordinari, dove tutto è dialogo con la realtà autentica, mangiare defecare fare sesso, dove ancora si sorride e piange nello stesso modo, in una accettazione che invece è resa impossibile e falsata dall’omologazione del consumismo e della civiltà tecnologica. Anche in questi film, come nei suoi interventi più celebri e travisati, Pasolini non è un mero conservatore che esalta mondi rurali e arcaici, la sua ossessione è quella per una esistenza dove ciascuno possa essere davvero lui o lei, in rapporto a storie e linguaggi che non siano dettati dal potere di turno.

Il successo è l’altra faccia della persecuzione, lo ha detto Pasolini e per la prima volta nonostante le censure e gli attacchi i suoi film hanno un grande e sbagliato successo. vengono visti come altrettante audaci commedie scollacciate al pari delle tante che vanno in voga in quegli anni, non in opposizione al sistema consumistico ma fagocitate da esso. Di qui l’Abiura che Pasolini dichiara dei suoi ultimi lavori, al pari di Freud che a inizio secolo compì una operazione analoga con la sua produzione precedente. Pasolini ha sempre usato parole forti, radicali, genocidio per quello che accadeva agli italiani sotto il boom economico, e adesso abiura per il suo stesso operato. Quello che segue in Pasolini, il suo ultimo film compiuto nel perenne e sempre più tragico e dolente tentativo di capire ancora il mondo è una feroce sinfonia funebre. Uno schiaffo in faccia, uno scandalo, una discesa estrema nell’infermo del nuovo fascismo, il potere anarchico senza faccia che ha fatto dei corpi stessi la propria merce.
A rivederlo oggi, Salò non spaventa tanto per la sua crudezza ma ancora una volta per la capacità di Pasolini di vedere e prevedere e additare quello che poi sarebbe diventato comune, così diffuso che neppure ci facciamo più caso. Salò già racconta col suo palazzo delle torture l’immenso reality show del mondo contemporaneo e dei media e degli strumenti che abbiamo in tasca in questo preciso momento, nel quale nella mera ripetizione ci si abitua a tutto e si fa pornografia persino delle emozioni più private, nel quale non c’è differenza tra postare la foto di un bambino affogato ina barca di migranti, una rissa in strada, un balletto nella propria stanza. L’osceno – letteralmente il fuori scena– è sbattuto in faccia perché ogni aspetto della vita è in vendita, la vita stessa è pornografia nel mercato globale del nuovo potere. Persino il racconto e l’arte– ed è una delle scelte più desolate di Pasolini– sono ormai ridotti al servizio del potere come altrettanti pianisti e coristi in un saloon dell’orrore, mero stuzzichio dei sensi stanchi.
V. La cometa, il pugno chiuso e una scritta sul tappeto

Tutto questo viaggio complesso, fatto di rovelli, spinte e controspinte comprende anche diversi autoritratti di Pasolini stesso, il suo stesso corpo e sguardo coinvolti. Comparse come il rappresentante del coro in Edipo. Il ruolo del Pittore del Decameron o dello scrittore di Canterbury, la voce nei documentari che accompagna il suo sguardo dietro la telecamera. E poi ci sono i ritratti di certi suoi tratti in alcuni dei personaggi e protagonisti, l’Edipo che dapprima, sono parole sue, è esteta decadente poi intellettuale comunista illuminista impegnato e infine al culmine della tragedia più nulla, l’identificazione di sé e del fratello Giulio ucciso con Cristo stesso tanto che sarà proprio la sua adorata madre a impersonare Maria, in una sorta di cupa profezia giacché effettivamente a quella donna toccherà due volte in vita sopravvivere a un figlio assassinato. In teorema egli è tanto il giovane figlio artista che cerca di riprodurre il blu degli occhi dello Straniero che la madre che lo cerca in una serie infinita di incontri sessuali. Quel “nulla” di Edipo alla fine del film però è stranamente pieno.
Pasolini negli ultimi anni si presenta come uomo rassegnato persino disperato ma al contempo resta pieno di pieno di progetti, di slanci. Per questo desidero la mia conclusione non conclusione si sofferma su due scene diverse che mi sembrano puntino nella stessa direzione. La prima è appunto da un progetto che gli non poté realizzare e che aveva in cantiere dopo Salò, assieme al film su San Poalo che doveva essere dalla sceneggiatura un duro attacco su come l’afflato spirituale si sclerotizza in quella che lui chiama la nevrosi moralistica della Chiesa, ossia una grande fiaba di viaggio con Eduardo De Filippo, altro re della commedia napoletana (che aveva doppiato un vecchio in Canterbury), e Ninetto Davoli, dal titolo Magio Randagio o Porno Theo Kolossal. Raccontava le avventure di due novelli re magi napoletani che seguono alla cometa e alla fine arrivano troppo tardi, per la cometa e il messia annesso. Alla fine il vecchio re magio commentava guardando il mondo intero dall’alto È stata un´illusione quella che mi ha guidato attraverso il mondo, ma è stata quell´illusione che del mondo mi ha fatto conoscere la realtà. Eppure, come tutte le comete, anche la cometa che ho seguito io è stata una stronzata. Ma senza quella stronzata, Terra, non ti avrei conosciuto.
L’altra è proprio dal film più tenebroso, Salò. Gli unici due momenti di ribellione espressi nel film sono quello di un giovane che decide liberamente e segretamente di fare l’amore con un’altra prigioniera di pelle nera e che sorpreso rivolge il pugno chiuso della lotta comunista ai carcerieri che lo freddano sul posto– anche nella svendita del desiderio e dei corpi, il desiderio personale e pure le conseguenze ideologiche che se ne traggono o lo alimentano, resistono, ma come diceva Pasolini, L’ideologia (per ideologia intendo il modo di concepire la vita) viene dopo; l’altro è quello di una ragazza prigioniera delle sevizie che scrive Dio sul tappeto, nome che poi sarà pure evocato piangendo.
Perché ho citato queste scene? Mi sento di poter affermare– è una immagine un po’ incerta, ma la sento attiva– che per Pasolini il problema non è tanto di raggiungere la verità, la verità per come la concepiamo è qualcosa di troppo vasto che rischia sempre di ridursi, forse necessariamente, a un capitale messo via, a una definizione troppo angusta e riduttiva e in fondo moralistica della vita. Sono sempre e solo tentativi di espressione per qualcosa che viene prima durante e dopo, la passione che la vita stessa ci suscita.
Come nel dialogo tra Giasone e il centauro diventato uomo con due sole gambe, ridotto a ragione e coscienza, non più sciamano mitico e sacrale. Il centauro gli espone dei fatti che sono Al di fuori dei tuoi calcoli e delle tue interpretazioni e Giasone risponde A cosa mi serve saperlo? A nulla. È la realtà. E tu per quale ragione me lo dici? Perché nulla potrebbe impedire al vecchio centauro di ispirare dei sentimenti e ame nuovo centauro di esprimerli. Le espressioni dunque sono necessarie ma non bastano mai non ci mettono al sicuro. È il leitmotiv di film come Edipo, Teorema, Medea nei quali si racconta la catastrofe dell’anima che si riduce a coscienza, ideologica, intellettuale moralistica. Quello che conta per Pasolini, prima durante e dopo qualunque verità scoperta imbracciata e comunicata, è di restare autentico davanti alla realtà. Restare autentici, cosa voglia dire davvero forse neppure lo so, ma così sento e ve lo comunico come punto di lavoro aperto. In questo però ci si può incontrare, in questo credo che possiamo incontrarci con Pasolini ancora oggi, essere creativi con lui, lasciarci come lui investire dal mondo e da ciò che suscita in noi come struggimento, desiderio, bestemmia e invocazione a bucare il ghetto del potere, di qualsiasi potere. Essere autentici prima ancora che definire la verità, e anche dopo averla definita con un gesto politico o un viaggio di conoscenza. Come noterà nella scena d’apertura dell’incompiuto Petrolio, Non ci si può comprendere a parole. L’unica dimostrazione di buona volontà reale è l’azione comune: anche, e tanto più, se scandalosa. Bene dice alla fine Polis venendo a patti con l’Inconciliabile, allora che cosa vuoi fare? Si può solo fare insieme. Allora, cosa vogliamo fare con Pasolini?
Edoardo Rialti scrive per “L’Indiscreto” e “Il Foglio”. È traduttore per Mondadori delle opere di R. K. Morgan, G. R. R. Martin, J. Abercrombie. Ha curato opere di Shakespeare, Wilde, C. S. Lewis. È autore delle biografie letterarie di C. Hitchens e J. R. R. Tolkien.


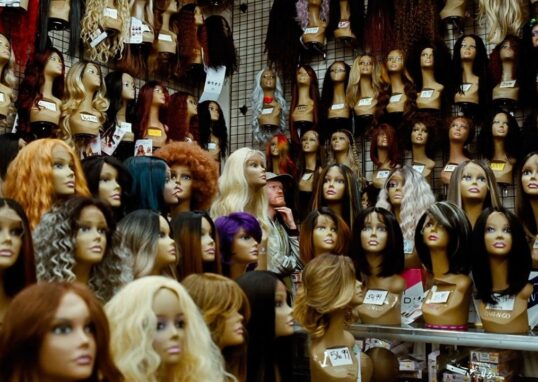




Splendida riflessione sulla poesia del cinema di Pasolini. Proprio questo sguardo “frontale” torna nei borghi: il Cilento Fest premia “Una faccia da cinema” e omaggia Ninetto Davoli, ponte vivente tra tradizione e sperimentazione.