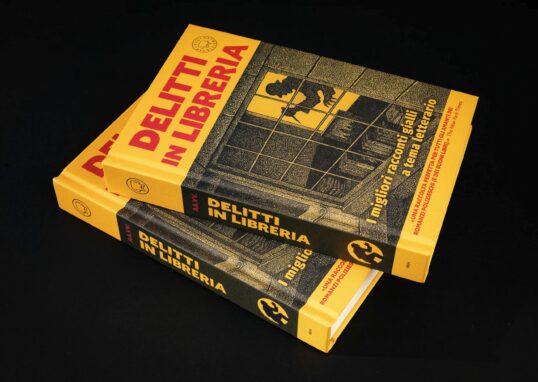«Ogni tanto ho paura di non riuscire a farti capire bene quello che è successo, perché ho questo modo così freddo di raccontarlo».
La storia della dittatura argentina più passa il tempo e più mi sembra una storia mia. Come se fossi argentino, come se in quel paese fossi nato, come se avessi avuto un fratello torturato, una madre desaparecida. Di certo questo sentimento (perché di questo stiamo parlando) nasce dal fatto che io ami molto quel paese, dalla mia grande passione per la letteratura di quelle latitudini, e – soprattutto -dal fatto che le vicende terribili che hanno patito gli argentini le ho a lungo studiate, lette, osservate, anche da vicino, andando nei luoghi dove gli orrori accadevano. Penso e ho pensato più volte che ciò che è accaduto laggiù potrebbe accadere dovunque e a chiunque da un giorno all’altro. Avevo cinque anni quando la Giunta militare guidata da Videla prese il potere in Argentina, mio padre mi diceva solo che stavano accadendo cose terribili, non andava oltre.
Leggere molti libri, belli, bellissimi – saggi, romanzi, racconti, poesie – che trattano o si ispirano a quegli anni non esaurisce mai l’argomento / sentimento; ogni tanto accade qualcosa di nuovo, una scrittrice o uno scrittore che, attraverso una nuova forma, spostando il punto di vista, ti raccontano un altro pezzo della storia e ti riportano di nuovo in quei posti, insegnandoti, spiegandoti, commuovendoti. È il caso della recente pubblicazione di Sur, La chiamata. Storia di una donna argentina, scritto dalla giornalista Leila Guerriero e tradotto da Maria Niola. Libro che, per ciò che mi riguarda, è il più bello letto fino a questa parte di anno.
Mi diceva: “Signora, se fosse per me lei non sarebbe qui”. Ma quel tipo era lo stesso che una notte entrò nel cubicolo di una delle ragazze sequestrate e le disse: “Succhiami il cazzo”.
Nel 1976, Silvia Labayru, durante la dittatura di Videla, fu rapita, torturata, violentata, costretta a subire di tutto, fino a dare la luce alla sua prima figlia, senza assistenza, in una stanza del centro di detenzione clandestino in cui era prigioniera. Aveva vent’anni, Silvia – come i molti caduti in quegli anni, torturati, uccisi, lanciati nel Rio de la Plata e per sempre desaparecidi – faceva parte di Montoneros, gruppo di lotta armata di matrice Peronista. Era una ragazza, era bellissima, lo è ancora. Venne rilasciata nel giugno del 1978, prese un volo per Madrid – come tanti esiliati di quegli anni – e pensò di averla scampata, di poter cominciare una nuova vita. Non era così, non del tutto, non immediatamente. Ad attenderla c’era un coro di voci, di dita puntate, gli altri compatrioti in esilio che, in sintesi, dicevano: «Come puoi essere sopravvissuta, tu e tua figlia, senza aver collaborato, senza aver tradito?»; accusa comune a molti dei superstiti alle torture.
Quelle accuse, quel sentirsi ripudiata è durato molti anni, fino a che piano piano, Silvia, ha ricostruito, ricucito la sua vita accanto ai pochi amici rimasti e a quelli che le ha concesso il tempo a venire. Questo libro racconta la sua storia che è diversa da ogni altra storia sui desaparecidos. Ogni superstite fa storia a sé, ogni morto ha una vicenda diversa. Leila Guerriero è una giornalista bravissima, precisa, determinata, empatica. Guerriero scrive benissimo, il suo racconto è il racconto fatto insieme a Silvia, figlio di circa due anni di conversazioni, chiacchierate davanti ai caffè, a casa di Silvia a Buenos Aires, nei bar, nei taxi, a pranzo. Oppure al telefono con messaggi audio, con frasi che aprivano a conversazioni future. Guerriero è riuscita a scrivere forse il grande testo sulla dittatura scrivendo la vita di una donna, l’anello mancante, e ci è riuscita tra le altre cose, grazie alla libertà e alla forza mentale di Silvia – che non è mai cambiata da quando aveva vent’anni -, e ci è riuscita grazie alla sua capacità di domandare e a quella ancora più rara di ascoltare. La chiamata riesce nel suo compito perché diventa, agli occhi di chi legge, la certificazione di qualcosa che nasce e diventa l’amicizia tra due donne straordinarie.
Capita spesso che invece di dire “quando sono scomparsa”, dica “quando sono morta”.
Leila intervista Silvia e gli amici del tempo, chi è stato esiliato e chi è rimasto, intervista la figlia nata nel centro di detenzione, intervista il figlio nato dopo quegli anni. Intervista compagni, amanti di Silvia. Chi le è rimasto sempre accanto per come ha potuto e chi le ha voltato le spalle. Ne esce un grande affresco sui giorni della dittatura e sugli anni successivi perché il tempo fa il suo lavoro ma certe cose non passano mai. Per esempio, mai come in questo libro, si percepisce bene la vita difficile di chi è sopravvissuto alle torture. Chi, come Silvia, riparava in Europa, o in altri stati del Sudamerica, era guardato con sospetto dagli altri esiliati. Eri vivo, avevi tradito. Silvia, invece, non ha fatto nemmeno un nome, mai. Il suo essere liberata è figlio di una serie di circostanze, tra queste anche la chiamata, appunto, telefonica, ricevuta da suo padre un giorno di marzo del 1977. Silvia ha un’intelligenza fuori dal comune e non ha mai smesso di farsi domande neppure quando veniva torturata o stuprata. Si è sempre messa in discussione, ma è rimasta libera. Quando è tornata in Argentina nel 2018 – costruendo una vita di coppia con un grande amore smarrito negli anni terribili, ma mai perduto – ha denunciato gli abusi sessuali; si badi bene che non si faceva distinzione tra tortura e violenza sessuale, e invece sono due cose diverse, due reati e chi è colpevole deve pagare per entrambi.
C’era da impazzire. Una settimana prima ero dov’ero, e una settimana dopo mi ritrovavo lì, circondata da quella gente, con un daiquiri in mano, senza poter dire da dove ero uscita.
Ci si commuove spesso quando si legge. Leila Guerriero è molto brava a fare avanti e indietro nel tempo, a sciogliere i nodi assemblando le conversazioni con Silvia, con le altre testimonianze e con i suoi appunti. Non smette mai di avere dubbi, di interrogarsi, perché la vita di Silvia non la si può osservare tenendo conto di un solo punto di vista. Non si può raccontare l’Argentina di quegli anni senza scavare a fondo, senza dubitare, senza tremare. Tra le scene in cui, leggendo, si vacilla, ci sono quelle in cui Leila e Silvia vanno a visitare (più di una volta) il centro di detenzione che oggi è un museo, un luogo della memoria. In quelle pagine l’equilibrio tra ciò che vediamo oggi e ciò che è stato è perfetto. Silvia vede ciò che c’è adesso, una mostra fotografica, una conferenza e vede all’indietro. Gli spazi sembrano diversi, così come la luce, non c’è la musica insistente usata dai torturatori per coprire le urla. Non c’è più il dolore, eppure c’è ancora, la ferita rimane, anche se vai avanti, anche se come Silvia hai avuto una vita appagante.
In quest’ultimo senso offro questo libro: è il ritratto di una donna. Un tentativo.
Leila Guerriero ha scritto un libro che va oltre l’esperienza collettiva della dittatura, un testo che esplora le luci e ombre che sempre attraversano gli esseri umani. Oltrepassa il lavoro documentale e giornalistico, toglie la polvere dagli archivi, bussa sul cuore di Silvia Labayru e ci consegna un’opera di letteratura pura e siamo d’accordo col grande scrittore argentino Rodrigo Fresán quando afferma che Leila Guerriero «ha scritto il suo A sangue freddo, o piuttosto, A sangue caldo». E il paragone non appare per nulla esagerato.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/